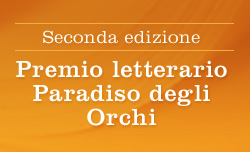CLASSICI
Alfredo Ronci
Non propriamente ozioso: “Libera nos a Malo” di Luigi Meneghello.
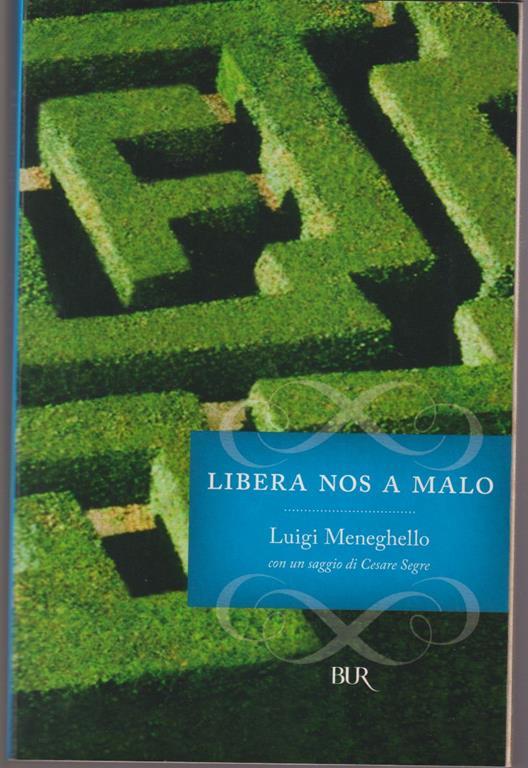
Leggiamo su Internet: “Espressione evangelica presente nella preghiera del Padre nostro nella versione latina della Vulgata”. Bene.
Luigi Meneghello ne approfitta per raccontarci, invece, la storia del suo paese, Malo, e della sua adolescenza, carica di significati.
Il libro esce nel 1963, anno significatissimo per la nostra letteratura. Bussa alla porta il romanzo che non è più romanzo, almeno, è un’altra cosa, ma resiste anche il romanzo classico, pur se alleggeritosi dagli impacci del neorealismo. E Libera nos a Malo cos’è? Dove si colloca?
Quando esce il romanzo tra le altre polemiche vi è quella dell’uso del dialetto. Avevamo già avuto precedenti significativi: nel 1954 esce La malora di Beppe Fenoglio; nel 1955 esce Ragazzi di vita di Pasolini; nel 1958 Il ponte della Ghisolfa di Testori; nel 1962 Il calzolaio di Vigevano di Mastronardi e per ultimo, ma solo perché fu scritto una decina di anni prima, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana di Gadda. Dove allora si colloca l’esordio di Meneghello?
Dice lo stesso nel romanzo: “… la parola del dialetto è sempre incavicchiata alla realtà, per la ragione che è la cosa stessa, appercepita prima che imparassimo a ragionare, e non più sfumata in seguito dato che ci hanno insegnato a ragionare in un’altra lingua. Questo vale soprattutto per i nome delle cose”.
Dunque sembrerebbe (ma forse il condizionale è un errore) che la letteratura imponga l’uso di due lingue, quella antica ed etica, e quella più propriamente commerciale. Come a dire che il romanzo di Meneghello va letto come un documento di anni ormai lontani (si parla a cominciare dagli anni venti) e soprattutto dell’infanzia dello scrittore. E in questo ci pare assolutamente certo che la posizione di Meneghello a proposito dell’uso del dialetto sia quello più vicino ai poeti che non ai romanzieri.
Dice ancora l’autore in una delle post-fazioni del libro: “Questo libro è scritto dall’interno di un mondo dove si parla una lingua che non si scrive; sono ragguagli di uno da Malo a quegli italiani che volessero sentirli; e sono scritti, per forza, in italiano. Non mi sono proposto però né di tradurre né di riprodurre il dialetto; invece ho trasportato dal dialetto alla lingua una forma e costrutto là dove mi pareva necessario, e sempre col criterio che questi miei “trasporti” nel loro contesto dovessero riuscire comprensibili al lettore italiano”.
Non è facile parlare del libro, meglio ancora, non è facile raccogliere un episodio significativo di esso, perché il bello del romanzo sta nella unicità del suo linguaggio (linguaggio che peraltro viene ampiamente spiegato nelle note in fondo al romanzo, anche se queste non facilmente intuibili).
Comunque qualcosa si riesce a trarre, solo per una questione di suggestione. Come per esempio quando il protagonista (cioè Meneghello) e un suo amico, stanno giocando con una cartina dell’Europa: “Io e bruno curvi sulla carta dell’Eugropa non ci rendevamo conto allora quanto vicini fossimo arrivati allo spirito e ai metodi della lotta politica e militare a cui più tardi assistemmo. Sotto sotto noi credevamo allora – pur non confessandolo – di giocare: invece per prendere la Francia e la Croazia, la Grecia e la Polonia si fa effettivamente così”.
A dire il vero abbiamo scelto il pezzo il meno intimo del romanzo. E s’intenda per intimo il più vicino all’ambientazione giovanile. Perché in Libera nos a Malo è un susseguirsi di eventi tipicamente infantili: la chiesa, il modo di fare messa, il prete, i giochi semplici e puerili, le prime bambine, le prime ragazze. Per ognuno si sceglie non solo il modo di raccontare, ma anche le anomalie da spiegare e renderle fruibili. E generazionale: “… e più volte vedendo i poveri mangiare ebbi lo shock di sentire una differenza che in seguito avrei potuto chiamare di classe. Il culmine del successo mondano per i nostri vecchi era quello: “Mangia bene””.
Libera nos a Malo dunque non è una lettura facile, anche se i temi potrebbero far parte di una libera trattazione sull’infanzia e sulla giovinezza (ma c’è anche altro). Rimane un tentativo piuttosto riuscito di frammentare la realtà e presentarci un’umanità seria che l’uso totale del dialetto avrebbe potuto rivisitarla totalmente. Se ci fosse stato un popolo a capirla.
L’edizione da noi considerata è:
Luigi Meneghello
Libera nos a Malo
Bur
Luigi Meneghello ne approfitta per raccontarci, invece, la storia del suo paese, Malo, e della sua adolescenza, carica di significati.
Il libro esce nel 1963, anno significatissimo per la nostra letteratura. Bussa alla porta il romanzo che non è più romanzo, almeno, è un’altra cosa, ma resiste anche il romanzo classico, pur se alleggeritosi dagli impacci del neorealismo. E Libera nos a Malo cos’è? Dove si colloca?
Quando esce il romanzo tra le altre polemiche vi è quella dell’uso del dialetto. Avevamo già avuto precedenti significativi: nel 1954 esce La malora di Beppe Fenoglio; nel 1955 esce Ragazzi di vita di Pasolini; nel 1958 Il ponte della Ghisolfa di Testori; nel 1962 Il calzolaio di Vigevano di Mastronardi e per ultimo, ma solo perché fu scritto una decina di anni prima, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana di Gadda. Dove allora si colloca l’esordio di Meneghello?
Dice lo stesso nel romanzo: “… la parola del dialetto è sempre incavicchiata alla realtà, per la ragione che è la cosa stessa, appercepita prima che imparassimo a ragionare, e non più sfumata in seguito dato che ci hanno insegnato a ragionare in un’altra lingua. Questo vale soprattutto per i nome delle cose”.
Dunque sembrerebbe (ma forse il condizionale è un errore) che la letteratura imponga l’uso di due lingue, quella antica ed etica, e quella più propriamente commerciale. Come a dire che il romanzo di Meneghello va letto come un documento di anni ormai lontani (si parla a cominciare dagli anni venti) e soprattutto dell’infanzia dello scrittore. E in questo ci pare assolutamente certo che la posizione di Meneghello a proposito dell’uso del dialetto sia quello più vicino ai poeti che non ai romanzieri.
Dice ancora l’autore in una delle post-fazioni del libro: “Questo libro è scritto dall’interno di un mondo dove si parla una lingua che non si scrive; sono ragguagli di uno da Malo a quegli italiani che volessero sentirli; e sono scritti, per forza, in italiano. Non mi sono proposto però né di tradurre né di riprodurre il dialetto; invece ho trasportato dal dialetto alla lingua una forma e costrutto là dove mi pareva necessario, e sempre col criterio che questi miei “trasporti” nel loro contesto dovessero riuscire comprensibili al lettore italiano”.
Non è facile parlare del libro, meglio ancora, non è facile raccogliere un episodio significativo di esso, perché il bello del romanzo sta nella unicità del suo linguaggio (linguaggio che peraltro viene ampiamente spiegato nelle note in fondo al romanzo, anche se queste non facilmente intuibili).
Comunque qualcosa si riesce a trarre, solo per una questione di suggestione. Come per esempio quando il protagonista (cioè Meneghello) e un suo amico, stanno giocando con una cartina dell’Europa: “Io e bruno curvi sulla carta dell’Eugropa non ci rendevamo conto allora quanto vicini fossimo arrivati allo spirito e ai metodi della lotta politica e militare a cui più tardi assistemmo. Sotto sotto noi credevamo allora – pur non confessandolo – di giocare: invece per prendere la Francia e la Croazia, la Grecia e la Polonia si fa effettivamente così”.
A dire il vero abbiamo scelto il pezzo il meno intimo del romanzo. E s’intenda per intimo il più vicino all’ambientazione giovanile. Perché in Libera nos a Malo è un susseguirsi di eventi tipicamente infantili: la chiesa, il modo di fare messa, il prete, i giochi semplici e puerili, le prime bambine, le prime ragazze. Per ognuno si sceglie non solo il modo di raccontare, ma anche le anomalie da spiegare e renderle fruibili. E generazionale: “… e più volte vedendo i poveri mangiare ebbi lo shock di sentire una differenza che in seguito avrei potuto chiamare di classe. Il culmine del successo mondano per i nostri vecchi era quello: “Mangia bene””.
Libera nos a Malo dunque non è una lettura facile, anche se i temi potrebbero far parte di una libera trattazione sull’infanzia e sulla giovinezza (ma c’è anche altro). Rimane un tentativo piuttosto riuscito di frammentare la realtà e presentarci un’umanità seria che l’uso totale del dialetto avrebbe potuto rivisitarla totalmente. Se ci fosse stato un popolo a capirla.
L’edizione da noi considerata è:
Luigi Meneghello
Libera nos a Malo
Bur
CERCA
NEWS
RECENSIONI
-
Laura Imani Messina
Le parole della pioggia
-
Maurizio de Giovanni
L’orologiaio di Brest
-
Matteo Auciello
Tecniche miste di trasformazione.
ATTUALITA'
-
Stefano Torossi
GEORGE ANTHEIL 1900 – 1959
-
Stefano Torossi
I FRATELLI MARCELLO. Benedetto Marcello 1686 – 1739 Alessandro Marcello 1673 – 1747
-
Stefano Torossi
Carl Maria von Weber 1786 - 1826
CLASSICI
-
Alfredo Ronci
Bisognerà trovare un motivo: “Gatteria” di Nino Savarese.
-
Massimo Grisafi
Roberto Bolaño "Un romanzetto lumpen"
-
Alfredo Ronci
Ma fu vero capolavoro? “Seminario sulla gioventù” di Aldo Busi.
CINEMA E MUSICA
-
Marco Minicangeli
The Dangers in My Heart
-
Lorenzo Lombardi/Marco Minicangeli
28 anni dopo – Il tempio delle ossa.
-
Marco Minicangeli
La mia famiglia a Taipei
RACCONTI
-
Pietro Poltronieri
Sumud Flotilla
-
Eugenio Flajani Galli
Ciro e il Miracolo di S. Gennaro
-
Massimo Grisafi
Dondola dondola