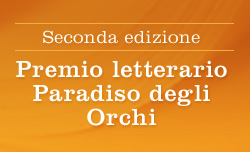RACCONTI
Massimiliano Città
St. Louis Blues

«St. Louis Blues»
You gotta pay the dues, if you wanna sing the blues
«La più grande cantante di blues del mondo
non smetterà mai di cantare.
Bessie Smith, 1894-1937»
[Epitaffio sulla lapide di Bessie Smith voluto da Janis Joplin]
Andavamo in giro per gli Stati. Erano viaggi infiniti e infinite storie. E voci dalle inflessioni cangianti, cullanti talvolta. Fino a quando qualcuno s’alzava dal letargo profondo dentro cui la povertà l’aveva cacciato e iniziava a bestemmiare, blaterando che dovevamo andarcene lontano da lui e dalla sua miseria, ché non aveva tempo da perdere mentre era in attesa della morte. Perché quello starnazzare che rimproverava a noi, a suo dire, allontanava la vecchia signora, e lui non poteva permetterselo, l’attendeva, da tempo immemore.
Andavamo in giro per gli Stati. Erano dolori infiniti e infinite gioie. Trasudavano nelle decine e decine di volti che villaggio dopo villaggio, campagna dopo campagna, città oltre città ci ritrovavamo di fronte. Erano volti tanto differenti da fondersi l’uno sull’altro fino a divenire ai nostri occhi familiari. Erano impronte modellate sulla polvere, cere accarezzate su corpi stanchi, erano simboli da riconoscere.
C’era sempre da incontrare qualche John, che a differenti latitudini pareva assumere ai nostri sguardi il medesimo sembiante, la medesima postura, perfino lo stesso abbigliamento. E Lisa, o Joanna, con l’identico vezzo nello stringere le labbra e portarsi la mano delicatamente sulla fronte a liberarla da quel ciuffo ribelle che non ne voleva sapere di rimanersene al suo posto.
Andavamo in giro per gli Stati.
Talvolta ci scambiavano per zingari in viaggio. Pochi bagagli stipati, sopra e sotto i nostri occhi spenti, leggermente aperti, nell’accenno di stanchezza. Con le palpebre a sostenerci in quella continua veglia della sera che sarebbe arrivata da lì a poco. Avevamo colori da mostrare oltre il nero che ci distingueva lungo la strada e poche parole da dire, ci bastava la musica.
Quando hai dentro un fiume in piena e il buon Dio t’ha dato in dono la possibilità di tirarlo fuori attraverso la musica non ti servono molte parole, se non per dire grazie, prego, un gin e poi un altro e un altro ancora, e no, stasera non mi va proprio di scopare, e roba del genere, niente di più.
Andavamo in giro per gli Stati. Erano viaggi infiniti e infinite noie.
C’era sempre un tutore del villaggio, o giù di lì, che aveva qualcosa da ridire su di noi. L’uomo ligio, timorato di Dio, con le sue mostrine in bella vista e un berretto che lo proiettava verso nuovi pianeti da scoprire.
Ritto sulle gambe tozze, braccia ferme e strette a sé, così da non perdere neppure un respiro dei suoi. Fisso a puntarci lo sguardo addosso come saetta divina, ultimo baluardo di una popolazione indifesa. Popolazione che proteggeva dal nostro tentativo di invasione, dalla lebbra che sicuramente nascondevamo sotto agli stracci, dalla droga che trasportavamo in ingenti quantità fin dentro le ossa, che ovviamente, a suo dire, usavamo come contenitori di distribuzione. Preservava la povera gente dall’anima del diavolo che scorreva viscidamente lungo le note delle nostre maledette melodie. E noi a sorridergli dietro, per quella tristezza che si portava addosso, senza averne consapevolezza.
Andavamo in giro per gli Stati.
Come piccole carovane multicolori e strombazzanti passavamo per i centri delle cittadine incitando la gente a uscirsene fuori dalle loro modeste abitazioni, in cui provavano a celare la modestia di esistenze venute al mondo spesso per caso.
I figli del caos camminavano a piedi scalzi e con lo sguardo incuriosito ci seguivano per un po’, poi distoglievano la loro vita, verso altro da imprecare.
Erano periodi in cui la miseria teneva unita la nazione. Miseria che sembrava piegarci le membra verso la polvere delle strade. Pochi vestiti ad addobbare molte anime in pena, senza un lavoro certo, senza una paga certa per far fronte a certi debiti, senza una vita certa per far fronte a certi peccati.
Andavamo in giro per gli Stati ed era un bel viaggiare.
Carovane di musicisti, mai sempre gli stessi.
C’era sempre qualcuno che abbandonava lungo il viaggio.
E dava il bel servito.
Magari, aveva in qualche ospedale sperduto del profondo sud la moglie sofferente di doglie e per tutto quello che avevano promesso davanti al Signore era giusto suddividere il dolore in parti uguali.
Magari, aveva ricevuto un’offerta migliore, una scrittura in qualche orchestra di rilievo, un vestito nuovo e qualcuno che ne rinnovasse il candore con un buon lavaggio.
Magari, aveva finito i soldi per la roba e senza non era nemmeno capace di dare un passo, figurarsi metter dietro un paio di note.
Magari, c’era qualcuno che aveva litigato con qualcun altro come sempre qualcuno fa e mandato a fanculo il resto e noi alla ricerca di un altro qualcuno per poter rimpiazzare quel qualcuno dell’inizio.
Magari, c’era chi, senza sapere come e perché, svaniva nel bel mezzo della notte, in avanscoperta, incontro alla sua anima. Lungo una via senza ritorno. E lo faceva così velocemente da lasciare quei pochi stracci appiccicati sulla pelle all’incuria della polvere, insieme alle lacrime di chi ne avrebbe avuto ancora memoria.
Magari, c’era il tipo bizzarro, tanto da volersene restare ostinatamente appeso ad un ramo, «perché da lì il mondo si vede meglio e si tiene a distanza il dolore», diceva. E noi ad insistere, a dirgli che s’era fatto tardi, e non era modo di perder tempo il suo, ma lui niente. Non voleva scrollarsi di dosso quella paranoia, o era la sbronza che continuava ad appesantire i suoi pensieri. Fatto sta che lo lasciavamo lì, sospeso, su quel ramo, fino a quando il ramo stesso sarebbe stato in grado di sopportare il peso di quell’anima bizzarra.
C’era sempre un tizio che abbandonava il viaggio.
Come se morisse in quel nostro cammino comune, lo avevamo battezzato il prossimo, chiunque esso fosse stato.
Il prossimo ci avrebbe lasciato, per questo lo amavamo di più come dice la scrittura, più di noi stessi. Sapevamo bene, ed io per prima, che mai avremmo abbandonato zia, il prossimo invece sì, se ne sarebbe di certo andato, in un certo momento per una strada certa.
Zia da parte sua non abbandonava mai nessuno.
Qualcuno la lasciò indietro, altri dissero che non era granché buona a far molto, altri l’adorarono per il resto della loro vita, pochi le negarono qualcosa, ma è noto che alla fine del suo viaggio non si ebbero i soldi per vergare una lapide col nome di battesimo, un nome breve, eppure così forte a pronunciarsi.
Ricordo che zia ne aveva storie da raccontare.
E mentre le narrava sorrideva con un fare malinconico. Si finiva sempre con l’ascoltarla quella donna, e dovevi startene zitto. Qualunque cosa si faceva non appena zia iniziava a raccontare tutti attorno si fermavano, come in un antico rituale.
Zitti ad ascoltare.
Sarebbero stai guai altrimenti.
«Ruby», mi diceva spesso, «tieni d’occhio la cottura di questo e quell’altro», mentre lei si agitava interpretando le vicende che tutti dovevano ascoltare in rigoroso silenzio.
D’altra parte la sua voce era incantevole, anche se non intonava i soliti blues e raccontava di tradimenti a go go, ed era un piacere tutto nuovo sentirla parlare. Alcuni arrivavano addirittura a pensare che parlasse cantando, pertanto erano i più meravigliati quando la sentivano raccontare, senza musica intorno.
Bastava lei. Il suo strumento, la sua orchestrina, la sua voce.
Certo è che quando si ritrovava sul palco, con quelle strambe posture e le perline luccicanti a scivolare su copricapi improbabili e acconciature nascoste da fazzoletti stretti sulle tempie, quasi fosse una mammy d’altri tempi, be’, quello sì che era puro spettacolo.
Un altro spettacolo.
Venivano da ogni parte, non solo per lei questo è certo, almeno all’inizio. Non sarebbe giusto affermarlo, dire che tutti giungevano per assistere alla performance di Bessie, ma col tempo non c’era molto da dire in contrario. Chi si ritrovava al suo cospetto sapeva d’essere lì, per lei. Pronto ad ascoltarla, senza grilli per la testa, né altri pensieri. Non c’era voglia di fare null’altro, fuorché ascoltarla.
Soltanto l’idea di sentire quello che aveva da cantare, da raccontare con la sua voce.
Già, la sua voce.
Non una semplice, comune voce umana, femminile, ma qualcosa d’altro, difficile da definirsi.
La voce di zia Bessie pareva essere l’insieme di tante voci. Fuse una sull’altra, come per quei volti che incontravamo lungo il viaggio e parevano ritrovarsi in un unico sguardo.
Zia Bessie tratteneva in sé l’accento di migliaia di voci comuni, che a partire dalle sue labbra divenivano un qualcosa di speciale, così carico di bellezza da non potersi sopportare.
Le voci di un’intera generazione accomunata dal sudore che sapeva ben riconoscere sui campi di cotone, una voce che diceva di quel sudore più di tanti resoconti di costume afroamericano che si vedono spesso in giro. Una voce che parlava di razze differenti, da mettere una di fronte all’altra per evidenziarne il diverso colore, una voce che superava gli zigomi pronunciati, le labbra ispessite dalla fame, la muscolatura nervosa, il culo dei neri, che a muso duro venivano puntualmente sbattuti fuori.
Da qualsiasi luogo.
Lei era quella voce e molto di più.
Per questo motivo giungevano da ogni parte ad ascoltarla.
Per questo motivo sembrava di ritrovarla ovunque per la strada.
Come se un’eco luminosa indicasse la via per arrivare a lei.
Zia Bessie era solita dire:
«Devi provare a pagare i tuoi debiti se vuoi davvero cantare blues amico mio. Così dicevano dalle mie parti, sai. Devi avere un’anima certo, devi sentirla quell’anima, dentro, nel profondo. Ma un’anima semplice non basta, sai. Se hai un’anima e null’altro non puoi cantarne di blues. Per quanta voce tu creda di tenere in corpo non uscirà che uno spiffero di fiato, floscio. Moscio. Bisogna aver peccato per potersi dire cantante di blues. Non è un fatto di fede, ma di vita vecchio mio. Il peccato, la presunzione di aver lasciato tracce di sé dietro le spalle, tracce dolorose, solchi che la gente ha ben presente e può ponderare a distanza di tempo. C’è musica e musica. Musica che ti scivola addosso come rugiada, musica che ti solletica, magari ti fa stare anche allegra per un quarto d’ora e giù di lì, come una scopata ben riuscita. Forse. Io non chiedo di cantare quella musica. Né voglio ascoltarla. Io chiedo di fare l’amore con la mia musica, avvertire qualcosa che vada oltre il momento, l’istante di un orgasmo ben riuscito e quella sensazione trattengo tra le labbra. Che sia ricordo o nome non m’importa molto, resto consapevole di dare un volto ad un passato che so di certo non ritornerà. Io voglio parlarci con la mia musica. Dopo. Ogni volta, pur sapendo che sarò spossata e stanca. Questo è il mio blues. Il blues ti deve lacerare la pelle, le ossa, la fica se ce l’hai. Vecchio mio non puoi mica capire, lo so bene. Considera che se tu non avessi mai sentito nulla nelle tue viscere, nel profondo, là sotto dico, dove hai provato a sentirti forte, ecco, senza niente di quelle sensazioni che tua madre avrà di certo rimproverato in qualche occasione, non avresti mai potuto cantare del blues. Del resto non so neppure se tu l’abbia mai cantato».
Questo, si racconta, diceva zia Bessie a chi le domandava cos’era la musica che portava con sé.
Zia non si curò affatto delle cose quotidiane in fondo, viveva sulle note del suo dolore, come fosse in una continua trance, e in quel dolore s’è spenta.
In un insopportabile silenzio.
You gotta pay the dues, if you wanna sing the blues
«La più grande cantante di blues del mondo
non smetterà mai di cantare.
Bessie Smith, 1894-1937»
[Epitaffio sulla lapide di Bessie Smith voluto da Janis Joplin]
Andavamo in giro per gli Stati. Erano viaggi infiniti e infinite storie. E voci dalle inflessioni cangianti, cullanti talvolta. Fino a quando qualcuno s’alzava dal letargo profondo dentro cui la povertà l’aveva cacciato e iniziava a bestemmiare, blaterando che dovevamo andarcene lontano da lui e dalla sua miseria, ché non aveva tempo da perdere mentre era in attesa della morte. Perché quello starnazzare che rimproverava a noi, a suo dire, allontanava la vecchia signora, e lui non poteva permetterselo, l’attendeva, da tempo immemore.
Andavamo in giro per gli Stati. Erano dolori infiniti e infinite gioie. Trasudavano nelle decine e decine di volti che villaggio dopo villaggio, campagna dopo campagna, città oltre città ci ritrovavamo di fronte. Erano volti tanto differenti da fondersi l’uno sull’altro fino a divenire ai nostri occhi familiari. Erano impronte modellate sulla polvere, cere accarezzate su corpi stanchi, erano simboli da riconoscere.
C’era sempre da incontrare qualche John, che a differenti latitudini pareva assumere ai nostri sguardi il medesimo sembiante, la medesima postura, perfino lo stesso abbigliamento. E Lisa, o Joanna, con l’identico vezzo nello stringere le labbra e portarsi la mano delicatamente sulla fronte a liberarla da quel ciuffo ribelle che non ne voleva sapere di rimanersene al suo posto.
Andavamo in giro per gli Stati.
Talvolta ci scambiavano per zingari in viaggio. Pochi bagagli stipati, sopra e sotto i nostri occhi spenti, leggermente aperti, nell’accenno di stanchezza. Con le palpebre a sostenerci in quella continua veglia della sera che sarebbe arrivata da lì a poco. Avevamo colori da mostrare oltre il nero che ci distingueva lungo la strada e poche parole da dire, ci bastava la musica.
Quando hai dentro un fiume in piena e il buon Dio t’ha dato in dono la possibilità di tirarlo fuori attraverso la musica non ti servono molte parole, se non per dire grazie, prego, un gin e poi un altro e un altro ancora, e no, stasera non mi va proprio di scopare, e roba del genere, niente di più.
Andavamo in giro per gli Stati. Erano viaggi infiniti e infinite noie.
C’era sempre un tutore del villaggio, o giù di lì, che aveva qualcosa da ridire su di noi. L’uomo ligio, timorato di Dio, con le sue mostrine in bella vista e un berretto che lo proiettava verso nuovi pianeti da scoprire.
Ritto sulle gambe tozze, braccia ferme e strette a sé, così da non perdere neppure un respiro dei suoi. Fisso a puntarci lo sguardo addosso come saetta divina, ultimo baluardo di una popolazione indifesa. Popolazione che proteggeva dal nostro tentativo di invasione, dalla lebbra che sicuramente nascondevamo sotto agli stracci, dalla droga che trasportavamo in ingenti quantità fin dentro le ossa, che ovviamente, a suo dire, usavamo come contenitori di distribuzione. Preservava la povera gente dall’anima del diavolo che scorreva viscidamente lungo le note delle nostre maledette melodie. E noi a sorridergli dietro, per quella tristezza che si portava addosso, senza averne consapevolezza.
Andavamo in giro per gli Stati.
Come piccole carovane multicolori e strombazzanti passavamo per i centri delle cittadine incitando la gente a uscirsene fuori dalle loro modeste abitazioni, in cui provavano a celare la modestia di esistenze venute al mondo spesso per caso.
I figli del caos camminavano a piedi scalzi e con lo sguardo incuriosito ci seguivano per un po’, poi distoglievano la loro vita, verso altro da imprecare.
Erano periodi in cui la miseria teneva unita la nazione. Miseria che sembrava piegarci le membra verso la polvere delle strade. Pochi vestiti ad addobbare molte anime in pena, senza un lavoro certo, senza una paga certa per far fronte a certi debiti, senza una vita certa per far fronte a certi peccati.
Andavamo in giro per gli Stati ed era un bel viaggiare.
Carovane di musicisti, mai sempre gli stessi.
C’era sempre qualcuno che abbandonava lungo il viaggio.
E dava il bel servito.
Magari, aveva in qualche ospedale sperduto del profondo sud la moglie sofferente di doglie e per tutto quello che avevano promesso davanti al Signore era giusto suddividere il dolore in parti uguali.
Magari, aveva ricevuto un’offerta migliore, una scrittura in qualche orchestra di rilievo, un vestito nuovo e qualcuno che ne rinnovasse il candore con un buon lavaggio.
Magari, aveva finito i soldi per la roba e senza non era nemmeno capace di dare un passo, figurarsi metter dietro un paio di note.
Magari, c’era qualcuno che aveva litigato con qualcun altro come sempre qualcuno fa e mandato a fanculo il resto e noi alla ricerca di un altro qualcuno per poter rimpiazzare quel qualcuno dell’inizio.
Magari, c’era chi, senza sapere come e perché, svaniva nel bel mezzo della notte, in avanscoperta, incontro alla sua anima. Lungo una via senza ritorno. E lo faceva così velocemente da lasciare quei pochi stracci appiccicati sulla pelle all’incuria della polvere, insieme alle lacrime di chi ne avrebbe avuto ancora memoria.
Magari, c’era il tipo bizzarro, tanto da volersene restare ostinatamente appeso ad un ramo, «perché da lì il mondo si vede meglio e si tiene a distanza il dolore», diceva. E noi ad insistere, a dirgli che s’era fatto tardi, e non era modo di perder tempo il suo, ma lui niente. Non voleva scrollarsi di dosso quella paranoia, o era la sbronza che continuava ad appesantire i suoi pensieri. Fatto sta che lo lasciavamo lì, sospeso, su quel ramo, fino a quando il ramo stesso sarebbe stato in grado di sopportare il peso di quell’anima bizzarra.
C’era sempre un tizio che abbandonava il viaggio.
Come se morisse in quel nostro cammino comune, lo avevamo battezzato il prossimo, chiunque esso fosse stato.
Il prossimo ci avrebbe lasciato, per questo lo amavamo di più come dice la scrittura, più di noi stessi. Sapevamo bene, ed io per prima, che mai avremmo abbandonato zia, il prossimo invece sì, se ne sarebbe di certo andato, in un certo momento per una strada certa.
Zia da parte sua non abbandonava mai nessuno.
Qualcuno la lasciò indietro, altri dissero che non era granché buona a far molto, altri l’adorarono per il resto della loro vita, pochi le negarono qualcosa, ma è noto che alla fine del suo viaggio non si ebbero i soldi per vergare una lapide col nome di battesimo, un nome breve, eppure così forte a pronunciarsi.
Ricordo che zia ne aveva storie da raccontare.
E mentre le narrava sorrideva con un fare malinconico. Si finiva sempre con l’ascoltarla quella donna, e dovevi startene zitto. Qualunque cosa si faceva non appena zia iniziava a raccontare tutti attorno si fermavano, come in un antico rituale.
Zitti ad ascoltare.
Sarebbero stai guai altrimenti.
«Ruby», mi diceva spesso, «tieni d’occhio la cottura di questo e quell’altro», mentre lei si agitava interpretando le vicende che tutti dovevano ascoltare in rigoroso silenzio.
D’altra parte la sua voce era incantevole, anche se non intonava i soliti blues e raccontava di tradimenti a go go, ed era un piacere tutto nuovo sentirla parlare. Alcuni arrivavano addirittura a pensare che parlasse cantando, pertanto erano i più meravigliati quando la sentivano raccontare, senza musica intorno.
Bastava lei. Il suo strumento, la sua orchestrina, la sua voce.
Certo è che quando si ritrovava sul palco, con quelle strambe posture e le perline luccicanti a scivolare su copricapi improbabili e acconciature nascoste da fazzoletti stretti sulle tempie, quasi fosse una mammy d’altri tempi, be’, quello sì che era puro spettacolo.
Un altro spettacolo.
Venivano da ogni parte, non solo per lei questo è certo, almeno all’inizio. Non sarebbe giusto affermarlo, dire che tutti giungevano per assistere alla performance di Bessie, ma col tempo non c’era molto da dire in contrario. Chi si ritrovava al suo cospetto sapeva d’essere lì, per lei. Pronto ad ascoltarla, senza grilli per la testa, né altri pensieri. Non c’era voglia di fare null’altro, fuorché ascoltarla.
Soltanto l’idea di sentire quello che aveva da cantare, da raccontare con la sua voce.
Già, la sua voce.
Non una semplice, comune voce umana, femminile, ma qualcosa d’altro, difficile da definirsi.
La voce di zia Bessie pareva essere l’insieme di tante voci. Fuse una sull’altra, come per quei volti che incontravamo lungo il viaggio e parevano ritrovarsi in un unico sguardo.
Zia Bessie tratteneva in sé l’accento di migliaia di voci comuni, che a partire dalle sue labbra divenivano un qualcosa di speciale, così carico di bellezza da non potersi sopportare.
Le voci di un’intera generazione accomunata dal sudore che sapeva ben riconoscere sui campi di cotone, una voce che diceva di quel sudore più di tanti resoconti di costume afroamericano che si vedono spesso in giro. Una voce che parlava di razze differenti, da mettere una di fronte all’altra per evidenziarne il diverso colore, una voce che superava gli zigomi pronunciati, le labbra ispessite dalla fame, la muscolatura nervosa, il culo dei neri, che a muso duro venivano puntualmente sbattuti fuori.
Da qualsiasi luogo.
Lei era quella voce e molto di più.
Per questo motivo giungevano da ogni parte ad ascoltarla.
Per questo motivo sembrava di ritrovarla ovunque per la strada.
Come se un’eco luminosa indicasse la via per arrivare a lei.
Zia Bessie era solita dire:
«Devi provare a pagare i tuoi debiti se vuoi davvero cantare blues amico mio. Così dicevano dalle mie parti, sai. Devi avere un’anima certo, devi sentirla quell’anima, dentro, nel profondo. Ma un’anima semplice non basta, sai. Se hai un’anima e null’altro non puoi cantarne di blues. Per quanta voce tu creda di tenere in corpo non uscirà che uno spiffero di fiato, floscio. Moscio. Bisogna aver peccato per potersi dire cantante di blues. Non è un fatto di fede, ma di vita vecchio mio. Il peccato, la presunzione di aver lasciato tracce di sé dietro le spalle, tracce dolorose, solchi che la gente ha ben presente e può ponderare a distanza di tempo. C’è musica e musica. Musica che ti scivola addosso come rugiada, musica che ti solletica, magari ti fa stare anche allegra per un quarto d’ora e giù di lì, come una scopata ben riuscita. Forse. Io non chiedo di cantare quella musica. Né voglio ascoltarla. Io chiedo di fare l’amore con la mia musica, avvertire qualcosa che vada oltre il momento, l’istante di un orgasmo ben riuscito e quella sensazione trattengo tra le labbra. Che sia ricordo o nome non m’importa molto, resto consapevole di dare un volto ad un passato che so di certo non ritornerà. Io voglio parlarci con la mia musica. Dopo. Ogni volta, pur sapendo che sarò spossata e stanca. Questo è il mio blues. Il blues ti deve lacerare la pelle, le ossa, la fica se ce l’hai. Vecchio mio non puoi mica capire, lo so bene. Considera che se tu non avessi mai sentito nulla nelle tue viscere, nel profondo, là sotto dico, dove hai provato a sentirti forte, ecco, senza niente di quelle sensazioni che tua madre avrà di certo rimproverato in qualche occasione, non avresti mai potuto cantare del blues. Del resto non so neppure se tu l’abbia mai cantato».
Questo, si racconta, diceva zia Bessie a chi le domandava cos’era la musica che portava con sé.
Zia non si curò affatto delle cose quotidiane in fondo, viveva sulle note del suo dolore, come fosse in una continua trance, e in quel dolore s’è spenta.
In un insopportabile silenzio.
CERCA
NEWS
-
22.02.2026
Nutrimenti
Antonio Moresco - Il finimondo -
22.02.2026
Sellerio
Dario Ferrari - L'idiota di famiglia -
22.02.2026
Adelphi
Henry James - Ormai non poteva succedere più nulla - Taccuini.
RECENSIONI
-
William Sloane
La porta dell’alba
-
Laura Imani Messina
Le parole della pioggia
-
Maurizio de Giovanni
L’orologiaio di Brest
ATTUALITA'
-
Stefano Torossi
Giovanni Bottesini 1821 - 1889
-
Stefano Torossi
GEORGE ANTHEIL 1900 – 1959
-
Stefano Torossi
I FRATELLI MARCELLO. Benedetto Marcello 1686 – 1739 Alessandro Marcello 1673 – 1747
CLASSICI
CINEMA E MUSICA
-
Marco Minicangeli
The Dangers in My Heart
-
Lorenzo Lombardi/Marco Minicangeli
28 anni dopo – Il tempio delle ossa.
-
Marco Minicangeli
La mia famiglia a Taipei
RACCONTI
-
Dauphine Potter
Summer, estate, summer summer.
-
Pietro Poltronieri
Sumud Flotilla
-
Eugenio Flajani Galli
Ciro e il Miracolo di S. Gennaro