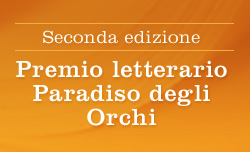RACCONTI
Antonio Caranas
Stanchezza

La donna scostò la tendina della finestra, guardò in alto poi in basso, c’erano ancora pozzanghere per la strada, ma doveva uscire. Per forza, non aveva più niente nella credenza e nel frigo. Per una settimana obbligata a casa da una malattia virale, non le era rimasta che una scatoletta di carne.
Vedova da un anno, sola, i figli accasati in tre città diverse, viveva senza ambasce e senza entusiasmi: in pensione dopo trentotto anni di servizio presso la biblioteca comunale prima come semplice impiegata e poi come direttrice. La momentanea malattia l’aveva debilitata; ma più che la stanchezza fisica era la stanchezza mentale che la fiaccava: quella stanchezza dell’intelligenza che tiene dietro alla disfatta di progetti e speranze e fa lievitare il senso profondo della vacuità delle cose.
Non aveva ancora organizzato la sua nuova vita. Le sue amiche, ma più che amiche erano conoscenti, se la spassavano: chi dedita ai nipoti, chi indaffarata a preparare viaggi in comitiva per i pensionati, per quelli che se lo potevano permettere, chi impegnata nel volontariato in parrocchia. Non era, lo ammetteva, una filantropa, non aveva nipoti cui attaccarsi, non amava viaggiare. Non le piaceva quella vita ma non faceva niente per diversificarla. Non aveva attese. Dai figli non ci andava perché le nuore le avevano fatto chiaramente capire che non gradivano la sua presenza: la consideravano superba, distante. E lei ricambiava non nascondendo la propria insofferenza per loro e per coloro, come le sue amiche, severe assertrici delle tre virtù teologali. Mentre lei non aveva fede in niente, scacciava la speranza, rifuggiva la carità. Consunto anche il rapporto coi libri che è di conforto dell’intelletto.
Pensò al marito. “Oggi, dieci aprile, ricorreva il tuo onomastico, Aldo, e l’anniversario del nostro matrimonio: avremmo fatto trentacinque anni insieme”, sospirò scostando la fronte dal vetro della finestra. Poi sul vetro appannato dal suo alito scrisse: “Assurdo”.
La loro luna di miele, a Capri. Era il posto più bello del creato con quei panorami suggestivi e le caratteristiche naturali e culturali uniche al mondo, si entusiasmava lo sposo. Il mattino seguente davanti alla finestra spalancata – lui era nel bagno – osservava i faraglioni e il mare turchino senza vederli e sentiva gli stridi dei gabbiani senza ascoltarli, le lacrime gli velarono il panorama e subito le deterse perché avvertì la presenza di lui dietro le spalle. La cinse con un braccio e parlò dei poeti e degli artisti che venivano da ogni parte del mondo in questo lembo di Paradiso; e la baciò romanticamente. Al ricordo, un tremore errò sulle sue labbra e si dolse sin nel profondo.
Non l’aveva amato, gli aveva voluto bene, questo sì, come se ne può volere a un vicino di casa sempre gentile e disponibile. E per via che lui l’amava di un amore assoluto lei gli fu sempre riconoscente. Mai un litigio.
Mio caro, tu, che hai portato a spasso la tua vita con decoro e gentilezza, confessami: sapevi che io, la tua Vita di nome e di fatto, come amavi ripetermi fino alla noia, non ho mai sentito un briciolo di passione per te? Ah, la vita, tu l’hai vissuta certo meglio di me, avvitato com’eri alla mia, al tuo amore per me senza fine. Guardavi sfiorire i fiori sul terrazzo e mi dicevi: “La tua bellezza non sfiorirà mai”. Io nascondevo la mia indifferenza dietro un sorriso, e Dio solo sa quanto esso era amaro. Sai quando ho sentito qualcosa (pietà?) per te? L’ultimo anno della tua vita. Soffrivi, e la mia presenza leniva la tua sofferenza. Era l’inizio d’autunno e tu avevi espresso il desiderio di tornare a Capri. Albergo a cinque stelle con ampia terrazza agghindata di piante e fiori con vista meravigliosa. Una luce senza sorriso sfrangiava di giallo morto le nuvole del tramonto e tu con la coscienza della fine prossima sorridevi sempre per il solo fatto che ti ero accanto ed eri arcicontento di morire prima di me. Il tuo Amore per me – lo scrivevi con la A maiuscola nelle lettere che mi spedivi quando eri fuori per lavoro – “una fiamma divina che le grandi acque non riescono a spegnere né i fiumi a travolgere”, citavi la Bibbia. Tu sei stato fortunatissimo, amico mio! Quella fiamma divina è arsa in te dal giorno in cui mi hai conosciuto sino agli ultimi attimi della tua vita. In me è arsa per brevissimi e lontanissimi momenti e non per te. Lo so, la più grande pena per te era che tu mi sopravvivessi. M’immagino il dolore di veder allontanarsi per sempre chi hai amato di amore grande! Non era il mio caso e mi ritenevo fortunata. Ma anche tu sei stato fortunato, no? Non mi hai visto crepare, forse saresti crepato con me, come il cane che si lascia morire insieme col padrone. Io sono stato il tuo padrone, ma non te l’ho chiesto io di esserlo, eri tu felice di essere schiavo d’amore… Negli ultimi mesi mi hai ripetuto fino alla noia i versi che ricordo a memoria e non so se erano tuoi o di chi, e, ti confesso, la commozione ora mi prende: “La morte non è niente. / Sarò solamente passato dall’altra parte / è come fossi nascosto nella stanza accanto / non sarò lontano, sarò dietro l’angolo / come quando giocavo a nascondino con i bambini. / Il tuo sorriso è stato la mia pace quaggiù / sarà la mia pace lassù”.
Ora il mio cervello funziona per inerzia e niente mi salva da me stessa; vorrei dormire, dormire un sonno ignaro d’angoscia, lungo lunghissimo e poi svegliarmi un giorno, un giorno d’aprile ma non come questo, un giorno d’aprile delicato di sole al tramonto… o di sera alla luce generosa della luna nel vico sotto la finestra della mia vecchia casa accanto al cadavere della mia felicità ferita a morte da una schioppettata di mio padre che mise in fuga per sempre il mio Romeo. Ah Romeo Romeo… Mi sa che è il mio senno che sta fuggendo sulla luna e non ho un amico fatato come Astolfo che vada a recuperarmelo lassù – le capitava spesso di associare reminiscenze letterarie ai suoi ricordi o stati d’animo, e sorrise –. Ah, a scapparsene per sempre il senno! Così non penserei a nulla, non aspetterei il Nulla… chi vive come me non c’è bisogno che muoia.
Era ancora davanti alla finestra – di casa o a Capri? – Quel mare da azzurro e placido si fece agitato e marrone, nere nuvolaglie abbassarono il cielo, strani stridi quelli dei gabbiani quasi metallici come un suono proveniente da estreme lontananze e quando capì che era il telefono andò per rispondere ma il telefono smise di squillare. Pensò a qualcuno dei figli – solo a loro? – Meccanicamente prese dalla tasca della vestaglia un kleenex, si asciugò le guance umide. Andò al bagno, si lavò e mentre si aggiustava davanti allo specchio si rivide in un altro specchio, lontanissimo nello spazio e nel tempo, rimirarsi nella sua magnifica selvatichezza: a quelle due parole pronunciate ad alta voce apparve dal buio sotterraneo della memoria, dove l’aveva inabissato, l’altro. Si scosse e andò nella stanza da letto, si vestì lentamente e mentre si vestiva cadenzò le parole: “Non c’è nostalgia più dolorosa di quella delle cose che non sono mai state”. Come ogni forte lettore non ricordò precisamente di chi fossero. Forse di Pessoa.
Uscì nel primo pomeriggio. Il cielo accennava una schiarita a ponente ma a levante era cupo: non un giorno di cielo tutto azzurro in questo aprile, pensò. E guardando quel grande pezzo di cielo lucido simile a un lago montano rivide l’infanzia dei figli che durante la villeggiatura volevano andare ogni giorno al lago, e s’immerse nei loro ricordi bambini, assecondando, come spesso faceva, quell’inganno dolcedolente; e ora adulti e lontani ebbe una fitta al cuore.
Non sentendo più i suoi passi si percepì come un’ombra. Si guardò intorno, rallentò il passo, si fermò. Non avvertiva i rumori della vita circostante, tutto si era trasformato in penombra e capì che sì, tutto era finito. Al crepitare di un motorino ebbe un lieve soprassalto, uscì dalla penombra e riprese a camminare e avvertì un’inutile quiete scenderle nel profondo. Vagò per le viuzze della città vecchia, dove dormì il sonno di bambina fino alla vigilia della giovinezza. S’imbatté in qualche conoscenza scambiando parole vacue. Al chiosco consumò una spremuta d’arancia: provò un senso di tenerezza per il gestore – non ricordava come da Napoli era finito lì – più vecchio dei suoi anni, un tempo giovane e impertinente quando d’estate le offriva il gelato sussurrandole che voleva essere un gelato per entrare dentro di lei. Le ricordò il suo gusto preferito. Lei gli sorrise. Uscì dalla città vecchia. Passò dall’edicola e comprò un quotidiano nazionale e il periodico locale. Si diresse alla villa comunale. Raggiunse con un po’ d’affanno il solito posto, là in alto. Sedette sulla panchina di legno sotto la robinia. Diede una scorsa al periodico e durante la lettura del quotidiano si appisolò.
Su, vieni, avvicinati, è inutile che nascondi la falce dietro la schiena e ti presenti con quel sorriso triste come a volerti scusare. Guarda laggiù in fondo il giorno che se ne va: anch’esso ha il sorriso triste del tramonto. Non ti pare? Ma non può che cedere alla notte, morire per risorgere domani. Brava, così mi piaci, accomodati, metti da parte la falce, riposa un poco, dammi retta, dormi un poco, deponi la falce, no, non te la nascondo, mi credi così coraggiosa? intelligenza sì, ma quanto a coraggio… Se ne avessi avuto non sarei qui ora a chiederti di addormentarti vicino a me prima di… E se ti addormentassi e non ti svegliassi più? Dico sciocchezze? Lo so lo so, ne ho dette tante, e anche fatte, s’intende… ma una imperdonabile. E risentì come un’eco lontana la melodia della giovinezza al dolorante arpeggio della chitarra nel vico cieco della Fossa dei Ciucci e si aggrappò al ricordo: rivide il sorriso di lui triste da ventenne alla luce bianca della luna allontanarsi lentamente nonostante le due schioppettate di suo padre dalla finestra di casa. Pum pum… avrei voluto corrergli dietro ma due manrovesci di mio padre mi inchiodarono alla sedia. Mai più ho rivisto un sorriso come il suo, o forse non l'ho cercato e mi diedi a cercare me stessa senza incontrarmi mai. Tutto quello che ho avuto sono stati brandelli di luce riflessa dai figli quando erano piccoli. In seguito frammenti di falsa vita… Ho un compagno da tanto tempo che mi sta dietro dietro, anzi avanti avanti, anzi dentro dentro e mi trascina in questa vita-non vita. Non riposa e non dorme mai, come te. Tutto muore in me da quando è padrone di me, con la sua fredda mano mi stringe le tempie e me le fa scoppiare e per il dolore erompe dentro di me un pianto acuto come quello delle prefiche durante la pausa delle orazioni. A questo punto sei preferibile tu a lui, per questo ti ho chiamato. Ma ora dormi un poco anche tu e sogna per una volta la vita. Al risveglio mi darai il tuo bacio e anch’io entrerò con un sorriso triste nella notte del tempo senza tempo. Brava, vedo che ti stai addormentando… Ma che urli così disperata! Ti eri appena appisolata. Che hai sognato di tanto orribile? Hai avuto un incubo forse? Me lo vuoi dire per favore? Ah, ma io lo so. Nel tuo fulmineo sonno hai avuto un incubo: la vita.
Sobbalzò al poderoso mugghio dello smisurato bastimento ancorato nel porto e pensò alle sue amiche patite di crociere, e alla loro vaghezza culturale. Lei, a differenza di loro, aveva viaggiato una vita sempre sulla stessa nave; una nave particolare, taciturna e pensosa, stracolma di uomini e donne di lingue diverse: tutti ordinati e allineati, ognuno al proprio posto da lei assegnato sugli scaffali. E dal diuturno colloquio con loro aveva conosciuto le meraviglie e gli orrori degli uomini. Un merlo zinziò saltellando da un ramo all’altro, lei cercò goffamente di imitarne il verso con un leggero sorriso che si mutò in una smorfia d’indignazione pensando a un balordo cacciatore. “Deficiente – inveì mentalmente – se spari a un merlo credi tu che il suo canto cesserà per sempre? Il suo canto stormiva già prima di Budda, Cristo e Maometto e continuerà a echeggiare anche molto dopo che le loro parole saranno cadute nell’oblio perché quello del merlo, dell’usignolo, della cinciallegra, del cardellino, dell'allodola, non è un sermone, un’ammonizione, un comandamento, è solo canto. E in principio non ‘era la parola’ ma il canto di un uccello”.
Una volta in pensione non vi aveva messo più piede in biblioteca. Anzi vi era andata una volta dopo circa un anno, e quegli scaffali che lei aveva nutrito, allevato e protetto, erano coperti, le parve, di sonno e di polvere.
Nei primi tempi quando era solo impiegata la sala di lettura era affollata di “studiosi” giovani che le sbirciavano le cosce ogni volta che saliva sulla scala a pioli per prendere i libri dagli scaffali più alti. Ricordò che allora le donne non usavano portare i pantaloni e le gonne erano per giunta corte. Non poteva, ora, escludere che ci prendesse gusto in quel saliscendi conturbante. Aveva venti-ventidue anni ed era molto bella. Sorrise.
Era ancora bella e aveva una schiera di corteggiatori, anche under 60. Quelli più accesi dicevano che era di una bellezza regale. Il suo portamento eretto e lo sguardo elevato potevano presumere una certa superbia, ma non era superbia: era come se guardasse la propria esistenza dall’alto senza indulgenza. I capelli, non tinti, tendenti al grigio parevano vezzeggiati da mèches; il viso rivelava accoramento misto alla dolcezza dell’intelligenza – non del cuore – e per questo appariva austeramente bello.
Si alzò dalla panchina e si avvicinò alla balaustrata. Il sole era a picco sull’orizzonte frangiato da nuvolette chiare mentre una nube grande e cinerina avanzava minacciosa verso la linea del tramonto. Poggiò i gomiti sulla cimasa, le mani a pugno sotto il mento, lo sguardo fisso: il mare verde, il molo, la lunga fila di tigli sul lungomare, ma non li vedeva. Ebbe compassione di sé, della sua vita. Mentalmente, dall’alto in basso misurò i metri ed ebbe un fremito di paura e poi rabbrividì tutta perché sentì il freddo della vita. Si fissò nella visione del tramonto: la grande nuvola coprì totalmente il sole, lui la decorò di rosa e, acquattato dietro quel fondale, non riapparve più mentre gli ultimi scorci d’azzurro sfumavano nel grigio. Rientrò in sé, nella riserva del suo azzurro interiore.
I passi, lenti, invece di riportarla a casa, la portarono sul molo. Rigattieri e persone sfaccendate vociavano in attesa delle paranze. Più lontano, coppie di innamorati, sedute sui frangiflutti, aspettavano l’oscurità. Si portò ai bordi della banchina del molo: l’acqua, benché alta, era stagnante, istoriata da larghe macchie luccicanti di nafta. Si afferrò ai lembi del giorno in fuga.
Vedova da un anno, sola, i figli accasati in tre città diverse, viveva senza ambasce e senza entusiasmi: in pensione dopo trentotto anni di servizio presso la biblioteca comunale prima come semplice impiegata e poi come direttrice. La momentanea malattia l’aveva debilitata; ma più che la stanchezza fisica era la stanchezza mentale che la fiaccava: quella stanchezza dell’intelligenza che tiene dietro alla disfatta di progetti e speranze e fa lievitare il senso profondo della vacuità delle cose.
Non aveva ancora organizzato la sua nuova vita. Le sue amiche, ma più che amiche erano conoscenti, se la spassavano: chi dedita ai nipoti, chi indaffarata a preparare viaggi in comitiva per i pensionati, per quelli che se lo potevano permettere, chi impegnata nel volontariato in parrocchia. Non era, lo ammetteva, una filantropa, non aveva nipoti cui attaccarsi, non amava viaggiare. Non le piaceva quella vita ma non faceva niente per diversificarla. Non aveva attese. Dai figli non ci andava perché le nuore le avevano fatto chiaramente capire che non gradivano la sua presenza: la consideravano superba, distante. E lei ricambiava non nascondendo la propria insofferenza per loro e per coloro, come le sue amiche, severe assertrici delle tre virtù teologali. Mentre lei non aveva fede in niente, scacciava la speranza, rifuggiva la carità. Consunto anche il rapporto coi libri che è di conforto dell’intelletto.
Pensò al marito. “Oggi, dieci aprile, ricorreva il tuo onomastico, Aldo, e l’anniversario del nostro matrimonio: avremmo fatto trentacinque anni insieme”, sospirò scostando la fronte dal vetro della finestra. Poi sul vetro appannato dal suo alito scrisse: “Assurdo”.
La loro luna di miele, a Capri. Era il posto più bello del creato con quei panorami suggestivi e le caratteristiche naturali e culturali uniche al mondo, si entusiasmava lo sposo. Il mattino seguente davanti alla finestra spalancata – lui era nel bagno – osservava i faraglioni e il mare turchino senza vederli e sentiva gli stridi dei gabbiani senza ascoltarli, le lacrime gli velarono il panorama e subito le deterse perché avvertì la presenza di lui dietro le spalle. La cinse con un braccio e parlò dei poeti e degli artisti che venivano da ogni parte del mondo in questo lembo di Paradiso; e la baciò romanticamente. Al ricordo, un tremore errò sulle sue labbra e si dolse sin nel profondo.
Non l’aveva amato, gli aveva voluto bene, questo sì, come se ne può volere a un vicino di casa sempre gentile e disponibile. E per via che lui l’amava di un amore assoluto lei gli fu sempre riconoscente. Mai un litigio.
Mio caro, tu, che hai portato a spasso la tua vita con decoro e gentilezza, confessami: sapevi che io, la tua Vita di nome e di fatto, come amavi ripetermi fino alla noia, non ho mai sentito un briciolo di passione per te? Ah, la vita, tu l’hai vissuta certo meglio di me, avvitato com’eri alla mia, al tuo amore per me senza fine. Guardavi sfiorire i fiori sul terrazzo e mi dicevi: “La tua bellezza non sfiorirà mai”. Io nascondevo la mia indifferenza dietro un sorriso, e Dio solo sa quanto esso era amaro. Sai quando ho sentito qualcosa (pietà?) per te? L’ultimo anno della tua vita. Soffrivi, e la mia presenza leniva la tua sofferenza. Era l’inizio d’autunno e tu avevi espresso il desiderio di tornare a Capri. Albergo a cinque stelle con ampia terrazza agghindata di piante e fiori con vista meravigliosa. Una luce senza sorriso sfrangiava di giallo morto le nuvole del tramonto e tu con la coscienza della fine prossima sorridevi sempre per il solo fatto che ti ero accanto ed eri arcicontento di morire prima di me. Il tuo Amore per me – lo scrivevi con la A maiuscola nelle lettere che mi spedivi quando eri fuori per lavoro – “una fiamma divina che le grandi acque non riescono a spegnere né i fiumi a travolgere”, citavi la Bibbia. Tu sei stato fortunatissimo, amico mio! Quella fiamma divina è arsa in te dal giorno in cui mi hai conosciuto sino agli ultimi attimi della tua vita. In me è arsa per brevissimi e lontanissimi momenti e non per te. Lo so, la più grande pena per te era che tu mi sopravvivessi. M’immagino il dolore di veder allontanarsi per sempre chi hai amato di amore grande! Non era il mio caso e mi ritenevo fortunata. Ma anche tu sei stato fortunato, no? Non mi hai visto crepare, forse saresti crepato con me, come il cane che si lascia morire insieme col padrone. Io sono stato il tuo padrone, ma non te l’ho chiesto io di esserlo, eri tu felice di essere schiavo d’amore… Negli ultimi mesi mi hai ripetuto fino alla noia i versi che ricordo a memoria e non so se erano tuoi o di chi, e, ti confesso, la commozione ora mi prende: “La morte non è niente. / Sarò solamente passato dall’altra parte / è come fossi nascosto nella stanza accanto / non sarò lontano, sarò dietro l’angolo / come quando giocavo a nascondino con i bambini. / Il tuo sorriso è stato la mia pace quaggiù / sarà la mia pace lassù”.
Ora il mio cervello funziona per inerzia e niente mi salva da me stessa; vorrei dormire, dormire un sonno ignaro d’angoscia, lungo lunghissimo e poi svegliarmi un giorno, un giorno d’aprile ma non come questo, un giorno d’aprile delicato di sole al tramonto… o di sera alla luce generosa della luna nel vico sotto la finestra della mia vecchia casa accanto al cadavere della mia felicità ferita a morte da una schioppettata di mio padre che mise in fuga per sempre il mio Romeo. Ah Romeo Romeo… Mi sa che è il mio senno che sta fuggendo sulla luna e non ho un amico fatato come Astolfo che vada a recuperarmelo lassù – le capitava spesso di associare reminiscenze letterarie ai suoi ricordi o stati d’animo, e sorrise –. Ah, a scapparsene per sempre il senno! Così non penserei a nulla, non aspetterei il Nulla… chi vive come me non c’è bisogno che muoia.
Era ancora davanti alla finestra – di casa o a Capri? – Quel mare da azzurro e placido si fece agitato e marrone, nere nuvolaglie abbassarono il cielo, strani stridi quelli dei gabbiani quasi metallici come un suono proveniente da estreme lontananze e quando capì che era il telefono andò per rispondere ma il telefono smise di squillare. Pensò a qualcuno dei figli – solo a loro? – Meccanicamente prese dalla tasca della vestaglia un kleenex, si asciugò le guance umide. Andò al bagno, si lavò e mentre si aggiustava davanti allo specchio si rivide in un altro specchio, lontanissimo nello spazio e nel tempo, rimirarsi nella sua magnifica selvatichezza: a quelle due parole pronunciate ad alta voce apparve dal buio sotterraneo della memoria, dove l’aveva inabissato, l’altro. Si scosse e andò nella stanza da letto, si vestì lentamente e mentre si vestiva cadenzò le parole: “Non c’è nostalgia più dolorosa di quella delle cose che non sono mai state”. Come ogni forte lettore non ricordò precisamente di chi fossero. Forse di Pessoa.
Uscì nel primo pomeriggio. Il cielo accennava una schiarita a ponente ma a levante era cupo: non un giorno di cielo tutto azzurro in questo aprile, pensò. E guardando quel grande pezzo di cielo lucido simile a un lago montano rivide l’infanzia dei figli che durante la villeggiatura volevano andare ogni giorno al lago, e s’immerse nei loro ricordi bambini, assecondando, come spesso faceva, quell’inganno dolcedolente; e ora adulti e lontani ebbe una fitta al cuore.
Non sentendo più i suoi passi si percepì come un’ombra. Si guardò intorno, rallentò il passo, si fermò. Non avvertiva i rumori della vita circostante, tutto si era trasformato in penombra e capì che sì, tutto era finito. Al crepitare di un motorino ebbe un lieve soprassalto, uscì dalla penombra e riprese a camminare e avvertì un’inutile quiete scenderle nel profondo. Vagò per le viuzze della città vecchia, dove dormì il sonno di bambina fino alla vigilia della giovinezza. S’imbatté in qualche conoscenza scambiando parole vacue. Al chiosco consumò una spremuta d’arancia: provò un senso di tenerezza per il gestore – non ricordava come da Napoli era finito lì – più vecchio dei suoi anni, un tempo giovane e impertinente quando d’estate le offriva il gelato sussurrandole che voleva essere un gelato per entrare dentro di lei. Le ricordò il suo gusto preferito. Lei gli sorrise. Uscì dalla città vecchia. Passò dall’edicola e comprò un quotidiano nazionale e il periodico locale. Si diresse alla villa comunale. Raggiunse con un po’ d’affanno il solito posto, là in alto. Sedette sulla panchina di legno sotto la robinia. Diede una scorsa al periodico e durante la lettura del quotidiano si appisolò.
Su, vieni, avvicinati, è inutile che nascondi la falce dietro la schiena e ti presenti con quel sorriso triste come a volerti scusare. Guarda laggiù in fondo il giorno che se ne va: anch’esso ha il sorriso triste del tramonto. Non ti pare? Ma non può che cedere alla notte, morire per risorgere domani. Brava, così mi piaci, accomodati, metti da parte la falce, riposa un poco, dammi retta, dormi un poco, deponi la falce, no, non te la nascondo, mi credi così coraggiosa? intelligenza sì, ma quanto a coraggio… Se ne avessi avuto non sarei qui ora a chiederti di addormentarti vicino a me prima di… E se ti addormentassi e non ti svegliassi più? Dico sciocchezze? Lo so lo so, ne ho dette tante, e anche fatte, s’intende… ma una imperdonabile. E risentì come un’eco lontana la melodia della giovinezza al dolorante arpeggio della chitarra nel vico cieco della Fossa dei Ciucci e si aggrappò al ricordo: rivide il sorriso di lui triste da ventenne alla luce bianca della luna allontanarsi lentamente nonostante le due schioppettate di suo padre dalla finestra di casa. Pum pum… avrei voluto corrergli dietro ma due manrovesci di mio padre mi inchiodarono alla sedia. Mai più ho rivisto un sorriso come il suo, o forse non l'ho cercato e mi diedi a cercare me stessa senza incontrarmi mai. Tutto quello che ho avuto sono stati brandelli di luce riflessa dai figli quando erano piccoli. In seguito frammenti di falsa vita… Ho un compagno da tanto tempo che mi sta dietro dietro, anzi avanti avanti, anzi dentro dentro e mi trascina in questa vita-non vita. Non riposa e non dorme mai, come te. Tutto muore in me da quando è padrone di me, con la sua fredda mano mi stringe le tempie e me le fa scoppiare e per il dolore erompe dentro di me un pianto acuto come quello delle prefiche durante la pausa delle orazioni. A questo punto sei preferibile tu a lui, per questo ti ho chiamato. Ma ora dormi un poco anche tu e sogna per una volta la vita. Al risveglio mi darai il tuo bacio e anch’io entrerò con un sorriso triste nella notte del tempo senza tempo. Brava, vedo che ti stai addormentando… Ma che urli così disperata! Ti eri appena appisolata. Che hai sognato di tanto orribile? Hai avuto un incubo forse? Me lo vuoi dire per favore? Ah, ma io lo so. Nel tuo fulmineo sonno hai avuto un incubo: la vita.
Sobbalzò al poderoso mugghio dello smisurato bastimento ancorato nel porto e pensò alle sue amiche patite di crociere, e alla loro vaghezza culturale. Lei, a differenza di loro, aveva viaggiato una vita sempre sulla stessa nave; una nave particolare, taciturna e pensosa, stracolma di uomini e donne di lingue diverse: tutti ordinati e allineati, ognuno al proprio posto da lei assegnato sugli scaffali. E dal diuturno colloquio con loro aveva conosciuto le meraviglie e gli orrori degli uomini. Un merlo zinziò saltellando da un ramo all’altro, lei cercò goffamente di imitarne il verso con un leggero sorriso che si mutò in una smorfia d’indignazione pensando a un balordo cacciatore. “Deficiente – inveì mentalmente – se spari a un merlo credi tu che il suo canto cesserà per sempre? Il suo canto stormiva già prima di Budda, Cristo e Maometto e continuerà a echeggiare anche molto dopo che le loro parole saranno cadute nell’oblio perché quello del merlo, dell’usignolo, della cinciallegra, del cardellino, dell'allodola, non è un sermone, un’ammonizione, un comandamento, è solo canto. E in principio non ‘era la parola’ ma il canto di un uccello”.
Una volta in pensione non vi aveva messo più piede in biblioteca. Anzi vi era andata una volta dopo circa un anno, e quegli scaffali che lei aveva nutrito, allevato e protetto, erano coperti, le parve, di sonno e di polvere.
Nei primi tempi quando era solo impiegata la sala di lettura era affollata di “studiosi” giovani che le sbirciavano le cosce ogni volta che saliva sulla scala a pioli per prendere i libri dagli scaffali più alti. Ricordò che allora le donne non usavano portare i pantaloni e le gonne erano per giunta corte. Non poteva, ora, escludere che ci prendesse gusto in quel saliscendi conturbante. Aveva venti-ventidue anni ed era molto bella. Sorrise.
Era ancora bella e aveva una schiera di corteggiatori, anche under 60. Quelli più accesi dicevano che era di una bellezza regale. Il suo portamento eretto e lo sguardo elevato potevano presumere una certa superbia, ma non era superbia: era come se guardasse la propria esistenza dall’alto senza indulgenza. I capelli, non tinti, tendenti al grigio parevano vezzeggiati da mèches; il viso rivelava accoramento misto alla dolcezza dell’intelligenza – non del cuore – e per questo appariva austeramente bello.
Si alzò dalla panchina e si avvicinò alla balaustrata. Il sole era a picco sull’orizzonte frangiato da nuvolette chiare mentre una nube grande e cinerina avanzava minacciosa verso la linea del tramonto. Poggiò i gomiti sulla cimasa, le mani a pugno sotto il mento, lo sguardo fisso: il mare verde, il molo, la lunga fila di tigli sul lungomare, ma non li vedeva. Ebbe compassione di sé, della sua vita. Mentalmente, dall’alto in basso misurò i metri ed ebbe un fremito di paura e poi rabbrividì tutta perché sentì il freddo della vita. Si fissò nella visione del tramonto: la grande nuvola coprì totalmente il sole, lui la decorò di rosa e, acquattato dietro quel fondale, non riapparve più mentre gli ultimi scorci d’azzurro sfumavano nel grigio. Rientrò in sé, nella riserva del suo azzurro interiore.
I passi, lenti, invece di riportarla a casa, la portarono sul molo. Rigattieri e persone sfaccendate vociavano in attesa delle paranze. Più lontano, coppie di innamorati, sedute sui frangiflutti, aspettavano l’oscurità. Si portò ai bordi della banchina del molo: l’acqua, benché alta, era stagnante, istoriata da larghe macchie luccicanti di nafta. Si afferrò ai lembi del giorno in fuga.
CERCA
NEWS
-
22.02.2026
Nutrimenti
Antonio Moresco - Il finimondo -
22.02.2026
Sellerio
Dario Ferrari - L'idiota di famiglia -
22.02.2026
Adelphi
Henry James - Ormai non poteva succedere più nulla - Taccuini.
RECENSIONI
-
William Sloane
La porta dell’alba
-
Laura Imani Messina
Le parole della pioggia
-
Maurizio de Giovanni
L’orologiaio di Brest
ATTUALITA'
-
Stefano Torossi
Giovanni Bottesini 1821 - 1889
-
Stefano Torossi
GEORGE ANTHEIL 1900 – 1959
-
Stefano Torossi
I FRATELLI MARCELLO. Benedetto Marcello 1686 – 1739 Alessandro Marcello 1673 – 1747
CLASSICI
CINEMA E MUSICA
-
Marco Minicangeli
The Dangers in My Heart
-
Lorenzo Lombardi/Marco Minicangeli
28 anni dopo – Il tempio delle ossa.
-
Marco Minicangeli
La mia famiglia a Taipei
RACCONTI
-
Dauphine Potter
Summer, estate, summer summer.
-
Pietro Poltronieri
Sumud Flotilla
-
Eugenio Flajani Galli
Ciro e il Miracolo di S. Gennaro