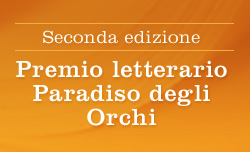ATTUALITA'
Stefano Torossi
Antonio Caldara - 1670 - 1736

All’epoca bisognava attaccarsi alla nobiltà per sopravvivere, non c’era nessun altro modo. E così fa il nostro Antonio Caldara, passando da principi a cardinali per finire nientedimeno che con un imperatore.
Nasce a Venezia, è musico contralto nella Cappella ducale di S. Marco a ottanta ducati l’anno, poi, per la sua “molta virtù nella professione del contrapunto, cantar di musica e tasteggiare, oltre al cembalo, diverse sorti d’istromenti”, è nominato Maestro di Cappella del Duca di Mantova, fino allo scoppio della guerra di successione spagnola, quando la corte si scioglie e tutti scappano a gambe levate.
Nel 1708 lo troviamo a Roma nel palazzo del suo nuovo protettore, il Cardinale Pietro Ottoboni, vicecancelliere pontificio, collezionista d’arte e poeta, autore di molti testi messi in musica proprio da Caldara. Comincia a conoscere e a farsi stimare da altri nobili: il Marchese Ruspoli, il Cardinale Pamphilij, la Regina di Polonia.
Nello stesso anno raggiunge gli Absburgo di Spagna e proprio qui nasce il seme della futura, saldissima stima che sempre gli dimostrerà la famiglia imperiale.
Nel 1709 è di nuovo a Roma dai Ruspoli presso i quali inizia un periodo di fecondo rapporto professionale e amichevole in compagnia di altri virtuosi musicali per una fitta serie di rappresentazioni, le “conversazioni” domenicali a cui tutta la nobiltà tiene a essere invitata a causa del loro richiamo mondano, ma anche, come leggiamo qui sotto, per il livello artistico.
Il Barone von Uffenbach, fine conoscitore di musica, non finisce di lodarne l’alta qualità: “Il concerto settimanale a Palazzo Ruspoli è il meglio qui a Roma. Sono convinto di non aver mai ascoltato in tutta la mia vita qualcosa di simile perfezione…la cantante principale è la moglie di Caldara”.
Nessun suo titolo è rimasto a galleggiare nella memoria dei posteri, come invece è successo ad alcuni colleghi, ma è certo che di musica ne ha scritta moltissima, e buona: Stabat mater, Missa Dolorosa, e musica sacra; musica da camera, sonate, trii e quartetti; opere, “Ifigenia in Aulide”, “Dafne”, eccetera eccetera.
Nel 1711 muore l’imperatore e Caldara si affretta a offrire i suoi servizi al successore Carlo VI (l’amico spagnolo) e lo segue a Vienna nella speranza di un posto fisso a corte, ma non riesce ad ottenere lo sperato incarico di Maestro di Cappella, che invece, per i contorti disegni della burocrazia imperiale scivola direttamente in grembo al vice precedente, Ziani.
Nel ’13 Ziani muore, ma anche questa volta e probabilmente per la stessa ragione, niente da fare per Caldara, il quale, prudentemente ha mantenuto la sua posizione presso il principe Ruspoli.
Finalmente nel ‘17 arriva la sospirata nomina a Vicekapellmeister, nella quale a un certo punto il Caldara arriva a comandare più del vero Kapellmeister, Fux, a sostituirlo in pubblico durante i suoi frequenti attacchi di podagra, a incassare uno stipendio superiore e soprattutto a mantenere, aumentandola la benevolenza dell’imperatore che si manifesta con continui premi in denaro, riconoscimenti onorifici e alla fine addirittura, in sostituzione del vitalizio destinato alla sua vedova, con una enorme liquidazione di fine carriera: 12.000 fiorini!
Mica male per quello che all’epoca era ancora un domestico.
Musicale, ma sempre domestico.
Nasce a Venezia, è musico contralto nella Cappella ducale di S. Marco a ottanta ducati l’anno, poi, per la sua “molta virtù nella professione del contrapunto, cantar di musica e tasteggiare, oltre al cembalo, diverse sorti d’istromenti”, è nominato Maestro di Cappella del Duca di Mantova, fino allo scoppio della guerra di successione spagnola, quando la corte si scioglie e tutti scappano a gambe levate.
Nel 1708 lo troviamo a Roma nel palazzo del suo nuovo protettore, il Cardinale Pietro Ottoboni, vicecancelliere pontificio, collezionista d’arte e poeta, autore di molti testi messi in musica proprio da Caldara. Comincia a conoscere e a farsi stimare da altri nobili: il Marchese Ruspoli, il Cardinale Pamphilij, la Regina di Polonia.
Nello stesso anno raggiunge gli Absburgo di Spagna e proprio qui nasce il seme della futura, saldissima stima che sempre gli dimostrerà la famiglia imperiale.
Nel 1709 è di nuovo a Roma dai Ruspoli presso i quali inizia un periodo di fecondo rapporto professionale e amichevole in compagnia di altri virtuosi musicali per una fitta serie di rappresentazioni, le “conversazioni” domenicali a cui tutta la nobiltà tiene a essere invitata a causa del loro richiamo mondano, ma anche, come leggiamo qui sotto, per il livello artistico.
Il Barone von Uffenbach, fine conoscitore di musica, non finisce di lodarne l’alta qualità: “Il concerto settimanale a Palazzo Ruspoli è il meglio qui a Roma. Sono convinto di non aver mai ascoltato in tutta la mia vita qualcosa di simile perfezione…la cantante principale è la moglie di Caldara”.
Nessun suo titolo è rimasto a galleggiare nella memoria dei posteri, come invece è successo ad alcuni colleghi, ma è certo che di musica ne ha scritta moltissima, e buona: Stabat mater, Missa Dolorosa, e musica sacra; musica da camera, sonate, trii e quartetti; opere, “Ifigenia in Aulide”, “Dafne”, eccetera eccetera.
Nel 1711 muore l’imperatore e Caldara si affretta a offrire i suoi servizi al successore Carlo VI (l’amico spagnolo) e lo segue a Vienna nella speranza di un posto fisso a corte, ma non riesce ad ottenere lo sperato incarico di Maestro di Cappella, che invece, per i contorti disegni della burocrazia imperiale scivola direttamente in grembo al vice precedente, Ziani.
Nel ’13 Ziani muore, ma anche questa volta e probabilmente per la stessa ragione, niente da fare per Caldara, il quale, prudentemente ha mantenuto la sua posizione presso il principe Ruspoli.
Finalmente nel ‘17 arriva la sospirata nomina a Vicekapellmeister, nella quale a un certo punto il Caldara arriva a comandare più del vero Kapellmeister, Fux, a sostituirlo in pubblico durante i suoi frequenti attacchi di podagra, a incassare uno stipendio superiore e soprattutto a mantenere, aumentandola la benevolenza dell’imperatore che si manifesta con continui premi in denaro, riconoscimenti onorifici e alla fine addirittura, in sostituzione del vitalizio destinato alla sua vedova, con una enorme liquidazione di fine carriera: 12.000 fiorini!
Mica male per quello che all’epoca era ancora un domestico.
Musicale, ma sempre domestico.
CERCA
NEWS
-
22.02.2026
Nutrimenti
Antonio Moresco - Il finimondo -
22.02.2026
Sellerio
Dario Ferrari - L'idiota di famiglia -
22.02.2026
Adelphi
Henry James - Ormai non poteva succedere più nulla - Taccuini.
RECENSIONI
-
William Sloane
La porta dell’alba
-
Laura Imani Messina
Le parole della pioggia
-
Maurizio de Giovanni
L’orologiaio di Brest
ATTUALITA'
-
Stefano Torossi
Giovanni Bottesini 1821 - 1889
-
Stefano Torossi
GEORGE ANTHEIL 1900 – 1959
-
Stefano Torossi
I FRATELLI MARCELLO. Benedetto Marcello 1686 – 1739 Alessandro Marcello 1673 – 1747
CLASSICI
CINEMA E MUSICA
-
Marco Minicangeli
The Dangers in My Heart
-
Lorenzo Lombardi/Marco Minicangeli
28 anni dopo – Il tempio delle ossa.
-
Marco Minicangeli
La mia famiglia a Taipei
RACCONTI
-
Dauphine Potter
Summer, estate, summer summer.
-
Pietro Poltronieri
Sumud Flotilla
-
Eugenio Flajani Galli
Ciro e il Miracolo di S. Gennaro