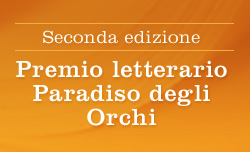ATTUALITA'
Stefano Torossi
Il povero Cla-Cla
All’Ara Pacis si apre la mostra “Claudio, il destino di un imperatore”. Allestimento sontuoso, pareti rosse, fari puntati. Alcuni pregevoli pezzi originali di scultura, molti calchi in gesso, di nessun interesse artistico, naturalmente, ma importanti per capire meglio il periodo. Tutto molto ufficiale.
Tranne questo bronzo che ci ha colpiti per la sua verità. E’ un (presunto) ritratto di Claudio, che evidenzia il primo dei suoi tanti difetti, non sappiamo se veri oppure inventati dai suoi detrattori che erano, chissà perché, molti e molto agguerriti: un paio di esagerate orecchie a sventola.
Povero Claudio, avvelenato figurativamente e si sospetta anche letteralmente, con un bel piatto di funghi da una delle mogli molto particolari che incautamente frequentò: Messalina e Agrippina. (Seneca, il pettegolo, scrive che, proprio in questa occasione, le sue ultime parole prima di andarsene furono: “Vae! Puto concacavi me!” – “Accidenti! Credo di essermela fatta addosso!”)
Scomodamente collocato dal fato tra Caligola, di cui era zio, e Nerone, di cui era patrigno, non deve avere avuto una vita facile.
In più era zoppo, ovvero claudicante (dal latino claudus - Claudius), e balbuziente, per questo soprannominato Cla-Cla; e finalmente considerato un mezzo scemo da familiari e amici.
Eppure a cinquant’anni, una volta fatto fuori Caligola (non da lui, in verità), diventa imperatore, e neanche tanto malvagio. Anzi, per quello che possiamo ancora vedere almeno in architettura, un grande.
Suo è l’Acquedotto Claudio, per duemila anni il più bell’ornamento della Campagna Romana oltre a essere uno dei più grandiosi dell’impero.
Basta alzare gli occhi su per i magnifici massicci pilastri che per chilometri avanzano, arco dopo arco, con una regolarità che, certo anche per la sua funzionalità, coincide con la perfezione assoluta.
Suo è anche il grande porto di Ostia, meno fortunato dell’Acquedotto, perché si insabbiò dopo meno di un secolo. E naturalmente una quantità di altre belle opere e di belle conquiste per Roma, fra cui quella della Britannia.
Ma a noi è particolarmente simpatico per una novità che tentò di introdurre fra le piccole cose quotidiane: niente a che vedere con le sue grandiose imprese di condottiero e imperatore.
A Roma, in Via del Pellegrino, al N. 145, c’è un negozio di casalinghi, il cui proprietario, mentre vende caffettiere e detersivi, ascolta Scarlatti a preferenza di Vivaldi perché trova quest’ultimo un po’ troppo commerciale.
Murata sulla parete vicino all’ingresso di questa bottega particolare c’è una lapide (pur sapendo che ce n’è un’altra simile ai Musei Vaticani, crediamo che sia l’unica di questo genere in giro per la città) che testimonia un’audace innovazione grafica di Claudio, durata solo pochi anni e poi dimenticata (come spesso accade alle audaci innovazioni).
Una nuova lettera, una F rovesciata (Ⅎ), chiamata digamma inversum, introdotta da Cla-Cla nell’alfabeto latino per indicare la V intervocalica che prima era tutt’uno con la U.
È nell’ultima riga dell’epigrafe. Un po’ di attenzione e la si scopre dove normalmente ci sarebbe stata una V: POMERIVM (AM)PLIAℲIT TERMINAℲIT(QUE), invece di come si scriveva prima, e si continuò a scrivere dopo: POMERIVM (AM)PLIAVIT TERMINAVIT(QUE).
La U di pomerium non è intervocalica quindi non ha subito modifiche e ha continuato a essere scritta V.
Poco imperiale magari, ma decisamente carino.
Tranne questo bronzo che ci ha colpiti per la sua verità. E’ un (presunto) ritratto di Claudio, che evidenzia il primo dei suoi tanti difetti, non sappiamo se veri oppure inventati dai suoi detrattori che erano, chissà perché, molti e molto agguerriti: un paio di esagerate orecchie a sventola.
Povero Claudio, avvelenato figurativamente e si sospetta anche letteralmente, con un bel piatto di funghi da una delle mogli molto particolari che incautamente frequentò: Messalina e Agrippina. (Seneca, il pettegolo, scrive che, proprio in questa occasione, le sue ultime parole prima di andarsene furono: “Vae! Puto concacavi me!” – “Accidenti! Credo di essermela fatta addosso!”)
Scomodamente collocato dal fato tra Caligola, di cui era zio, e Nerone, di cui era patrigno, non deve avere avuto una vita facile.
In più era zoppo, ovvero claudicante (dal latino claudus - Claudius), e balbuziente, per questo soprannominato Cla-Cla; e finalmente considerato un mezzo scemo da familiari e amici.
Eppure a cinquant’anni, una volta fatto fuori Caligola (non da lui, in verità), diventa imperatore, e neanche tanto malvagio. Anzi, per quello che possiamo ancora vedere almeno in architettura, un grande.
Suo è l’Acquedotto Claudio, per duemila anni il più bell’ornamento della Campagna Romana oltre a essere uno dei più grandiosi dell’impero.
Basta alzare gli occhi su per i magnifici massicci pilastri che per chilometri avanzano, arco dopo arco, con una regolarità che, certo anche per la sua funzionalità, coincide con la perfezione assoluta.
Suo è anche il grande porto di Ostia, meno fortunato dell’Acquedotto, perché si insabbiò dopo meno di un secolo. E naturalmente una quantità di altre belle opere e di belle conquiste per Roma, fra cui quella della Britannia.
Ma a noi è particolarmente simpatico per una novità che tentò di introdurre fra le piccole cose quotidiane: niente a che vedere con le sue grandiose imprese di condottiero e imperatore.
A Roma, in Via del Pellegrino, al N. 145, c’è un negozio di casalinghi, il cui proprietario, mentre vende caffettiere e detersivi, ascolta Scarlatti a preferenza di Vivaldi perché trova quest’ultimo un po’ troppo commerciale.
Murata sulla parete vicino all’ingresso di questa bottega particolare c’è una lapide (pur sapendo che ce n’è un’altra simile ai Musei Vaticani, crediamo che sia l’unica di questo genere in giro per la città) che testimonia un’audace innovazione grafica di Claudio, durata solo pochi anni e poi dimenticata (come spesso accade alle audaci innovazioni).
Una nuova lettera, una F rovesciata (Ⅎ), chiamata digamma inversum, introdotta da Cla-Cla nell’alfabeto latino per indicare la V intervocalica che prima era tutt’uno con la U.
È nell’ultima riga dell’epigrafe. Un po’ di attenzione e la si scopre dove normalmente ci sarebbe stata una V: POMERIVM (AM)PLIAℲIT TERMINAℲIT(QUE), invece di come si scriveva prima, e si continuò a scrivere dopo: POMERIVM (AM)PLIAVIT TERMINAVIT(QUE).
La U di pomerium non è intervocalica quindi non ha subito modifiche e ha continuato a essere scritta V.
Poco imperiale magari, ma decisamente carino.
CERCA
NEWS
RECENSIONI
-
Matteo Auciello
Tecniche miste di trasformazione.
-
Luca Giommoni
Nero
-
Matsumoto Seicho
Vangelo nero
ATTUALITA'
-
Stefano Torossi
GEORGE ANTHEIL 1900 – 1959
-
Stefano Torossi
I FRATELLI MARCELLO. Benedetto Marcello 1686 – 1739 Alessandro Marcello 1673 – 1747
-
Stefano Torossi
Carl Maria von Weber 1786 - 1826
CLASSICI
CINEMA E MUSICA
-
Lorenzo Lombardi/Marco Minicangeli
28 anni dopo – Il tempio delle ossa.
-
Marco Minicangeli
La mia famiglia a Taipei
-
Marco Minicangeli
To a Land Unknow
RACCONTI
-
Pietro Poltronieri
Sumud Flotilla
-
Eugenio Flajani Galli
Ciro e il Miracolo di S. Gennaro
-
Massimo Grisafi
Dondola dondola