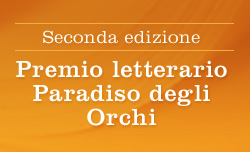CLASSICI
Alfredo Ronci
Una tragedia modernissima: ‘Maria Zef’ di Paola Drigo.
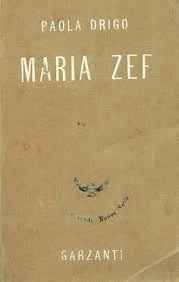
Mi fa davvero pensare e ripensare quel premio Viareggio (1937): dato ad un libro che condanna, senza mezzi termini, il machismo e la condizione subumana della donna, quando il contesto (si legga: regime), nell’esaltazione di valori tipicamente maschili (famiglia, patria, chiesa), aggiungeva, piuttosto che sottrarre, stimoli ad una reiterata prassi del possesso.
Per questo il titolo specifica l’elemento della modernità di Maria Zef: (di una scrittrice, Paola Drigo, nata quasi per sbaglio, appena formatasi con qualche racconto qua e là, prima di pubblicare un romanzo che un critico di allora, esattamente Pietro Pancrazi, definì forte quanto le cose più cruenti di una Deledda o di una Serao) perché viola la trimurti del pensiero fascista e, soprattutto nel finale della storia, lo fiacca orgogliosamente stroncandolo con violenza, con un atto potremmo dire quasi rivoluzionario.
Andiamo con ordine.
Formatasi alla scuola del verismo la Drigo omaggia in qualche modo la corrente: ne esce una storia secca, nel senso dell’essenzialità, priva di qualsiasi orpello, ma fedele ad una linea che esalta un profondo sentimento di pietà per gli ‘ultimi’, per i reietti, per i morti di fame, cittadini di uno stato non solo sotto regime, ma profondamente contadino e lungi ancora da un riscatto sociale.
La trama: Dopo la morte della madre, la quindicenne Mariute (Marietta) e la piccola Rosute (Rosetta) vengono dapprima ospitate in un convento di suore, poi accolte nella baita dello zio, Barbe Zef, il quale, mentre la sorellina è ricoverata in ospedale, abusa di Mariute.
La violenza viene avvertita dal lettore – e questo grazie anche al sapiente ‘dosaggio’ della Drigo - come una sorta di naturalezza del fenomeno sociale, come piaga ancestrale contro cui poco si può fare, perché una reazione metterebbe a repentaglio la condizione della donna (è lei che è sempre stata la vittima: forse cambiato qualcosa da allora?). La soluzione: anticipare la reiterazione dell’abuso.
Quando Mariute, su decisione dello zio, è costretta ad andar serva presso una famiglia più agiata, capisce che la prossima destinata dell’uomo sarà la sorellina: per evitare il più che probabile incesto, decide di eliminare lo zio, mozzandolo con un’ascia: Ella l’afferrò e l’alzò quanto più alto poté. La lama lampeggiò nell’ombra. Mirò al collo, e vibrò il colpo.
Non un grido: solo un fiotto di sangue.
Con questo finale, tra il grandguignol e la letteratura d’appendice (davvero l’unico appunto rispetto ad una improbabile deriva nazional-popolare), il romanzo della Drigo consegna ai posteri un ruolo femminile che avrà pochi eguali negli anni successivi. E soprattutto illumina un personaggio, Mariute che, pur nella configurazione di donnetta tutto sommato servile e abusata e nell’impossibilità di adagiarsi a una teologia in grado di proteggerla (Nessuno le aveva insegnato a pregare. Speranza, luce, a lei non potevano venire dal cielo ma, se mai, dalla terra) rivela una determinazione finale che, come si diceva all’inizio, assume una valenza quasi rivoluzionaria.
Non è certo la descrizione di un’Italia lontana mille miglia dall’attuale, in una dimensione tragica di miseria e disperazione, a relegare Maria Zef in un’ottica sorpassata e demodé (a riguardo vorrei spezzare una lancia a favore di una letteratura, soprattutto quella dagli anni quaranta agli anni sessanta, che quasi mai si prestò ad una deriva modale che comunque è sempre esistita nell’editoria, con il carro di Tespi di nepotismi e favoritismi): ci sono troppi elementi che appartengono ad un’ancestrale disamina dell’essere umano e ad un’idea di superiorità genetica.
Maria Zef rimane un punto nevralgico della produzione letteraria della Drigo, ma anche della produzione letteraria nazionale in genere.
Nel 1981 Vittorio Cottafavi, regista di esperienza indiscussa, realizzò un film tratto dal libro. Le reazioni furono strane ed inconsuete, come lo furono pure all’uscita di Maria Zef : si preferì colpevolizzare l’autrice e il regista (quest’ultimo aveva avuto anche l’intuito di far recitare la pellicola in friulano) per aver mostrato una terra segnata dallo stereotipo dell’alcolismo e dell’incesto, piuttosto che determinare un’analisi serena dei meccanismi dello strapotere maschile.
Così allora, come sempre.
L‘edizione da noi considerata è:
Paola Drigo
Maria Zef
Garzanti - 1942
Per questo il titolo specifica l’elemento della modernità di Maria Zef: (di una scrittrice, Paola Drigo, nata quasi per sbaglio, appena formatasi con qualche racconto qua e là, prima di pubblicare un romanzo che un critico di allora, esattamente Pietro Pancrazi, definì forte quanto le cose più cruenti di una Deledda o di una Serao) perché viola la trimurti del pensiero fascista e, soprattutto nel finale della storia, lo fiacca orgogliosamente stroncandolo con violenza, con un atto potremmo dire quasi rivoluzionario.
Andiamo con ordine.
Formatasi alla scuola del verismo la Drigo omaggia in qualche modo la corrente: ne esce una storia secca, nel senso dell’essenzialità, priva di qualsiasi orpello, ma fedele ad una linea che esalta un profondo sentimento di pietà per gli ‘ultimi’, per i reietti, per i morti di fame, cittadini di uno stato non solo sotto regime, ma profondamente contadino e lungi ancora da un riscatto sociale.
La trama: Dopo la morte della madre, la quindicenne Mariute (Marietta) e la piccola Rosute (Rosetta) vengono dapprima ospitate in un convento di suore, poi accolte nella baita dello zio, Barbe Zef, il quale, mentre la sorellina è ricoverata in ospedale, abusa di Mariute.
La violenza viene avvertita dal lettore – e questo grazie anche al sapiente ‘dosaggio’ della Drigo - come una sorta di naturalezza del fenomeno sociale, come piaga ancestrale contro cui poco si può fare, perché una reazione metterebbe a repentaglio la condizione della donna (è lei che è sempre stata la vittima: forse cambiato qualcosa da allora?). La soluzione: anticipare la reiterazione dell’abuso.
Quando Mariute, su decisione dello zio, è costretta ad andar serva presso una famiglia più agiata, capisce che la prossima destinata dell’uomo sarà la sorellina: per evitare il più che probabile incesto, decide di eliminare lo zio, mozzandolo con un’ascia: Ella l’afferrò e l’alzò quanto più alto poté. La lama lampeggiò nell’ombra. Mirò al collo, e vibrò il colpo.
Non un grido: solo un fiotto di sangue.
Con questo finale, tra il grandguignol e la letteratura d’appendice (davvero l’unico appunto rispetto ad una improbabile deriva nazional-popolare), il romanzo della Drigo consegna ai posteri un ruolo femminile che avrà pochi eguali negli anni successivi. E soprattutto illumina un personaggio, Mariute che, pur nella configurazione di donnetta tutto sommato servile e abusata e nell’impossibilità di adagiarsi a una teologia in grado di proteggerla (Nessuno le aveva insegnato a pregare. Speranza, luce, a lei non potevano venire dal cielo ma, se mai, dalla terra) rivela una determinazione finale che, come si diceva all’inizio, assume una valenza quasi rivoluzionaria.
Non è certo la descrizione di un’Italia lontana mille miglia dall’attuale, in una dimensione tragica di miseria e disperazione, a relegare Maria Zef in un’ottica sorpassata e demodé (a riguardo vorrei spezzare una lancia a favore di una letteratura, soprattutto quella dagli anni quaranta agli anni sessanta, che quasi mai si prestò ad una deriva modale che comunque è sempre esistita nell’editoria, con il carro di Tespi di nepotismi e favoritismi): ci sono troppi elementi che appartengono ad un’ancestrale disamina dell’essere umano e ad un’idea di superiorità genetica.
Maria Zef rimane un punto nevralgico della produzione letteraria della Drigo, ma anche della produzione letteraria nazionale in genere.
Nel 1981 Vittorio Cottafavi, regista di esperienza indiscussa, realizzò un film tratto dal libro. Le reazioni furono strane ed inconsuete, come lo furono pure all’uscita di Maria Zef : si preferì colpevolizzare l’autrice e il regista (quest’ultimo aveva avuto anche l’intuito di far recitare la pellicola in friulano) per aver mostrato una terra segnata dallo stereotipo dell’alcolismo e dell’incesto, piuttosto che determinare un’analisi serena dei meccanismi dello strapotere maschile.
Così allora, come sempre.
L‘edizione da noi considerata è:
Paola Drigo
Maria Zef
Garzanti - 1942
CERCA
NEWS
-
4.01.2026
Rizzoli
Dan Brown -
4.01.2026
La nave di Teseo
Patricia Highsmith -
4.01.2026
Adelphi
C.S.Lewis
RECENSIONI
-
Anna Bailey
I nostri ultimi giorni selvaggi
-
Paolo Agnoli
Gli ebrei e la cultura
-
Han Kang
Non dico addio
ATTUALITA'
-
La redazione
Pausa natalizia
-
Stefano Torossi
JEAN-PHILIPPE RAMEAU 1683 – 1764
-
Stefano Torossi
GIULIO BRICCIALDI 1818 – 1881
CLASSICI
CINEMA E MUSICA
-
Marco Minicangeli
La mia famiglia a Taipei
-
Marco Minicangeli
To a Land Unknow
-
Marco Minicangeli
Predator: Badlands
RACCONTI
-
Massimo Grisafi
Dondola dondola
-
Luca Alessandrini
Apres la pluie vient le beau temps
-
Leonello Ruberto
Mondo adulto