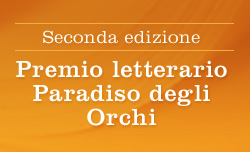RACCONTI
Giuseppe Bonaccorso
Lo svezzamento

Prima di iniziare è giusto premettere che questo racconto presenta elementi scabrosi e non velati da alcun artificio linguistico. Pertanto, coloro che hanno testa, bocca e orecchie completamente aperti e privi di filtri, possono continuare. Gli altri è meglio che abbandonino la lettura e riprovino magari con un altro racconto o in un diverso momento della loro vita.
Marco aveva nove anni e doveva ricevere il sacramento della prima confessione. I suoi genitori gli avevano presentato l’educazione religiosa come una normalità, un dovere che non pesa ad alcuno ma che giova per il benessere dello spirito. Marco aveva nove anni e sapeva solo, con un certo disappunto, di doversi presentare di fronte ad un prete per confessare, ovvero raccontare, per la prima volta i suoi peccati.
La catechista aveva preparato il gruppo distribuendo a tutti un breve opuscolo nel quale erano descritti i passi da seguire per un proficuo esame di coscienza.
Marco lo lesse due volte: il canovaccio era basato sui dieci comandamenti e sulla loro assurda pretesa di ergersi a legge universale. Egli non aveva mai rubato in vita sua (neppure qualche moneta dal borsellino della madre), non aveva ucciso se non forse qualche lucertola, rispettava i genitori perché non esisteva un’alternativa in proposito, santificava (a malincuore, questo è vero) le feste, non desiderava alcunché di appartenente ad altri (e in ciò il contributo maggiore era dato dalla sua condizione economica di benestante) e quindi, in definitiva, dopo aver sforzato l’immaginazione per non deludere le aspettative di chi lo avrebbe iniziato all’essere peccatore, capì di non aver idea di cosa raccontare al prete e cercò quindi di lavorare alacremente di fantasia.
Il giorno prestabilito, in quella sequenza molto simile alle vaccinazioni di gruppo, aveva la terza posizione. Quando venne il suo momento, si avvicinò al sacerdote, Padre E., un uomo alto e magrissimo, più simile agli scheletri dentro le teche che agli uomini veri, si inginocchiò così come deve fare ogni penitente (e già in quell’atto capì che il dolore alle ginocchia era un segno che la penitenza fosse molto più reale che simbolica) e ascoltò il blaterare e automatico confuso del vecchio. Alla fine capì soltanto il severo imperativo: “Raccontami tutti i tuoi peccati”.
“Ho commesso atti impuri” rispose Marco senza esitare ma cercando di parlare in modo sommesso perché Dio aveva sempre e comunque buone orecchie.
“Da solo o accompagnato?” lo incalzò subito, meccanico come una pressa industriale, Padre E.
Marco pensò a quelle strane parole e poi d’improvviso capì. “Da solo, padre” rispose mestamente.
“E’ molto grave quello che hai fatto” iniziò il sacerdote “San Paolo ci ha insegnato che il corpo è il tempio dello Spirito Santo e che bisogna trattarlo come una reliquia, con il rispetto del tabernacolo. Hai capito? Non devi mai più fare quelle cose!”
Marco si era masturbato la sera prima.
Aveva iniziato da poco. In genere non riusciva a raggiungere l’orgasmo, ma dopo qualche tentativo, aveva compreso che associando un’immagine di donna a quel gesto, tutto riusciva più semplice. Aveva pensato ad una supplente della quinta D, con il suo fare non da maestra ma da punitrice.
L’aveva vista nell’atto di costringerlo a denudarsi in uno stanzino per le scope e poi picchiarlo forte sul sedere. L’immagine l’aveva eccitato e, dopo qualche minuto aveva raggiunto l’orgasmo.
La prima volta era stato un momento stranissimo, l’esplosione di un mondo sconosciuto in una fase della vita in cui ormai si è certi di conoscere tutto. La seconda, la terza e così fino a quella volta, l’orgasmo era sempre stato il piacere senza spiegazioni. Un dono al di là di ogni logica ed etica: sia che i compiti fossero stati fatti a dovere, sia che invece tutto fosse andato male, sia che fosse da solo, che in compagnia, il suo piccolo pene restava sempre lì, pronto ad indurirsi e fare il suo nuovo dovere, anche in fretta e furia nel bagno d’un cinema.
“Ho capito…” rispose distrattamente al prete pensando che poco più tardi avrebbe potuto provare qualche nuovo gioco al computer.
“Se sei pentito, va’ e non peccare più” disse pomposamente Padre E. “E ricorda di recitare dieci Padre Nostro e dieci Ave Maria”. Dopo di ciò, lo licenziò.
Dubito che Padre E. non avesse mai avuto istinti erotici, ma per arrivare a quel genere di ripudio è necessario un lavoro non indifferente. Un uomo (anche se prete) d’altro stampo avrebbe certamente esclamato: “Marco, ti ho chiesto i peccati! Se non hai niente da dire, non farmi perdere tempo!”
Padre E. fece invece il suo dovere canonico e chiese a Marco di smettere di respirare, solo perché ad un fantomatico spirito impalpabile piaceva tanto farsi beffa dell’ossigeno così materiale. Parafrasando quanto scrisse Lacan: secondo Padre E., lo Spirito Santo doveva sloggiare la natura! Pur tuttavia, alla prossima boccata, indispensabile seppur piena di peccaminosi microbi, era ormai definita chiaramente la procedura: si andava dal prete, si riferiva tutto, si ascoltava una manfrina (sempre la stessa) e si recitavano meccanicamente delle preghiere rivolte alle mosche che volavano nella chiesa.
Ma permettetemi una digressione sul senso dell’aggettivo “accompagnato” in seno alla dottrina (antiquata) della chiesa. In effetti, guardandosi attorno all’interno del mondo cristiano, non si può non notare che ogni forma di “accompagnamento” è sempre l’accentuazione di una distanza naturale: si “accompagna” un feretro che, essendo trapassato è al di là di ogni possibile contatto. Si “accompagna” la liturgia con il canto; ma quest’ultimo esiste “sopra o sotto” una liturgia e mai accanto ad essa, poiché se così fosse, il valore andrebbe spostato sulle note e non più sul senso profondo delle parole. Il padre della sposa “accompagna” quest’ultima all’altare per distaccarsene definitivamente (e le lacrime non sono affatto rare in tali occasioni), così come il padrino o la madrina “accompagnano” il piccolo al fonte battesimale per far sì che esso, staccandosi dal suo stato peccaminoso, possa raggiungere la comunione spirituale.
E’ evidente, pertanto, che anche quando Padre E. chiese a Marco se i suoi atti impuri fossero stati o no “accompagnati”, intendeva (consciamente o inconsciamente) chiedere se essi avessero prodotto un’unione o una separazione. Cos’è dunque la masturbazione? E’ un atto che unisce o che separa? E, soprattutto, fare sesso “accompagnato” è davvero, secondo i canoni comuni, l’instaurazione di uno stato di non-separazione?
In termini molto più semplici, ma affatto inefficaci per lo scopo, Marco se lo chiese infruttuosamente mentre tornava correndo a casa.
L’interrogativo restò a lungo inevaso, soprattutto perché forse esso non ha davvero alcuna possibilità di ricevere una degna risposta al di fuori degli aspetti meccanici che, ovviamente, Marco comprendeva solo in termini di “assenza”. Egli immaginava la donna, ma non come fa l’uomo che l’ha già penetrata. Piuttosto ne considerava l’orma scavata nella sabbia, entro cui qualcosa, prima della sua consapevolezza (o a sua insaputa) aveva portato alla luce (ovvero, svelato) quel misterioso rituale. Così la camera dei genitori, ovvero il bordello più prossimo ad una culla, era “buia” durante la notte e il loro atto sessuale era consumato sempre e solo al di là della porta, in quell’oscurità che è, appunto, “ri-velata”, ovvero ricoperta e nascosti agli sguardi indiscreti. Egli poteva entrare di giorno nella stanza, ma non avrebbe scorto alcun segnale, se non un letto “grande” ove, forse, i due genitori si erano accoppiati. Una conchiglia vuota ove, appoggiando l’orecchio, si poteva ancora udire il rumore ritmico dell’oceano.
Il sesso, nella sua mirabolante valenza simbolica, era dunque per Marco proprio il letto vuoto, l’assenza o, tutt’al più la presenza solo di se stesso nella sua cameretta, il che, chiaramente, non differisce molto dal poetico ma intangibile “buio” ove i gemiti dei genitori, talvolta, si producevano come i canti d’un gruppo di ninfe.
Il suo primo contatto con la sessualità era avvenuto come normalmente accade a quasi tutti i ragazzini di quell’età: attraverso una rivista pornografica ritrovata in un campo non edificato e custodita dal gruppo come una reliquia in un luogo “segreto”.
Marco e i suoi amici di giochi la prendevano ogni pomeriggio, dopo i compiti, e, recatosi al riparo dagli sguardi indiscreti degli adulti, la sfogliavano sino a consumarne la carta. I più spacconi talvolta la sfogliavano di corsa e, trovata l’immagine giusta, strofinavano le vagine più grandi sul loro pube. Tutti gli altri associavano le parole scurrili (ma comuni) come “cazzo” o “minchia” ad un mondo sporco da cui tenersi alla larga. Ma così come le prese elettriche sono tanto pericolose quanto attraenti, quel giornale, con le sue immagini così “s-velate”, così dolcemente poste tra le braccia dei lettori, non poteva che mantenere alto sia il livello di pericolo, che quello afrodisiaco di piacere.
Le prime masturbazioni, come già detto, erano state infruttuose. Il godimento, di cui nella rivista si faceva un accenno spropositato, era qualcosa di ancora informe, perché, in fin dei conti, era informe l’immagine della donna, con quella sua parte tanto strana. Addirittura alcune immagini mostravano in primo piano i glutei allargati e molti compagni di Marco associarono essi al seno, pensando che la vagina si trovasse lì in mezzo, ma che fosse aperta solo nelle donne che non avevano ancora avuto figli. Subito dopo, tuttavia, essi si chiedevano come funzionasse la “ri-apertura”, visto che non erano pochi coloro che avevano fratelli e sorelle. Marco pensò che ad una certa età si chiedeva irreversibilmente e, visto che sua madre non era giovanissima ed egli era figlio unico, le sue possibilità di scorgere della peluria tra i seni di quella donna fossero scarsissime.
Per quella e per molte altre ragioni, Marco, con tutto il coraggio elargitogli da quell’esperienza, decise di fare un salto di qualità e chiese direttamente a sua madre delucidazioni sull’argomento.
Le si presentò con la spavalderia di un ragazzino di nove anni e le disse: “Sai, in cortile abbiamo trovato una di quelle riviste particolari…”
“Particolare, in che senso?” chiese la madre “Vorrai dire pornografica?”
Animato da quell’apparente stato di licenziosità, Marco aggiunse: “Certo… Ma tutti le guardano e a me non fa schifo… Io non sono come tanti…”
La donna lo guardò e annuì: “Certo”, disse, “Ed è anche giusto che tu sappia per bene certe cose… Credo che sia arrivato il momento”.
Per questa ragione, animata da sincera buona volontà ma essendo tutt’altro che una donna di mondo, decise di intraprendere la strada sicura della biologia e si procurò un libro ove venivano descritti in termini scientifici gli apparati genitali maschili e femminili.
Fu così che Marco, abituato a vagine in technicolor e “cazzi” di lunghezza spropositata, si ritrovò a contemplare con aria smarrita le illustrazioni caste di un vecchio libro per studenti delle scuole superiori post-fasciste. Gli sguardi gaudenti, le bocche spalancate nell’atto di mimare un incontenibile orgasmo, le eiaculazioni iridescenti e tutte le altre meraviglie che il tabù aveva reso tali, divennero descrizioni sterili di parti anatomiche senza senso.
“Quando un uomo e una donna si vogliono bene” incominciava sempre la madre “Possono fare l’amore, ovvero diventare una cosa sola”.
Quel leitmotiv così inutile (e, tra l’altro, ormai spoglio di ogni biologia) divenne il portabandiera del sesso e iniziò presto a lasciar manifestare le incongruenze palesi con quanto mostrato chiaramente dalla rivista sgualcita e nascosta sotto un sasso.
Tutte quelle coppie “si volevano bene”? Evidentemente no. Forse… Cosa c’entrava l’amore con il sesso? L’amore era cosa nota a Marco: si declinava nei modi talvolta più strani, ma era pur sempre amore, palese, luminoso, esposto alla luce del sole. Ciò che invece risultava nebuloso, nascosto, privo di quella sicurezza dell’esperienza era proprio il sesso. C’era necessariamente un’incongruenza, una voragine tra le parole di sua madre e la sua esperienza, e Marco, con una certa delusione, lo capì ben presto.
Avrebbe desiderato chiedere a sua madre di mostrargli sua vagina, ma sapeva che la risposta sarebbe stata negativa (seppur la storia di Edipo, letta anni dopo, avrebbe mostrato una trama ben differente). Così si limitò ad accettare la sua “saggezza” che lo differenziava dai compagni che ancora si domandavano dove fosse nascosta realmente la “fica”.
Scoprì il godimento durante un giorno di pioggia, nel primo pomeriggio. I suoi genitori erano entrambi fuori casa e Marco tentò di masturbarsi in modo diverso: prese una spugna leggermente umida (il cui colore assomigliava a quello rosato delle vagine vere) e iniziò a strofinarsi il piccolo pene, disteso beatamente sul letto. Per lungo tempo non accadde nulla. Poi, d’improvviso, così come deve succedere agli infartuati, provò una fortissima sensazione di calore, che dalla zona pelvica si espanse presto sino alla testa. Sentì un paio di scossoni improvvisi, come se qualcosa dentro di lui volesse uscire. Rimase immobile, col cuore accelerato e col fiato sospeso e, infine, dopo qualche secondo necessario al risveglio, il suo pene spinse fuori un paio di goccioline biancastre, proprio come quanto non riusciva a fare la pipì e restava fermo di fronte al gabinetto per alcuni minuti.
Accortosi di quella stranezza, si alzò di scatto: “Ecco” disse a voce alta “Lo sapevo! Questo è il godimento. Chissà cosa mi sarà successo…” e iniziò a preoccuparsi.
In realtà non gli era successo granché. I suoi testicoli e la sua prostata, non ancora avvezzi a quel lavoro poi così comune, avevano tardato e l’eiaculazione era stata fin troppo “secca”. Da quel momento, tuttavia, capì che il godimento non aveva molto da spartire con l’amore e che bastava lavorare di fantasia per poter ottenere qualcosa che fino a quel momento era rimasta sconosciuta e sopita tra le viscere del suo corpo.
Non parlò mai alla madre della sua attività masturbatoria sempre più frequente man mano che i giorni passavano, ma una volta, più per prenderla in giro che per reale curiosità, mentre si faceva il bagno, facendole notare lo sporco che si era formato tutt’attorno al glande, le chiese se esso fosse sperma.
La madre lo guardò stupita e un po’ accigliata, si fermò in preda al dubbio e poi d’istinto esclamò: “Ma che c’entra! Non dire stupidaggini”.
“Ma allora cos’è?” chiese Marco alludendo alla patina nel suo pene.
La madre evidentemente capì il contrario di ciò che il figlio desiderava, per cui iniziò la sua monotona filastrocca supponendo che lui l’avesse già dimenticata: “Ti ho già detto che quanto un uomo e una donna si vogliono bene…”
Il ragazzino la interruppe, come un professore universitario che si è stancato di ascoltare corbellerie: “No… Non dico quello. Intendo questo…“ e col dito si puntò il glande.
“Quella è semplicemente sporcizia!” tagliò corto la donna e tutto ebbe fine lì.
Restava tuttavia aperto un duplice problema: sembrava che il sesso fosse un atto intrinsecamente duale e ciò era stato confutato dalle banalissime esperienze di Marco; e, in secondo luogo, sempre in quella rivista, si parlava di “froci”, ovvero di uomini che cercavano altri uomini (più tardi imparò che l’equivalente femminile erano le “lesbiche”) e quindi il conto non tornava affatto.
Capì che quest’ultima era una situazione ben più misteriosa dell’ormai “conosciutissimo” sesso in seguito ad uno strano episodio che gli accadde nei mesi successivi.
Nella stessa parrocchia ove predicava Padre E., c’era un monaco di mezza età, Frate P., tarchiato e bassino, con un volto sempre rubicondo e gioviale. Era appassionato di elettronica spicciola e, forse troppo timido per allungare le mani su corpi femminili (che avrebbe potuto reperire a prezzi non eccessivi), cercava di prestare la sua opera di saggezza ai ragazzini che frequentavano il catechismo in quella parrocchia.
Non era un pedofilo, a meno che di vera “filia” non si desideri parlare. Era soltanto un uomo che, forse per povertà, forse per inettitudine, era finito in convento, con una veste dal tessuto urticante e una sfilza di voti di cui non capiva granché. Le sue maniere grossolane di approcciare gli argomenti sessuali svelavano quanto innocuo fosse il suo spirito e, probabilmente più per privazione personale, che per reale interesse aberrato, ogni tanto faceva domande indiscrete.
“Ormai stai entrando nella pubertà” disse una volta a Marco “Cominci ad avere peli neri attorno al genitale?”
“Sì” rispose senza vergogna il ragazzino “In cortile abbiamo anche trovato una rivista dove ci sono parecchie fotografie e mia madre mi ha insegnato tante cose che non capivo…”
Frate P. sorrise, come d’altronde faceva spesso: “E tu hai mai visto fare sesso?”
E’ evidente che una simile domanda, più che far gridare allo scandalo, dovrebbe far ridere di cuore chi l’ascolta, ma alcuni genitori, più bigotti che intelligenti, pensarono bene, dopo che tale interrogativo fu rivolto ripetutamente ai loro figli, di segnalare Frate P. alla curia, affinché fosse subito rimosso.
Forse, se tutti i preti pedofili fossero stati come quell’uomo, adesso avremmo solo ragazzini frustrati che, speranzosi di carpire qualche particolare scabroso, sarebbero tornati a casa con la coda tra le gambe, pensando che la domanda d’esame era fuori dalla loro portata. Ma purtroppo, il compito del tabù non è quello di precluderne l’accesso, ma di creare la predisposizione ad una nuova paura, paura che magari non avrà mai modo di presentarsi realmente.
Marco rispose mentendo: “Sì, una volta. Insieme a Filippo… In una macchina”
Non era vero, soprattutto considerando il fatto che disse anche di aver visto quell’autovettura peccaminosa in un luogo centralissimo, dove nessun pervertito si sarebbe mai sognato di fare nulla.
Frate P. gli credette (chissà se realmente, questa è solo una mia supposizione) e, lasciando emergere una “normale” tendenza in un uomo così castrato dall’infanzia, disse: “Quello si chiama coito anale”.
Marco non capì. Sapeva qual era il significato dell’aggettivo “anale” ma non riusciva a collegare l’atto sessuale con una sua variante che permetteva quella che poi scoprì essere l’omosessualità.
Lo disse a sua madre mentre questa stava terminando una telefonata. Lei fece un gesto schifato e, coprendo la cornetta del telefono, sussurrò: “Che porcherie! Poi ne parliamo… Adesso vatti a lavare le mani per il pranzo!”.
Successivamente spiegò che quello a cui si riferiva Frate P. era un atto da “malati” e che non aveva nulla a che vedere con l’amore genuino. Inoltre, tanto per rendere più credibile il suo atteggiamento, redarguì Marco per aver raccontato quelle panzane al frate, dandogli spago per le sue inaccettabili elucubrazioni.
“Ti ho già detto, Marco” esclamò la madre un po’ spazientita “E non farmelo più ripetere, che quando un uomo e una donna si vogliono bene, possono fare l’amore. Quello schifo di cui ti ha parlato Frate P. è una cosa dove non c’è alcuna forma d’amore”.
Come già detto in precedenza, tuttavia, al ragazzino interessava l’amore così come ad un adulto può far piacere avere una paghetta settimanale. Era il sesso, quello “strano”, ad attirare la sua attenzione, e il fatto che nell’atto “omosessuale” (parola troppo pesante per un poco più che bambino) non ci fosse amore, rendeva quella pratica, per quanto sgradevole, l’oggetto di una trasgressione ben più marcata.
Restava comunque pacifico che Marco odiasse profondamente le effusioni maschili. In particolare, Frate P., forse per le ragioni sopra-enunciate, forse per semplicioneria, “pretendeva” di essere sempre baciato sulla guancia.
Un amico di giochi, Rino, molto più “immaturo” di Marco, lo faceva con naturalezza, quasi ostentando un certo orgoglio. Quando erano insieme e incontravano il frate, Rino si avvicinava e lasciava schioccare le sue labbra sulla superficie quasi glabra di quelle enormi guance e Marco provava un forte disgusto per quella pratica. Così, quanto era il suo turno per salutare il frate, lo faceva accostando la sua guancia, così come normalmente si fa tra gli adulti.
“Rino mi bacia” disse una volta Frate P. “Ma tu no! L’ho notato, sai?”.
Marco nicchiò, inorridito da quella constatazione tanto ovvia quanto fuori luogo. Avrebbe baciato volentieri una donna giovane, magari affondando le sue labbra sulle guance o, addirittura, sulle stesse labbra di lei, ma con quel monaco lo sforzo era davvero notevole. Ci provò comunque.
La volta successiva lo baciò, notando il sorriso dipingersi sul volto inutile di quel mezzo uomo. Si fece schifo, ma dimenticò presto l’accaduto e si mise a chiacchierare di argomenti elettronici.
Una volta, prima della noiosissima funzione domenicale a cui la madre lo costringeva a partecipare, lasciò a Frate P. una rivista tecnica appena comprata. Era piena di circuiti e progetti vari e l’idea di poter avere un mentore che gli insegnasse qualche trucco, aveva galvanizzato il suo interesse a recarsi proprio quel giorno alla tediosissima messa delle undici e trenta.
Non appena la benedizione fu impartita e tutti iniziarono frettolosamente a lasciare la chiesa, Marco cercò subito Frate P. Lo trovò fuori, seduto su un gradone. Gli si avvicinò e gli chiese cosa ne pensasse dei progetti e degli articoli.
“Puoi realizzare il tester per batterie” rispose il frate “Io ne ho già uno ma per te sarà facile”.
“D’accordo, ma mi spieghi come funziona? Che cos’è esattamente un diodo?” chiese Marco impaziente delle risposte.
L’uomo lo guardò inespressivo. Evidentemente non sapeva bene neanche lui cosa rispondere, perciò decise di andare sul sicuro: “Ho notato che Rino è molto timido in fatto di sesso, dovresti parlargli tu, che invece sei parecchio più maturo…”.
Marco rimase un attimo spiazzato: “Io? E perché?”
“Perché ho notato che tu sai molte cose e dovresti dirle anche lui” fu la secca risposta.
Il ragazzino era andato dal frate solo per scoprire quale segreto permettesse a due led di lampeggiare o come funzionasse il misteriosissimo transistor e invece, ironia della sorte, gli toccava di dover impartire una lezione di sesso ad un compagno di giochi.
“Ho già parlato con Rino” disse il monaco sorridendo come un ebete “Ti ascolterà”.
Marco annuì e, vedendo l’amico avvicinarsi, si piegò a quello strano volere e cercò di appartarsi con Rino. Creò una commistione veloce tra quanto appreso dalla rivista pornografica e quanto raccontato dalla madre e glielo propinò senza esitazioni, sperando di poter poi godere del suo premio e poter quindi parlare di elettronica col frate.
Rino, a differenza di Marco, era sempre stato molto inibito di fronte alle immagini di rapporti sessuali espliciti, perché sua madre, donna tanto pia quanto ignorante, lo aveva liquidato dicendo: “E’ peccato” facendo leva sulla bonarietà del figlio. Quest’ultimo, quindi, si era deciso ad ascoltare qualcosa in proposito, solo perché un uomo di chiesa, detentore della legge divina, lo aveva invitato a farlo. Aveva quindi ascoltato Marco così come una vecchia pende dalle labbra del prete che, qualche giorno più in là, le darà l’estrema unzione e il codice d’accesso per il paradiso.
Quando tuttavia entrambi tornarono da Frate P., era quasi ora di pranzo e l’elettronica fu nuovamente subordinata ad un dovere ben più importante.
“Che palle!” esclamò Marco rivolgendosi a Rino “Volevo farmi spiegare come funziona quel circuito per radiocomandi!”
Entrambi, comunque, tra incerte immagini sessuali, diodi e sogni infranti, tornarono alle loro case per il doveroso pranzo domenicale e la giornata finì in quel modo così grottescamente insoddisfacente.
Dopo un po’ di tempo, Frate P. venne trasferito. Ovviamente le ragioni rimasero ignote ai più, ma era evidente che alcuni genitori, spaventati per quelle sgradevoli ingerenze, si fossero rivolti al vescovo minacciandolo di far esplodere una polveriera. Tutto era quindi tornato improvvisamente alla sua piatta normalità.
Marco approfondì i misteri del sesso così come (quasi) ogni altro ragazzino: tra ipotesi, spacconerie e film pornografici (un salto di qualità straordinario). Una volta comprò persino una compilation di giochi per computer in cui figurava il titolo “Porno Show”. Eccitatissimo corse a casa e caricò quel modesti programmino, roba da nulla rispetto all’evidenza dei cortometraggi reperiti qua e là.
Il gioco era basato su un’idea alquanto abusata nel campo videoludico: bisognava centrare una vagina in movimento con un pene che partiva dal basso dello schermo e raggiungeva la sua sommità. Chiaramente il divertimento era inesistente a parte il brivido dell’illecito che aveva provato all’atto dell’acquisto, preferendo quella cassetta ad un’altra con giochi forse molto più appassionanti.
Un altro giorno, invece, un compagno di scuola, anch’esso appassionato di computer, arrivato nel cortiletto dove si raccoglievano gli studenti, prese Marco sotto braccio e gli confidò: “Ho trovato un programma assurdo… Strip Poker. Tu giochi e ad ogni mano vinta, lei (l’avversario) si toglie una cosa, prima la camicetta, poi il reggiseno e poi…”
“E poi?” chiese Marco eccitato da quella commistione tra rischio e sessualità.
“E poi… dovrebbe levarsi tutto, ma io non ci sono ancora arrivato. Vince sempre il computer…”
Certo, l’ultima mano era sempre vinta dal computer, così da non poter mai arrivare a quel premio tanto ambito.
Ma di cosa si parlava realmente? Un’immagine a bassa risoluzione di una donna nuda: nulla in confronto alle vivide vagine turgide e ai peni da superdotati che comparivano nei film pornografici. Allora perché tanto interesse? La risposta è legata probabilmente al valore simbolico del sesso: la scoperta, l’ignoto che mai smette d’essere tale. Marco sapeva perfettamente (anche se da spettatore passivo) come era un vero apparato genitale femminile, ma ogni minimo dettaglio, aggiunto magari da un banalissimo programma per computer, aggiustava il tiro e rendeva più vasto quel panorama che non smetteva di vorticare su se stesso.
Così come quando, a casa d’una zia, Marco lesse qualche pagina di un libro ove si parlava di gravidanze e di metodi contraccettivi. In una pagina patinata, era riprodotta la fotografia di una donna con le gambe divaricate su un lettino ginecologico. Ovviamente ogni particolare era omesso, ma quella strana posizione, invitante come un abbraccio, lo colpì e lo lasciò fisso su quell’immagine in bianco e nero per diversi minuti, cercando di capire quale fosse il suo senso reale.
Quando tornò a masturbarsi, cosa che faceva ormai quasi quotidianamente, ripensò a quella strana posizione e un tremito gli percorse la schiena: lo sconosciuto aveva tolto un altro velo, proprio come la donna computerizzata dello Strip Poker.
La scoperta dei preservativi avvenne, invece, in modo molto più complicato. In farmacia aveva spesso visto quelle scatole colorate che talvolta raffiguravano delle coppie durante effusioni amorose e si era spesso chiesto cosa fossero. Dopo l’inaspettata “lectio magistralis” tenutagli da sua madre, si sentì forte a sufficiente per porre anche quell’annosa domanda.
La prima risposta fu evasiva: il tempo non permetteva una spiegazione approfondita. La seconda fu invece molto più proficua.
“Sono dei pezzi di plastica che l’uomo mette sul pene per non fecondare la donna” rispose la madre.
Marco li immaginò come dei piccoli tappi, ma ben presto di rese conto che quell’ipotesi era alquanto bizzarra. Allora spostò la sua immaginazione sulle bucce dei lupini e pensò che un profilattico fosse qualcosa di simile al prepuzio, che andava posizionato sopra il glande. Molto più tardi ne vide uno usato in strada e capì d’essersi sbagliato di grosso. Ancora una volta l’ignoto del sesso non gli aveva permesso di adagiarsi su convinzioni stantie.
Il resto della sua evoluzione sessuale non è degno di nota. Così come ogni ragazzo, superò le varie fasi dello sviluppo e conobbe il vero senso del piacere che non si consuma e che, al contrario della fame o della sete, viene talvolta accentuato proprio dalla sua consumazione.
Il resto della storia è davvero inutile. Dopo lo svezzamento, infatti, perfino i topi diventano commestibili e forse, chissà, anche quel misterioso piacere inizia suo malgrado ad omologarsi a sfilze di sapori preconfezionati.
Marco aveva nove anni e doveva ricevere il sacramento della prima confessione. I suoi genitori gli avevano presentato l’educazione religiosa come una normalità, un dovere che non pesa ad alcuno ma che giova per il benessere dello spirito. Marco aveva nove anni e sapeva solo, con un certo disappunto, di doversi presentare di fronte ad un prete per confessare, ovvero raccontare, per la prima volta i suoi peccati.
La catechista aveva preparato il gruppo distribuendo a tutti un breve opuscolo nel quale erano descritti i passi da seguire per un proficuo esame di coscienza.
Marco lo lesse due volte: il canovaccio era basato sui dieci comandamenti e sulla loro assurda pretesa di ergersi a legge universale. Egli non aveva mai rubato in vita sua (neppure qualche moneta dal borsellino della madre), non aveva ucciso se non forse qualche lucertola, rispettava i genitori perché non esisteva un’alternativa in proposito, santificava (a malincuore, questo è vero) le feste, non desiderava alcunché di appartenente ad altri (e in ciò il contributo maggiore era dato dalla sua condizione economica di benestante) e quindi, in definitiva, dopo aver sforzato l’immaginazione per non deludere le aspettative di chi lo avrebbe iniziato all’essere peccatore, capì di non aver idea di cosa raccontare al prete e cercò quindi di lavorare alacremente di fantasia.
Il giorno prestabilito, in quella sequenza molto simile alle vaccinazioni di gruppo, aveva la terza posizione. Quando venne il suo momento, si avvicinò al sacerdote, Padre E., un uomo alto e magrissimo, più simile agli scheletri dentro le teche che agli uomini veri, si inginocchiò così come deve fare ogni penitente (e già in quell’atto capì che il dolore alle ginocchia era un segno che la penitenza fosse molto più reale che simbolica) e ascoltò il blaterare e automatico confuso del vecchio. Alla fine capì soltanto il severo imperativo: “Raccontami tutti i tuoi peccati”.
“Ho commesso atti impuri” rispose Marco senza esitare ma cercando di parlare in modo sommesso perché Dio aveva sempre e comunque buone orecchie.
“Da solo o accompagnato?” lo incalzò subito, meccanico come una pressa industriale, Padre E.
Marco pensò a quelle strane parole e poi d’improvviso capì. “Da solo, padre” rispose mestamente.
“E’ molto grave quello che hai fatto” iniziò il sacerdote “San Paolo ci ha insegnato che il corpo è il tempio dello Spirito Santo e che bisogna trattarlo come una reliquia, con il rispetto del tabernacolo. Hai capito? Non devi mai più fare quelle cose!”
Marco si era masturbato la sera prima.
Aveva iniziato da poco. In genere non riusciva a raggiungere l’orgasmo, ma dopo qualche tentativo, aveva compreso che associando un’immagine di donna a quel gesto, tutto riusciva più semplice. Aveva pensato ad una supplente della quinta D, con il suo fare non da maestra ma da punitrice.
L’aveva vista nell’atto di costringerlo a denudarsi in uno stanzino per le scope e poi picchiarlo forte sul sedere. L’immagine l’aveva eccitato e, dopo qualche minuto aveva raggiunto l’orgasmo.
La prima volta era stato un momento stranissimo, l’esplosione di un mondo sconosciuto in una fase della vita in cui ormai si è certi di conoscere tutto. La seconda, la terza e così fino a quella volta, l’orgasmo era sempre stato il piacere senza spiegazioni. Un dono al di là di ogni logica ed etica: sia che i compiti fossero stati fatti a dovere, sia che invece tutto fosse andato male, sia che fosse da solo, che in compagnia, il suo piccolo pene restava sempre lì, pronto ad indurirsi e fare il suo nuovo dovere, anche in fretta e furia nel bagno d’un cinema.
“Ho capito…” rispose distrattamente al prete pensando che poco più tardi avrebbe potuto provare qualche nuovo gioco al computer.
“Se sei pentito, va’ e non peccare più” disse pomposamente Padre E. “E ricorda di recitare dieci Padre Nostro e dieci Ave Maria”. Dopo di ciò, lo licenziò.
Dubito che Padre E. non avesse mai avuto istinti erotici, ma per arrivare a quel genere di ripudio è necessario un lavoro non indifferente. Un uomo (anche se prete) d’altro stampo avrebbe certamente esclamato: “Marco, ti ho chiesto i peccati! Se non hai niente da dire, non farmi perdere tempo!”
Padre E. fece invece il suo dovere canonico e chiese a Marco di smettere di respirare, solo perché ad un fantomatico spirito impalpabile piaceva tanto farsi beffa dell’ossigeno così materiale. Parafrasando quanto scrisse Lacan: secondo Padre E., lo Spirito Santo doveva sloggiare la natura! Pur tuttavia, alla prossima boccata, indispensabile seppur piena di peccaminosi microbi, era ormai definita chiaramente la procedura: si andava dal prete, si riferiva tutto, si ascoltava una manfrina (sempre la stessa) e si recitavano meccanicamente delle preghiere rivolte alle mosche che volavano nella chiesa.
Ma permettetemi una digressione sul senso dell’aggettivo “accompagnato” in seno alla dottrina (antiquata) della chiesa. In effetti, guardandosi attorno all’interno del mondo cristiano, non si può non notare che ogni forma di “accompagnamento” è sempre l’accentuazione di una distanza naturale: si “accompagna” un feretro che, essendo trapassato è al di là di ogni possibile contatto. Si “accompagna” la liturgia con il canto; ma quest’ultimo esiste “sopra o sotto” una liturgia e mai accanto ad essa, poiché se così fosse, il valore andrebbe spostato sulle note e non più sul senso profondo delle parole. Il padre della sposa “accompagna” quest’ultima all’altare per distaccarsene definitivamente (e le lacrime non sono affatto rare in tali occasioni), così come il padrino o la madrina “accompagnano” il piccolo al fonte battesimale per far sì che esso, staccandosi dal suo stato peccaminoso, possa raggiungere la comunione spirituale.
E’ evidente, pertanto, che anche quando Padre E. chiese a Marco se i suoi atti impuri fossero stati o no “accompagnati”, intendeva (consciamente o inconsciamente) chiedere se essi avessero prodotto un’unione o una separazione. Cos’è dunque la masturbazione? E’ un atto che unisce o che separa? E, soprattutto, fare sesso “accompagnato” è davvero, secondo i canoni comuni, l’instaurazione di uno stato di non-separazione?
In termini molto più semplici, ma affatto inefficaci per lo scopo, Marco se lo chiese infruttuosamente mentre tornava correndo a casa.
L’interrogativo restò a lungo inevaso, soprattutto perché forse esso non ha davvero alcuna possibilità di ricevere una degna risposta al di fuori degli aspetti meccanici che, ovviamente, Marco comprendeva solo in termini di “assenza”. Egli immaginava la donna, ma non come fa l’uomo che l’ha già penetrata. Piuttosto ne considerava l’orma scavata nella sabbia, entro cui qualcosa, prima della sua consapevolezza (o a sua insaputa) aveva portato alla luce (ovvero, svelato) quel misterioso rituale. Così la camera dei genitori, ovvero il bordello più prossimo ad una culla, era “buia” durante la notte e il loro atto sessuale era consumato sempre e solo al di là della porta, in quell’oscurità che è, appunto, “ri-velata”, ovvero ricoperta e nascosti agli sguardi indiscreti. Egli poteva entrare di giorno nella stanza, ma non avrebbe scorto alcun segnale, se non un letto “grande” ove, forse, i due genitori si erano accoppiati. Una conchiglia vuota ove, appoggiando l’orecchio, si poteva ancora udire il rumore ritmico dell’oceano.
Il sesso, nella sua mirabolante valenza simbolica, era dunque per Marco proprio il letto vuoto, l’assenza o, tutt’al più la presenza solo di se stesso nella sua cameretta, il che, chiaramente, non differisce molto dal poetico ma intangibile “buio” ove i gemiti dei genitori, talvolta, si producevano come i canti d’un gruppo di ninfe.
Il suo primo contatto con la sessualità era avvenuto come normalmente accade a quasi tutti i ragazzini di quell’età: attraverso una rivista pornografica ritrovata in un campo non edificato e custodita dal gruppo come una reliquia in un luogo “segreto”.
Marco e i suoi amici di giochi la prendevano ogni pomeriggio, dopo i compiti, e, recatosi al riparo dagli sguardi indiscreti degli adulti, la sfogliavano sino a consumarne la carta. I più spacconi talvolta la sfogliavano di corsa e, trovata l’immagine giusta, strofinavano le vagine più grandi sul loro pube. Tutti gli altri associavano le parole scurrili (ma comuni) come “cazzo” o “minchia” ad un mondo sporco da cui tenersi alla larga. Ma così come le prese elettriche sono tanto pericolose quanto attraenti, quel giornale, con le sue immagini così “s-velate”, così dolcemente poste tra le braccia dei lettori, non poteva che mantenere alto sia il livello di pericolo, che quello afrodisiaco di piacere.
Le prime masturbazioni, come già detto, erano state infruttuose. Il godimento, di cui nella rivista si faceva un accenno spropositato, era qualcosa di ancora informe, perché, in fin dei conti, era informe l’immagine della donna, con quella sua parte tanto strana. Addirittura alcune immagini mostravano in primo piano i glutei allargati e molti compagni di Marco associarono essi al seno, pensando che la vagina si trovasse lì in mezzo, ma che fosse aperta solo nelle donne che non avevano ancora avuto figli. Subito dopo, tuttavia, essi si chiedevano come funzionasse la “ri-apertura”, visto che non erano pochi coloro che avevano fratelli e sorelle. Marco pensò che ad una certa età si chiedeva irreversibilmente e, visto che sua madre non era giovanissima ed egli era figlio unico, le sue possibilità di scorgere della peluria tra i seni di quella donna fossero scarsissime.
Per quella e per molte altre ragioni, Marco, con tutto il coraggio elargitogli da quell’esperienza, decise di fare un salto di qualità e chiese direttamente a sua madre delucidazioni sull’argomento.
Le si presentò con la spavalderia di un ragazzino di nove anni e le disse: “Sai, in cortile abbiamo trovato una di quelle riviste particolari…”
“Particolare, in che senso?” chiese la madre “Vorrai dire pornografica?”
Animato da quell’apparente stato di licenziosità, Marco aggiunse: “Certo… Ma tutti le guardano e a me non fa schifo… Io non sono come tanti…”
La donna lo guardò e annuì: “Certo”, disse, “Ed è anche giusto che tu sappia per bene certe cose… Credo che sia arrivato il momento”.
Per questa ragione, animata da sincera buona volontà ma essendo tutt’altro che una donna di mondo, decise di intraprendere la strada sicura della biologia e si procurò un libro ove venivano descritti in termini scientifici gli apparati genitali maschili e femminili.
Fu così che Marco, abituato a vagine in technicolor e “cazzi” di lunghezza spropositata, si ritrovò a contemplare con aria smarrita le illustrazioni caste di un vecchio libro per studenti delle scuole superiori post-fasciste. Gli sguardi gaudenti, le bocche spalancate nell’atto di mimare un incontenibile orgasmo, le eiaculazioni iridescenti e tutte le altre meraviglie che il tabù aveva reso tali, divennero descrizioni sterili di parti anatomiche senza senso.
“Quando un uomo e una donna si vogliono bene” incominciava sempre la madre “Possono fare l’amore, ovvero diventare una cosa sola”.
Quel leitmotiv così inutile (e, tra l’altro, ormai spoglio di ogni biologia) divenne il portabandiera del sesso e iniziò presto a lasciar manifestare le incongruenze palesi con quanto mostrato chiaramente dalla rivista sgualcita e nascosta sotto un sasso.
Tutte quelle coppie “si volevano bene”? Evidentemente no. Forse… Cosa c’entrava l’amore con il sesso? L’amore era cosa nota a Marco: si declinava nei modi talvolta più strani, ma era pur sempre amore, palese, luminoso, esposto alla luce del sole. Ciò che invece risultava nebuloso, nascosto, privo di quella sicurezza dell’esperienza era proprio il sesso. C’era necessariamente un’incongruenza, una voragine tra le parole di sua madre e la sua esperienza, e Marco, con una certa delusione, lo capì ben presto.
Avrebbe desiderato chiedere a sua madre di mostrargli sua vagina, ma sapeva che la risposta sarebbe stata negativa (seppur la storia di Edipo, letta anni dopo, avrebbe mostrato una trama ben differente). Così si limitò ad accettare la sua “saggezza” che lo differenziava dai compagni che ancora si domandavano dove fosse nascosta realmente la “fica”.
Scoprì il godimento durante un giorno di pioggia, nel primo pomeriggio. I suoi genitori erano entrambi fuori casa e Marco tentò di masturbarsi in modo diverso: prese una spugna leggermente umida (il cui colore assomigliava a quello rosato delle vagine vere) e iniziò a strofinarsi il piccolo pene, disteso beatamente sul letto. Per lungo tempo non accadde nulla. Poi, d’improvviso, così come deve succedere agli infartuati, provò una fortissima sensazione di calore, che dalla zona pelvica si espanse presto sino alla testa. Sentì un paio di scossoni improvvisi, come se qualcosa dentro di lui volesse uscire. Rimase immobile, col cuore accelerato e col fiato sospeso e, infine, dopo qualche secondo necessario al risveglio, il suo pene spinse fuori un paio di goccioline biancastre, proprio come quanto non riusciva a fare la pipì e restava fermo di fronte al gabinetto per alcuni minuti.
Accortosi di quella stranezza, si alzò di scatto: “Ecco” disse a voce alta “Lo sapevo! Questo è il godimento. Chissà cosa mi sarà successo…” e iniziò a preoccuparsi.
In realtà non gli era successo granché. I suoi testicoli e la sua prostata, non ancora avvezzi a quel lavoro poi così comune, avevano tardato e l’eiaculazione era stata fin troppo “secca”. Da quel momento, tuttavia, capì che il godimento non aveva molto da spartire con l’amore e che bastava lavorare di fantasia per poter ottenere qualcosa che fino a quel momento era rimasta sconosciuta e sopita tra le viscere del suo corpo.
Non parlò mai alla madre della sua attività masturbatoria sempre più frequente man mano che i giorni passavano, ma una volta, più per prenderla in giro che per reale curiosità, mentre si faceva il bagno, facendole notare lo sporco che si era formato tutt’attorno al glande, le chiese se esso fosse sperma.
La madre lo guardò stupita e un po’ accigliata, si fermò in preda al dubbio e poi d’istinto esclamò: “Ma che c’entra! Non dire stupidaggini”.
“Ma allora cos’è?” chiese Marco alludendo alla patina nel suo pene.
La madre evidentemente capì il contrario di ciò che il figlio desiderava, per cui iniziò la sua monotona filastrocca supponendo che lui l’avesse già dimenticata: “Ti ho già detto che quanto un uomo e una donna si vogliono bene…”
Il ragazzino la interruppe, come un professore universitario che si è stancato di ascoltare corbellerie: “No… Non dico quello. Intendo questo…“ e col dito si puntò il glande.
“Quella è semplicemente sporcizia!” tagliò corto la donna e tutto ebbe fine lì.
Restava tuttavia aperto un duplice problema: sembrava che il sesso fosse un atto intrinsecamente duale e ciò era stato confutato dalle banalissime esperienze di Marco; e, in secondo luogo, sempre in quella rivista, si parlava di “froci”, ovvero di uomini che cercavano altri uomini (più tardi imparò che l’equivalente femminile erano le “lesbiche”) e quindi il conto non tornava affatto.
Capì che quest’ultima era una situazione ben più misteriosa dell’ormai “conosciutissimo” sesso in seguito ad uno strano episodio che gli accadde nei mesi successivi.
Nella stessa parrocchia ove predicava Padre E., c’era un monaco di mezza età, Frate P., tarchiato e bassino, con un volto sempre rubicondo e gioviale. Era appassionato di elettronica spicciola e, forse troppo timido per allungare le mani su corpi femminili (che avrebbe potuto reperire a prezzi non eccessivi), cercava di prestare la sua opera di saggezza ai ragazzini che frequentavano il catechismo in quella parrocchia.
Non era un pedofilo, a meno che di vera “filia” non si desideri parlare. Era soltanto un uomo che, forse per povertà, forse per inettitudine, era finito in convento, con una veste dal tessuto urticante e una sfilza di voti di cui non capiva granché. Le sue maniere grossolane di approcciare gli argomenti sessuali svelavano quanto innocuo fosse il suo spirito e, probabilmente più per privazione personale, che per reale interesse aberrato, ogni tanto faceva domande indiscrete.
“Ormai stai entrando nella pubertà” disse una volta a Marco “Cominci ad avere peli neri attorno al genitale?”
“Sì” rispose senza vergogna il ragazzino “In cortile abbiamo anche trovato una rivista dove ci sono parecchie fotografie e mia madre mi ha insegnato tante cose che non capivo…”
Frate P. sorrise, come d’altronde faceva spesso: “E tu hai mai visto fare sesso?”
E’ evidente che una simile domanda, più che far gridare allo scandalo, dovrebbe far ridere di cuore chi l’ascolta, ma alcuni genitori, più bigotti che intelligenti, pensarono bene, dopo che tale interrogativo fu rivolto ripetutamente ai loro figli, di segnalare Frate P. alla curia, affinché fosse subito rimosso.
Forse, se tutti i preti pedofili fossero stati come quell’uomo, adesso avremmo solo ragazzini frustrati che, speranzosi di carpire qualche particolare scabroso, sarebbero tornati a casa con la coda tra le gambe, pensando che la domanda d’esame era fuori dalla loro portata. Ma purtroppo, il compito del tabù non è quello di precluderne l’accesso, ma di creare la predisposizione ad una nuova paura, paura che magari non avrà mai modo di presentarsi realmente.
Marco rispose mentendo: “Sì, una volta. Insieme a Filippo… In una macchina”
Non era vero, soprattutto considerando il fatto che disse anche di aver visto quell’autovettura peccaminosa in un luogo centralissimo, dove nessun pervertito si sarebbe mai sognato di fare nulla.
Frate P. gli credette (chissà se realmente, questa è solo una mia supposizione) e, lasciando emergere una “normale” tendenza in un uomo così castrato dall’infanzia, disse: “Quello si chiama coito anale”.
Marco non capì. Sapeva qual era il significato dell’aggettivo “anale” ma non riusciva a collegare l’atto sessuale con una sua variante che permetteva quella che poi scoprì essere l’omosessualità.
Lo disse a sua madre mentre questa stava terminando una telefonata. Lei fece un gesto schifato e, coprendo la cornetta del telefono, sussurrò: “Che porcherie! Poi ne parliamo… Adesso vatti a lavare le mani per il pranzo!”.
Successivamente spiegò che quello a cui si riferiva Frate P. era un atto da “malati” e che non aveva nulla a che vedere con l’amore genuino. Inoltre, tanto per rendere più credibile il suo atteggiamento, redarguì Marco per aver raccontato quelle panzane al frate, dandogli spago per le sue inaccettabili elucubrazioni.
“Ti ho già detto, Marco” esclamò la madre un po’ spazientita “E non farmelo più ripetere, che quando un uomo e una donna si vogliono bene, possono fare l’amore. Quello schifo di cui ti ha parlato Frate P. è una cosa dove non c’è alcuna forma d’amore”.
Come già detto in precedenza, tuttavia, al ragazzino interessava l’amore così come ad un adulto può far piacere avere una paghetta settimanale. Era il sesso, quello “strano”, ad attirare la sua attenzione, e il fatto che nell’atto “omosessuale” (parola troppo pesante per un poco più che bambino) non ci fosse amore, rendeva quella pratica, per quanto sgradevole, l’oggetto di una trasgressione ben più marcata.
Restava comunque pacifico che Marco odiasse profondamente le effusioni maschili. In particolare, Frate P., forse per le ragioni sopra-enunciate, forse per semplicioneria, “pretendeva” di essere sempre baciato sulla guancia.
Un amico di giochi, Rino, molto più “immaturo” di Marco, lo faceva con naturalezza, quasi ostentando un certo orgoglio. Quando erano insieme e incontravano il frate, Rino si avvicinava e lasciava schioccare le sue labbra sulla superficie quasi glabra di quelle enormi guance e Marco provava un forte disgusto per quella pratica. Così, quanto era il suo turno per salutare il frate, lo faceva accostando la sua guancia, così come normalmente si fa tra gli adulti.
“Rino mi bacia” disse una volta Frate P. “Ma tu no! L’ho notato, sai?”.
Marco nicchiò, inorridito da quella constatazione tanto ovvia quanto fuori luogo. Avrebbe baciato volentieri una donna giovane, magari affondando le sue labbra sulle guance o, addirittura, sulle stesse labbra di lei, ma con quel monaco lo sforzo era davvero notevole. Ci provò comunque.
La volta successiva lo baciò, notando il sorriso dipingersi sul volto inutile di quel mezzo uomo. Si fece schifo, ma dimenticò presto l’accaduto e si mise a chiacchierare di argomenti elettronici.
Una volta, prima della noiosissima funzione domenicale a cui la madre lo costringeva a partecipare, lasciò a Frate P. una rivista tecnica appena comprata. Era piena di circuiti e progetti vari e l’idea di poter avere un mentore che gli insegnasse qualche trucco, aveva galvanizzato il suo interesse a recarsi proprio quel giorno alla tediosissima messa delle undici e trenta.
Non appena la benedizione fu impartita e tutti iniziarono frettolosamente a lasciare la chiesa, Marco cercò subito Frate P. Lo trovò fuori, seduto su un gradone. Gli si avvicinò e gli chiese cosa ne pensasse dei progetti e degli articoli.
“Puoi realizzare il tester per batterie” rispose il frate “Io ne ho già uno ma per te sarà facile”.
“D’accordo, ma mi spieghi come funziona? Che cos’è esattamente un diodo?” chiese Marco impaziente delle risposte.
L’uomo lo guardò inespressivo. Evidentemente non sapeva bene neanche lui cosa rispondere, perciò decise di andare sul sicuro: “Ho notato che Rino è molto timido in fatto di sesso, dovresti parlargli tu, che invece sei parecchio più maturo…”.
Marco rimase un attimo spiazzato: “Io? E perché?”
“Perché ho notato che tu sai molte cose e dovresti dirle anche lui” fu la secca risposta.
Il ragazzino era andato dal frate solo per scoprire quale segreto permettesse a due led di lampeggiare o come funzionasse il misteriosissimo transistor e invece, ironia della sorte, gli toccava di dover impartire una lezione di sesso ad un compagno di giochi.
“Ho già parlato con Rino” disse il monaco sorridendo come un ebete “Ti ascolterà”.
Marco annuì e, vedendo l’amico avvicinarsi, si piegò a quello strano volere e cercò di appartarsi con Rino. Creò una commistione veloce tra quanto appreso dalla rivista pornografica e quanto raccontato dalla madre e glielo propinò senza esitazioni, sperando di poter poi godere del suo premio e poter quindi parlare di elettronica col frate.
Rino, a differenza di Marco, era sempre stato molto inibito di fronte alle immagini di rapporti sessuali espliciti, perché sua madre, donna tanto pia quanto ignorante, lo aveva liquidato dicendo: “E’ peccato” facendo leva sulla bonarietà del figlio. Quest’ultimo, quindi, si era deciso ad ascoltare qualcosa in proposito, solo perché un uomo di chiesa, detentore della legge divina, lo aveva invitato a farlo. Aveva quindi ascoltato Marco così come una vecchia pende dalle labbra del prete che, qualche giorno più in là, le darà l’estrema unzione e il codice d’accesso per il paradiso.
Quando tuttavia entrambi tornarono da Frate P., era quasi ora di pranzo e l’elettronica fu nuovamente subordinata ad un dovere ben più importante.
“Che palle!” esclamò Marco rivolgendosi a Rino “Volevo farmi spiegare come funziona quel circuito per radiocomandi!”
Entrambi, comunque, tra incerte immagini sessuali, diodi e sogni infranti, tornarono alle loro case per il doveroso pranzo domenicale e la giornata finì in quel modo così grottescamente insoddisfacente.
Dopo un po’ di tempo, Frate P. venne trasferito. Ovviamente le ragioni rimasero ignote ai più, ma era evidente che alcuni genitori, spaventati per quelle sgradevoli ingerenze, si fossero rivolti al vescovo minacciandolo di far esplodere una polveriera. Tutto era quindi tornato improvvisamente alla sua piatta normalità.
Marco approfondì i misteri del sesso così come (quasi) ogni altro ragazzino: tra ipotesi, spacconerie e film pornografici (un salto di qualità straordinario). Una volta comprò persino una compilation di giochi per computer in cui figurava il titolo “Porno Show”. Eccitatissimo corse a casa e caricò quel modesti programmino, roba da nulla rispetto all’evidenza dei cortometraggi reperiti qua e là.
Il gioco era basato su un’idea alquanto abusata nel campo videoludico: bisognava centrare una vagina in movimento con un pene che partiva dal basso dello schermo e raggiungeva la sua sommità. Chiaramente il divertimento era inesistente a parte il brivido dell’illecito che aveva provato all’atto dell’acquisto, preferendo quella cassetta ad un’altra con giochi forse molto più appassionanti.
Un altro giorno, invece, un compagno di scuola, anch’esso appassionato di computer, arrivato nel cortiletto dove si raccoglievano gli studenti, prese Marco sotto braccio e gli confidò: “Ho trovato un programma assurdo… Strip Poker. Tu giochi e ad ogni mano vinta, lei (l’avversario) si toglie una cosa, prima la camicetta, poi il reggiseno e poi…”
“E poi?” chiese Marco eccitato da quella commistione tra rischio e sessualità.
“E poi… dovrebbe levarsi tutto, ma io non ci sono ancora arrivato. Vince sempre il computer…”
Certo, l’ultima mano era sempre vinta dal computer, così da non poter mai arrivare a quel premio tanto ambito.
Ma di cosa si parlava realmente? Un’immagine a bassa risoluzione di una donna nuda: nulla in confronto alle vivide vagine turgide e ai peni da superdotati che comparivano nei film pornografici. Allora perché tanto interesse? La risposta è legata probabilmente al valore simbolico del sesso: la scoperta, l’ignoto che mai smette d’essere tale. Marco sapeva perfettamente (anche se da spettatore passivo) come era un vero apparato genitale femminile, ma ogni minimo dettaglio, aggiunto magari da un banalissimo programma per computer, aggiustava il tiro e rendeva più vasto quel panorama che non smetteva di vorticare su se stesso.
Così come quando, a casa d’una zia, Marco lesse qualche pagina di un libro ove si parlava di gravidanze e di metodi contraccettivi. In una pagina patinata, era riprodotta la fotografia di una donna con le gambe divaricate su un lettino ginecologico. Ovviamente ogni particolare era omesso, ma quella strana posizione, invitante come un abbraccio, lo colpì e lo lasciò fisso su quell’immagine in bianco e nero per diversi minuti, cercando di capire quale fosse il suo senso reale.
Quando tornò a masturbarsi, cosa che faceva ormai quasi quotidianamente, ripensò a quella strana posizione e un tremito gli percorse la schiena: lo sconosciuto aveva tolto un altro velo, proprio come la donna computerizzata dello Strip Poker.
La scoperta dei preservativi avvenne, invece, in modo molto più complicato. In farmacia aveva spesso visto quelle scatole colorate che talvolta raffiguravano delle coppie durante effusioni amorose e si era spesso chiesto cosa fossero. Dopo l’inaspettata “lectio magistralis” tenutagli da sua madre, si sentì forte a sufficiente per porre anche quell’annosa domanda.
La prima risposta fu evasiva: il tempo non permetteva una spiegazione approfondita. La seconda fu invece molto più proficua.
“Sono dei pezzi di plastica che l’uomo mette sul pene per non fecondare la donna” rispose la madre.
Marco li immaginò come dei piccoli tappi, ma ben presto di rese conto che quell’ipotesi era alquanto bizzarra. Allora spostò la sua immaginazione sulle bucce dei lupini e pensò che un profilattico fosse qualcosa di simile al prepuzio, che andava posizionato sopra il glande. Molto più tardi ne vide uno usato in strada e capì d’essersi sbagliato di grosso. Ancora una volta l’ignoto del sesso non gli aveva permesso di adagiarsi su convinzioni stantie.
Il resto della sua evoluzione sessuale non è degno di nota. Così come ogni ragazzo, superò le varie fasi dello sviluppo e conobbe il vero senso del piacere che non si consuma e che, al contrario della fame o della sete, viene talvolta accentuato proprio dalla sua consumazione.
Il resto della storia è davvero inutile. Dopo lo svezzamento, infatti, perfino i topi diventano commestibili e forse, chissà, anche quel misterioso piacere inizia suo malgrado ad omologarsi a sfilze di sapori preconfezionati.
CERCA
NEWS
-
22.02.2026
Nutrimenti
Antonio Moresco - Il finimondo -
22.02.2026
Sellerio
Dario Ferrari - L'idiota di famiglia -
22.02.2026
Adelphi
Henry James - Ormai non poteva succedere più nulla - Taccuini.
RECENSIONI
-
William Sloane
La porta dell’alba
-
Laura Imani Messina
Le parole della pioggia
-
Maurizio de Giovanni
L’orologiaio di Brest
ATTUALITA'
-
Stefano Torossi
Giovanni Bottesini 1821 - 1889
-
Stefano Torossi
GEORGE ANTHEIL 1900 – 1959
-
Stefano Torossi
I FRATELLI MARCELLO. Benedetto Marcello 1686 – 1739 Alessandro Marcello 1673 – 1747
CLASSICI
CINEMA E MUSICA
-
Marco Minicangeli
The Dangers in My Heart
-
Lorenzo Lombardi/Marco Minicangeli
28 anni dopo – Il tempio delle ossa.
-
Marco Minicangeli
La mia famiglia a Taipei
RACCONTI
-
Dauphine Potter
Summer, estate, summer summer.
-
Pietro Poltronieri
Sumud Flotilla
-
Eugenio Flajani Galli
Ciro e il Miracolo di S. Gennaro