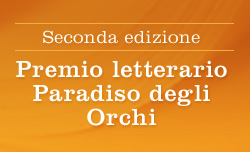CLASSICI
Alfredo Ronci
Ma cosa c’è di tanto strano? “Sillabari” di Goffredo Parise.
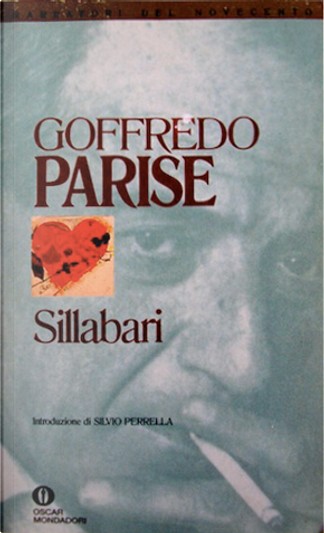
Avvertenza
Nella vita gli uomini fanno dei programmi perché sanno che, una volta scomparso l’autore, essi possono essere continuati da altri. In poesia è impossibile, non ci sono eredi. Così è toccato a me con questo libro: dodici anni fa giurai a me stesso, preso dalla mano della poesia, di scrivere tanti racconti sui sentimenti umani, così labili, partendo dalla A e arrivando alla Z. sono poesie in prosa. Ma alla lettera S, nonostante i programmi, la poesia mi ha abbandonato. E a questa lettera ho dovuto fermarmi. La poesia va e viene, vive e muore quando vuole lei, non quando vogliamo noi e non ha discendenti. Mi dispiace ma è così. Un poco come la vita, soprattutto come l’amore.
Gennaio 1982
Goffredo Parise.
Così concludeva lo scrittore, anzi, anticipava la seconda parte dei Sillabari. E su questa conclusione ci si sono fiondati commentatori e critici di ogni parte, non tanto per la parte in cui Parise parla delle poesie in prosa, quanto sul perché alla lettera S, nonostante i programmi, la poesia mi ha abbandonato.
Pensare che uno scrittore non possa più andare avanti perché la “sua” poesia si è prosciugata, mi sembra quasi un azzardo (anni fa mi capitò per le mani un libriccino delle edizioni “I quaderni di via del vento in cui venivano presentati tre racconti che non facevano parte né di Sillabario né di Sillabario 2, e il curatore non seppe darsi una risposta nemmeno per quello con il titolo di Politica che fu scritto nell’anno 1978, anno in cui fu ucciso Aldo Moro, ma che del politico prestigioso della Democrazia Cristiana non vi era traccia) anche perché rimanevano ben poche pagine da scrivere e soprattutto ben poche consonanti da terminare). No, la situazione, per quanto complessa, è invece la più facile e a dirlo sono alcuni intellettuali dell’epoca che hanno visto nella rinuncia di Parise ad andare avanti, un anticipo della morte che avvenne il 31 agosto 1986.
Ma come si collocano i Sillabari nella produzione letteraria dello scrittore? Ne abbiamo già parlato in precedenza (esattamente nella lettura de Il prete bello). Alcuni studiosi hanno diviso le opere in tre sezioni: la prima costituita dalla riscoperta, dopo vari anni, de Il ragazzo morto e le comete, la seconda da Il padrone, e la terza (ma si tralascia, e veramente non lo capiamo nemmeno oggi, appunto Il prete bello) da Sillabario e Sillabario 2 (radunati nei Sillabari, anche nelle edizioni che curiamo). Cosa ci racconta questa divisione? Ai giorni nostri non avrebbe sollevato alché ma, soprattutto negli anni settanta, si alzarono critiche a volte nemmeno oneste.
Tra gli altri giudizi ci “piace” riportare quello per cui Parise fosse considerato un poco di buono e addirittura reazionario. Ora, se proprio dovessimo appoggiarci all’opera dello scrittore, vediamo che tutto si può dire tranne che fosse un reazionario (ma erano o no gli anni settanta?). Da Il ragazzo morto e le comete (un unicum nella letteratura italiana: gli anni ’50 e tutto il neorealismo letterario e cinematografico divorato in un sol colpo) a Il prete bello (lo scegliamo noi perché è soprattutto un romanzo che appena sfiora il neorealismo, ma poi se lo mangia per strada) lo scrittore dipinge su sé stesso un’immagine della letteratura mai uguale a sé stessa, e nello stesso tempo liberata da un profondo senso di rifondazione.
Si chiede l’autore della introduzione di questa edizione Silvio Perrella: Ma si possono scrivere davvero delle storie naturali in pieno Novecento?
Non sappiamo bene cosa volesse dire di preciso Perrella, ma in ogni caso la risposta, per quanto generica, è sì: Parise aveva tutte le ragioni per scrivere delle storie naturali che, al contrario di quello che si disse quando uscirono i Sillabari, non contenevano nulla dell’anticamente vissuto (ma sarebbe anticamente vissuto le esperienze della guerra o, solo perché si era negli anni settanta, bisognava dar loro un tono più “moderno”?), né di una intimità che forse non piaceva (ma a noi tanto piace ricordare il ricordo che Parise fa dello scrittore Comisso: “I miei Amori d’Oriente, che libro!” e ancora fece un cenno di ammirazione golosa come si trattasse di cibo.), o del senso della vita che si esalta nel “provare” il latte di un neonato.
Sillabari non va riscoperto, come succede per gli incerti del mestiere. Va riassaporato racconto per racconto lasciando da parte gli errori di una generazione imbevuta del troppo.
L’edizione da noi considerata è:
Goffredo Parise
Sillabari
Oscar Mondadori
Nella vita gli uomini fanno dei programmi perché sanno che, una volta scomparso l’autore, essi possono essere continuati da altri. In poesia è impossibile, non ci sono eredi. Così è toccato a me con questo libro: dodici anni fa giurai a me stesso, preso dalla mano della poesia, di scrivere tanti racconti sui sentimenti umani, così labili, partendo dalla A e arrivando alla Z. sono poesie in prosa. Ma alla lettera S, nonostante i programmi, la poesia mi ha abbandonato. E a questa lettera ho dovuto fermarmi. La poesia va e viene, vive e muore quando vuole lei, non quando vogliamo noi e non ha discendenti. Mi dispiace ma è così. Un poco come la vita, soprattutto come l’amore.
Gennaio 1982
Goffredo Parise.
Così concludeva lo scrittore, anzi, anticipava la seconda parte dei Sillabari. E su questa conclusione ci si sono fiondati commentatori e critici di ogni parte, non tanto per la parte in cui Parise parla delle poesie in prosa, quanto sul perché alla lettera S, nonostante i programmi, la poesia mi ha abbandonato.
Pensare che uno scrittore non possa più andare avanti perché la “sua” poesia si è prosciugata, mi sembra quasi un azzardo (anni fa mi capitò per le mani un libriccino delle edizioni “I quaderni di via del vento in cui venivano presentati tre racconti che non facevano parte né di Sillabario né di Sillabario 2, e il curatore non seppe darsi una risposta nemmeno per quello con il titolo di Politica che fu scritto nell’anno 1978, anno in cui fu ucciso Aldo Moro, ma che del politico prestigioso della Democrazia Cristiana non vi era traccia) anche perché rimanevano ben poche pagine da scrivere e soprattutto ben poche consonanti da terminare). No, la situazione, per quanto complessa, è invece la più facile e a dirlo sono alcuni intellettuali dell’epoca che hanno visto nella rinuncia di Parise ad andare avanti, un anticipo della morte che avvenne il 31 agosto 1986.
Ma come si collocano i Sillabari nella produzione letteraria dello scrittore? Ne abbiamo già parlato in precedenza (esattamente nella lettura de Il prete bello). Alcuni studiosi hanno diviso le opere in tre sezioni: la prima costituita dalla riscoperta, dopo vari anni, de Il ragazzo morto e le comete, la seconda da Il padrone, e la terza (ma si tralascia, e veramente non lo capiamo nemmeno oggi, appunto Il prete bello) da Sillabario e Sillabario 2 (radunati nei Sillabari, anche nelle edizioni che curiamo). Cosa ci racconta questa divisione? Ai giorni nostri non avrebbe sollevato alché ma, soprattutto negli anni settanta, si alzarono critiche a volte nemmeno oneste.
Tra gli altri giudizi ci “piace” riportare quello per cui Parise fosse considerato un poco di buono e addirittura reazionario. Ora, se proprio dovessimo appoggiarci all’opera dello scrittore, vediamo che tutto si può dire tranne che fosse un reazionario (ma erano o no gli anni settanta?). Da Il ragazzo morto e le comete (un unicum nella letteratura italiana: gli anni ’50 e tutto il neorealismo letterario e cinematografico divorato in un sol colpo) a Il prete bello (lo scegliamo noi perché è soprattutto un romanzo che appena sfiora il neorealismo, ma poi se lo mangia per strada) lo scrittore dipinge su sé stesso un’immagine della letteratura mai uguale a sé stessa, e nello stesso tempo liberata da un profondo senso di rifondazione.
Si chiede l’autore della introduzione di questa edizione Silvio Perrella: Ma si possono scrivere davvero delle storie naturali in pieno Novecento?
Non sappiamo bene cosa volesse dire di preciso Perrella, ma in ogni caso la risposta, per quanto generica, è sì: Parise aveva tutte le ragioni per scrivere delle storie naturali che, al contrario di quello che si disse quando uscirono i Sillabari, non contenevano nulla dell’anticamente vissuto (ma sarebbe anticamente vissuto le esperienze della guerra o, solo perché si era negli anni settanta, bisognava dar loro un tono più “moderno”?), né di una intimità che forse non piaceva (ma a noi tanto piace ricordare il ricordo che Parise fa dello scrittore Comisso: “I miei Amori d’Oriente, che libro!” e ancora fece un cenno di ammirazione golosa come si trattasse di cibo.), o del senso della vita che si esalta nel “provare” il latte di un neonato.
Sillabari non va riscoperto, come succede per gli incerti del mestiere. Va riassaporato racconto per racconto lasciando da parte gli errori di una generazione imbevuta del troppo.
L’edizione da noi considerata è:
Goffredo Parise
Sillabari
Oscar Mondadori
CERCA
NEWS
-
4.01.2026
Rizzoli
Dan Brown -
4.01.2026
La nave di Teseo
Patricia Highsmith -
4.01.2026
Adelphi
C.S.Lewis
RECENSIONI
-
Matsumoto Seicho
Vangelo nero
-
Dolores Hitchens
La gatta ci ha messo lo zampino.
-
Anna Bailey
I nostri ultimi giorni selvaggi
ATTUALITA'
-
Stefano Torossi
Carl Maria von Weber 1786 - 1826
-
Stefano Torossi
ARRIGO BOITO 1842 - 1918
-
La redazione
Pausa natalizia
CLASSICI
CINEMA E MUSICA
-
Marco Minicangeli
La mia famiglia a Taipei
-
Marco Minicangeli
To a Land Unknow
-
Marco Minicangeli
Predator: Badlands
RACCONTI
-
Eugenio Flajani Galli
Ciro e il Miracolo di S. Gennaro
-
Massimo Grisafi
Dondola dondola
-
Luca Alessandrini
Apres la pluie vient le beau temps