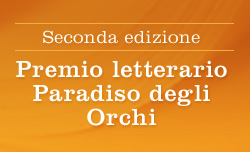Comincia a studiare a Cadice, dove è nato. La cittadina gli sta stretta e allora si trasferisce con la famiglia a Madrid. Qui subisce una sterzata verso la musica tradizionale spagnola, che poi darà il colore a tutta la sua produzione. Il responsabile è il musicologo Felipe Pedrell.
Debutta con la zarzuela, poi vince il concorso di composizione della Academia de Bellas Artes con l’opera “La vida breve”. Il premio è la messa in scena.
Niente messa in scena. Gli organizzatori latitano. De Falla si arrabbia, molla tutto e se ne va a Parigi, che in quegli anni è il centro della cultura nel mondo. Qui conosce Debussy, Ravel, Stravinskij e tutti gli artisti che si riuniscono nel famoso Circolo degli Apache, uno di quei covi dove nei periodi rivoluzionari nascono i nuovi movimenti intellettuali.
Passa gli anni della prima guerra mondiale a Madrid e poi a Granada. È amicissimo di Garcia Lorca e con lui fonda una compagnia teatrale.
Djagilev gli commissiona la musica per uno spettacolo, scenografie di Picasso, che debutta a Londra nel 1919. Così, con “Il Cappello a Tre Punte” entra in un gruppo davvero niente male: Borodin, Debussy, Ravel, Stravinskij, Satie, Milhaud, Strauss, Prokoviev, che hanno lavorato, stanno lavorando o lavoreranno per Djagilev.
<figure style="margin: 4px 20px 4px 0px; text-align: left; display: inline; max-width: 100%; width: auto; height: auto !important; position: relative; z-index: 1; float: left; " class="cc-imagewrapper cc-m-image-align-1"></figure>
Qui dobbiamo inserire due righe su questo personaggio responsabile di alcuni momenti fondamentali per la storia della musica e dello spettacolo: Sergej Pavlovic Djagilev.
“Djagilev aveva il genio di scoprire quello degli altri. Questo dono era talmente infallibile che si poteva credere che egli forgiasse il talento degli artisti”.
È gallerista e critico d’arte. Nel 1906 fa il colpo grosso con la mostra “Due secoli di arte russa” al Salon d’Automne di Parigi, che dà il via alla follia russofila di quegli anni e apre la strada alla sua nuova attività di organizzatore e direttore artistico di spettacoli di danza, con la fondazione, nel 1909, dei “Ballets Russes”.
È un fiorire di giovani ballerini, coreografi, pittori e musicisti a cui Djagilev commissiona lavori d’avanguardia che vanno in scena accompagnati da risse furibonde, scazzottate e sfide a duello, ma sempre con infallibile successo
Il primo è ”Danze Polovesiane” di Borodin. Segue Debussy con “Jeux” e “L’apres midi d’un faune”, Ravel con “Daphnis et Chloè”, Satie con “Parade”, Respighi con “La boutique fantasque”, eccetera eccetera. E naturalmente c’è l’incontro fondamentale (per tutti e due) con Stravinskij e i suoi tre esplosivi capolavori: “L’Uccello di Fuoco”, “Petruska” e la “Sagra della primavera”.
E per le scenografie chi chiama? Ragazzi di belle speranze: Picasso, Matisse, Braque, Mirò, Max Ernst, e i nostri De Chirico e Balla.
I danzatori, poi, sono un fatto a sé. Ogni rappresentazione è un lancio per nomi che rimarranno nella nostra memoria. Le ragazze: Anna Pavlova e Ida Rubinstein; i ballerini: Vaslav Nijinskij, Leonide Massine, Serge Lifar…
I suoi collaboratori lo ricordano come un inflessibile organizzatore, capace di terrorizzarli con un’occhiata, ma anche come un padre che mette le necessità della compagnia davanti alle proprie.
Nel 1929 Sergej Pavlovic muore quasi povero (la contabilità non è mai stata familiare a personaggi come lui) in una camera del lussuoso Hotel des Bains al Lido di Venezia. L’amica Coco Chanel si occupa di saldare i suoi conti in sospeso, di sicuro anche quello dell’albergo. È sepolto all’isola di San Michele, in Laguna, dove, qualche anno dopo gli terrà compagnia il suo Stravinskij.
Torniamo a De Falla.
Nel 1920, per la morte del suo caro amico, compone “Piece de guitarre ecrit pour le tombeau de Debussy”, un brano, eseguito in prima da Andres Segovia, che segna la nascita del repertorio per la chitarra moderna. Lo strumento, dimenticato alla fine dell’ottocento, torna di attualità proprio grazie a questa composizione che lo rimette al centro della scena.
Dopo la presa di potere del dittatore Franco, amareggiato dalla piega politica del suo paese, spaventato dalla violenza della guerra civile, addolorato per l’uccisione dell’amico Garcia Lorca approfitta di un invito per una serie di concerti organizzati dall’Istituto Spagnolo di Cultura e parte, nel 1939, con sua sorella per il Sud America, deciso a rimanerci.
E ci rimane, in Argentina, ad Alta Gracia, in una casa che ora è il Museo De Falla.
In Spagna non ci tornerà mai più.