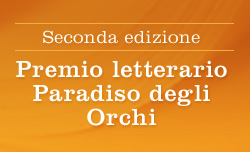CLASSICI
Alfredo Ronci
Quel che resta: “L’aria che respiri” di Luigi Davì.

Di questi tempi si dice sempre che, per far vendere un prodotto, in questo caso editoriale, gli esperti del settore se ne inventano di tutti i colori. Vero, non potremmo dire il contrario, ma anche nei lontani, e per alcuni, amatissimi anni sessanta, le cose non stavano diversamente. E perché lo diciamo? Un esempio lampante lo testimonia il libro che andiamo a proporre.
Diciamo che L’aria che respiri di Luigi Davì è una specie di puzzle, almeno stando a quanto viene sottolineato dalle note biografiche di Einaudi. Sì perché le pregiate edizioni ci avvertono che a parte Gymkhana -Cross antologia di ben quarantacinque racconti che Davì pubblicò nel ’56 nei Gettoni e che non è mai stata ripubblicata, il libro in questione raccoglie il meglio dello scrittore sin dagli esordi che avvennero alla fine degli anni quaranta (e che furono notati da Italo Calvino che si vantava di aver scoperto Davì) fino al breve romanzo Uno mandato da un tale che fu a sua volta pubblicato dall’edizione Parenti nel 1959 (ricordiamo che questa edizione che andiamo ad esaminare uscì per Einaudi nel 1964).
Giusto dire che Davì fu uno scrittore-operaio? Per certi versi sì, anche se negli ultimi periodi lavorava nel settore commerciale e viaggiava per conto di un’altra industria. Ma sentiamo di preciso cosa scriveva la casa editrice Einaudi sullo scrittore e soprattutto sul perché si insisteva sul promuoverlo:
La definizione di “scrittore-operaio”, anzi de “lo scrittore-operaio” della letteratura italiana per antonomasia, a Luigi Davì garba poco, e a ragione, se prendiamo la classificazione sociologica come una limitazione. Davì scrive perché è scrittore, scrittore fino alla radice dei capelli: il piacere delle parole, di riportare sulla carta le parole soltanto parlate, di mescolarle con le parole soltanto scritte, di vedere il guizzo diverso che prende una frase appena le si dà un certo snodo sintattico, una sospensione, un’inversione, una virgola, è un piacere che lui intende fin in fondo, e che sa comunicarci. (Guardate il racconto lungo “Paesi del vino” nient’altro che due giornate di bevute in compagnia di un giovanotto di città, ma tutto tenuto sullo slancio continuo di questa sua scrittura).
Ora vediamo noi cosa abbiamo colto, cominciando proprio da Paesi del vino, il racconto che apre l’antologia. Certo è vero, la trama si svolge tutta in due giorni di bevute e chiacchiere (il giovanotto, come dicono le note, è davvero “di città” ed ha una certa attrazione per una ragazza del posto) ma l’atmosfera che si coglie nel posto, il bucolico proliferare di situazioni contadine, sembra non intaccare l’idea del giovane. Tanto che la fine si traduce in… E’ tempo che io ritorni nel mondo.
Al centro vi è, non bisogna assolutamente dimenticarlo, lo stile della scrittura. Uno stile che per certi versi è a metà tra un post-realismo di facciata ed una nuova esposizione letteraria che invece cerca altre dimensioni, altre, permettetemi di dirlo, verità.
E questa “speciale” narrazione si ritrova, ben fatta, nel piccolo romanzo che conclude l’antologia, Uno mandato da un tale. Qui le cose, se vogliamo, sembrano complicarsi, perché davvero c’è uno stile che non azzarderemmo a dirlo neorealista, ma le situazioni, e ancor di più i mezzi, ce lo fanno vedere in tutt’altra direzione.
E’ la storia di un ragazzo, spaesato e sembra senza nessun contatto genitoriale, che si fa assumere, in un posto a lui sconosciuto, da uno sorta di ferraio che presto lo prende sotto le sue “regole” e apprezzando il fatto che lo ritenga uno da tenere in considerazione. E in questo luogo Uccio, così il nome, scopre alcune cose: Le macchine erano cinque e di tre ne conosceva i nomi: “fresatrice” quella subito vicino alla porta, “trapano” quella che serviva per forare, e “mola” quella che rendeva taglienti le punte da trapano. Ma la più grande delle macchine era una di fronte alla finestra che dava sulla strada e lunga quanto la stessa; era una macchina dissimile dalle altre: più bassa, più imponente, massiccia, con molte leve e maniglie (…). Sulla macchina notò, tornandola ad osservare, delle tabelle anch’esse irte di numeri e con parole come “diagramma”, “mandrino”, “ritardo”; e poi “Witworth”, “metrico-decimale”, “Acme”.
E’ chiaro che le macchine sono anche una sorta di divisione tra quello che c’era prima, che c’era sempre stato, e quello che poteva sembrare un futuro. In poche parole anche lo stile di Davì è così.
P.S. Per carità, non vorrei apparire antipatico, ma è normale che per titolare un’antologia, si scelga il racconto meno significativo? O forse lo hanno scelto perché tutte le altre “cose” avevano avuto già un titolo?
L’edizione da noi considerata è:
Luigi Davì
L’aria che respiri
Einaudi
Diciamo che L’aria che respiri di Luigi Davì è una specie di puzzle, almeno stando a quanto viene sottolineato dalle note biografiche di Einaudi. Sì perché le pregiate edizioni ci avvertono che a parte Gymkhana -Cross antologia di ben quarantacinque racconti che Davì pubblicò nel ’56 nei Gettoni e che non è mai stata ripubblicata, il libro in questione raccoglie il meglio dello scrittore sin dagli esordi che avvennero alla fine degli anni quaranta (e che furono notati da Italo Calvino che si vantava di aver scoperto Davì) fino al breve romanzo Uno mandato da un tale che fu a sua volta pubblicato dall’edizione Parenti nel 1959 (ricordiamo che questa edizione che andiamo ad esaminare uscì per Einaudi nel 1964).
Giusto dire che Davì fu uno scrittore-operaio? Per certi versi sì, anche se negli ultimi periodi lavorava nel settore commerciale e viaggiava per conto di un’altra industria. Ma sentiamo di preciso cosa scriveva la casa editrice Einaudi sullo scrittore e soprattutto sul perché si insisteva sul promuoverlo:
La definizione di “scrittore-operaio”, anzi de “lo scrittore-operaio” della letteratura italiana per antonomasia, a Luigi Davì garba poco, e a ragione, se prendiamo la classificazione sociologica come una limitazione. Davì scrive perché è scrittore, scrittore fino alla radice dei capelli: il piacere delle parole, di riportare sulla carta le parole soltanto parlate, di mescolarle con le parole soltanto scritte, di vedere il guizzo diverso che prende una frase appena le si dà un certo snodo sintattico, una sospensione, un’inversione, una virgola, è un piacere che lui intende fin in fondo, e che sa comunicarci. (Guardate il racconto lungo “Paesi del vino” nient’altro che due giornate di bevute in compagnia di un giovanotto di città, ma tutto tenuto sullo slancio continuo di questa sua scrittura).
Ora vediamo noi cosa abbiamo colto, cominciando proprio da Paesi del vino, il racconto che apre l’antologia. Certo è vero, la trama si svolge tutta in due giorni di bevute e chiacchiere (il giovanotto, come dicono le note, è davvero “di città” ed ha una certa attrazione per una ragazza del posto) ma l’atmosfera che si coglie nel posto, il bucolico proliferare di situazioni contadine, sembra non intaccare l’idea del giovane. Tanto che la fine si traduce in… E’ tempo che io ritorni nel mondo.
Al centro vi è, non bisogna assolutamente dimenticarlo, lo stile della scrittura. Uno stile che per certi versi è a metà tra un post-realismo di facciata ed una nuova esposizione letteraria che invece cerca altre dimensioni, altre, permettetemi di dirlo, verità.
E questa “speciale” narrazione si ritrova, ben fatta, nel piccolo romanzo che conclude l’antologia, Uno mandato da un tale. Qui le cose, se vogliamo, sembrano complicarsi, perché davvero c’è uno stile che non azzarderemmo a dirlo neorealista, ma le situazioni, e ancor di più i mezzi, ce lo fanno vedere in tutt’altra direzione.
E’ la storia di un ragazzo, spaesato e sembra senza nessun contatto genitoriale, che si fa assumere, in un posto a lui sconosciuto, da uno sorta di ferraio che presto lo prende sotto le sue “regole” e apprezzando il fatto che lo ritenga uno da tenere in considerazione. E in questo luogo Uccio, così il nome, scopre alcune cose: Le macchine erano cinque e di tre ne conosceva i nomi: “fresatrice” quella subito vicino alla porta, “trapano” quella che serviva per forare, e “mola” quella che rendeva taglienti le punte da trapano. Ma la più grande delle macchine era una di fronte alla finestra che dava sulla strada e lunga quanto la stessa; era una macchina dissimile dalle altre: più bassa, più imponente, massiccia, con molte leve e maniglie (…). Sulla macchina notò, tornandola ad osservare, delle tabelle anch’esse irte di numeri e con parole come “diagramma”, “mandrino”, “ritardo”; e poi “Witworth”, “metrico-decimale”, “Acme”.
E’ chiaro che le macchine sono anche una sorta di divisione tra quello che c’era prima, che c’era sempre stato, e quello che poteva sembrare un futuro. In poche parole anche lo stile di Davì è così.
P.S. Per carità, non vorrei apparire antipatico, ma è normale che per titolare un’antologia, si scelga il racconto meno significativo? O forse lo hanno scelto perché tutte le altre “cose” avevano avuto già un titolo?
L’edizione da noi considerata è:
Luigi Davì
L’aria che respiri
Einaudi
CERCA
NEWS
-
18.01.2026
Einaudi
Haiku al femminile -
18.01.2026
Sellerio
Davide Cammarone -
18.01.2026
La naven di Teseo
Christian Raimo
RECENSIONI
-
Luca Giommoni
Nero
-
Matsumoto Seicho
Vangelo nero
-
Dolores Hitchens
La gatta ci ha messo lo zampino.
ATTUALITA'
-
Stefano Torossi
I FRATELLI MARCELLO. Benedetto Marcello 1686 – 1739 Alessandro Marcello 1673 – 1747
-
Stefano Torossi
Carl Maria von Weber 1786 - 1826
-
Stefano Torossi
ARRIGO BOITO 1842 - 1918
CLASSICI
CINEMA E MUSICA
-
Lorenzo Lombardi/Marco Minicangeli
28 anni dopo – Il tempio delle ossa.
-
Marco Minicangeli
La mia famiglia a Taipei
-
Marco Minicangeli
To a Land Unknow
RACCONTI
-
Eugenio Flajani Galli
Ciro e il Miracolo di S. Gennaro
-
Massimo Grisafi
Dondola dondola
-
Luca Alessandrini
Apres la pluie vient le beau temps