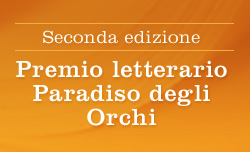CLASSICI
Alfredo Ronci
Una garbata raccontatrice del Novecento: “Ritratto in piedi” di Gianna Manzini.
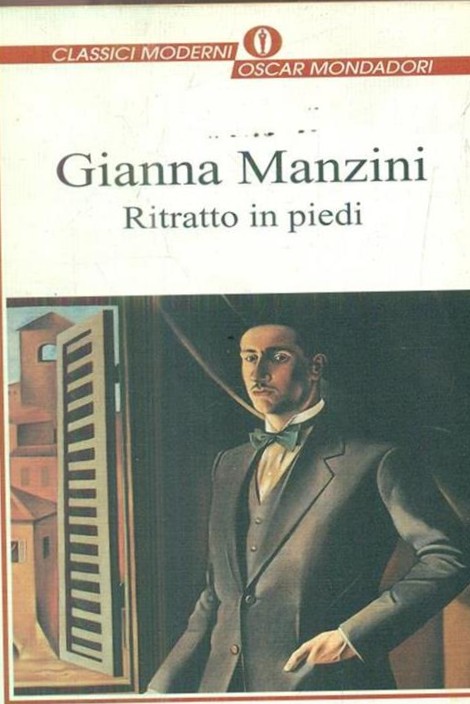
Scriveva Giacomo Debenedetti nel suo esemplare Intermezzo su Gianna Manzini: Gianna Manzini è un amalgama di istinto e di consapevolezza talmente straordinario, che persino il suo modo di accaparrarci, pure così accattivante, ci fa più volte temere di essere in difetto. Ci si affondi con lei nei meandri dell’istinto; si captino i messaggi dei nervi e del sangue, della voglia di vivere o degli umori in disordine, tutti quelli insomma che sembrano arrivarci solo quando riescono a frodare gli sbarramenti della ragione. Subito, nei viluppi di quelle complicità istintive, ci si sentirà sorvegliati, non si capisce se assistiti, o giudicati, dalla sua superiore consapevolezza.
Ora, di fronte a simile “esposizione” dovremmo lasciar andare qualsiasi altro giudizio, ed accogliere come definitivo la valutazione di Debenedetti. Però qualcosa bisogna pur dire.
La mia prima lettura di Ritratto in piedi risale a circa venti anni fa e allora dicevo: Sarà anche toccante, ma la continua “masturbazione” verbale e le noiose digressioni appesantiscono il testo oltre ogni misura. Forse è assolutamente vero che il metro migliore della Manzini è il componimento breve. Il racconto può racchiudere in sé anche il senso della meraviglia, che può essere della lingua; il romanzo soffre di asfissia.
Ora non voglio paragonare i due giudizi (ci mancherebbe altro), ma certamente tra le due esposizioni c’è qualcosa che non quadra, ma se dovessi essere sincero ora mi accosterei di più alle parole di Debenedetti che alle mie. E spiego anche il perché. E’ vero, nel romanzo ci sono troppi sconfinamenti, e spesso lo sono esclusivamente linguistici (bisogna pur dire che accusare la Manzini di sconfinamenti linguistici sarebbe condannarla a morte), ma nello stesso tempo questo scadenzario narrativo le permette di uscire da una letteratura troppo comune e invadente, e lanciarsi verso traguardi che si rifanno ai classici letterari.
Ecco cosa diceva la Manzini nell’Atto di contrizione che precede il Ritratto in piedi vero e proprio: Ebbene, in certi momenti, mentre mi provo a scrivere la vita del babbo, io sono quel cavallo, a metà dell’arcata del ponte. M’impenno. Non vado avanti. Addirittura torno indietro. Sconvolta? Tanto; ma non abbastanza. Infatti mi butto su un diverso lavoro; posso persino attirare su di me un malanno o una malattia; prometto; riprometto; ma con un senso di colpa, di struggimento, di pace perduta.
Ecco cosa dovrebbe percepire il lettore di fronte al ricordo del padre della Manzini: un senso di pace perduta, di un qualcosa che sembra sfuggire e che la stessa scrittrice non sa afferrare o stringere nemmeno quando è di fronte ai suoi resti mortali nel cimitero, e si lascia andare a considerazioni che sembrano non avere una realtà assoluta: … babbo io mi sostengo sulla tua morte.
Sull’arte della Manzini si è detto di tutto (compreso il Debenedetti), ma l’appunto che più ci convince è nell’introduzione all’edizione di questo romanzo dove si dice: Proprio i libri di racconti di questo periodo sono da registrare fra le cose migliori della scrittrice toscana, che nella misura breve trova, secondo molti interpreti, la forma più congeniale alla sua ispirazione. (Abbiamo cercato di capire chi fosse l’autore di questa tesi, ma non ci siamo riusciti).
Certo è vero, la Manzini è più efficace nel periodo breve, ma i suoi romanzi, e soprattutto questo romanzo, che secondo alcuni è da considerarsi invece la summa di tutta la produzione letteraria della scrittrice toscana, sono anche il risultato di un’indagine che nulla lascia al caso, nemmeno nell’accostamento ai classici del periodo.
E’ la storia di Giuseppe, il padre appunto della Manzini, anarchico convinto, che ben presto abbandonò la casa e che nel periodo fascista fu costretto a trascorrere gli ultimi anni in esilio a Cutignano, un paese delle montagne pistoiesi, dove morì nel 1925.
Apprezzato oltre misura dalla figlia (… Ora sono col babbo; sono fortissima. Non vi può essere maggiore allegrezza che questa d’aver capito il pensiero di lui.) è osteggiato invece dai parenti della moglie, provenienti da una famiglia borghese, di idee conservatrici (… Un fuorilegge, un avventuriero, un pericolo pubblico, una minaccia ambulante, un distruttore, un incendiario, un disastro…). La figlia comunque continuò a nutrire un affetto sincero che coltivò fino alla vecchiaia.
E da qui, cioè da questa assoluta unione col padre che nasce Ritratto in piedi, un romanzo su cui non vogliamo di nuovo polemizzare sulle capacità narrative della Manzini, ma solo ricordare di un’opera sentita e mai superficiale.
L’edizione da noi considerata è:
Gianna Manzini
Ritratto in piedi
Oscar Mondadori
Ora, di fronte a simile “esposizione” dovremmo lasciar andare qualsiasi altro giudizio, ed accogliere come definitivo la valutazione di Debenedetti. Però qualcosa bisogna pur dire.
La mia prima lettura di Ritratto in piedi risale a circa venti anni fa e allora dicevo: Sarà anche toccante, ma la continua “masturbazione” verbale e le noiose digressioni appesantiscono il testo oltre ogni misura. Forse è assolutamente vero che il metro migliore della Manzini è il componimento breve. Il racconto può racchiudere in sé anche il senso della meraviglia, che può essere della lingua; il romanzo soffre di asfissia.
Ora non voglio paragonare i due giudizi (ci mancherebbe altro), ma certamente tra le due esposizioni c’è qualcosa che non quadra, ma se dovessi essere sincero ora mi accosterei di più alle parole di Debenedetti che alle mie. E spiego anche il perché. E’ vero, nel romanzo ci sono troppi sconfinamenti, e spesso lo sono esclusivamente linguistici (bisogna pur dire che accusare la Manzini di sconfinamenti linguistici sarebbe condannarla a morte), ma nello stesso tempo questo scadenzario narrativo le permette di uscire da una letteratura troppo comune e invadente, e lanciarsi verso traguardi che si rifanno ai classici letterari.
Ecco cosa diceva la Manzini nell’Atto di contrizione che precede il Ritratto in piedi vero e proprio: Ebbene, in certi momenti, mentre mi provo a scrivere la vita del babbo, io sono quel cavallo, a metà dell’arcata del ponte. M’impenno. Non vado avanti. Addirittura torno indietro. Sconvolta? Tanto; ma non abbastanza. Infatti mi butto su un diverso lavoro; posso persino attirare su di me un malanno o una malattia; prometto; riprometto; ma con un senso di colpa, di struggimento, di pace perduta.
Ecco cosa dovrebbe percepire il lettore di fronte al ricordo del padre della Manzini: un senso di pace perduta, di un qualcosa che sembra sfuggire e che la stessa scrittrice non sa afferrare o stringere nemmeno quando è di fronte ai suoi resti mortali nel cimitero, e si lascia andare a considerazioni che sembrano non avere una realtà assoluta: … babbo io mi sostengo sulla tua morte.
Sull’arte della Manzini si è detto di tutto (compreso il Debenedetti), ma l’appunto che più ci convince è nell’introduzione all’edizione di questo romanzo dove si dice: Proprio i libri di racconti di questo periodo sono da registrare fra le cose migliori della scrittrice toscana, che nella misura breve trova, secondo molti interpreti, la forma più congeniale alla sua ispirazione. (Abbiamo cercato di capire chi fosse l’autore di questa tesi, ma non ci siamo riusciti).
Certo è vero, la Manzini è più efficace nel periodo breve, ma i suoi romanzi, e soprattutto questo romanzo, che secondo alcuni è da considerarsi invece la summa di tutta la produzione letteraria della scrittrice toscana, sono anche il risultato di un’indagine che nulla lascia al caso, nemmeno nell’accostamento ai classici del periodo.
E’ la storia di Giuseppe, il padre appunto della Manzini, anarchico convinto, che ben presto abbandonò la casa e che nel periodo fascista fu costretto a trascorrere gli ultimi anni in esilio a Cutignano, un paese delle montagne pistoiesi, dove morì nel 1925.
Apprezzato oltre misura dalla figlia (… Ora sono col babbo; sono fortissima. Non vi può essere maggiore allegrezza che questa d’aver capito il pensiero di lui.) è osteggiato invece dai parenti della moglie, provenienti da una famiglia borghese, di idee conservatrici (… Un fuorilegge, un avventuriero, un pericolo pubblico, una minaccia ambulante, un distruttore, un incendiario, un disastro…). La figlia comunque continuò a nutrire un affetto sincero che coltivò fino alla vecchiaia.
E da qui, cioè da questa assoluta unione col padre che nasce Ritratto in piedi, un romanzo su cui non vogliamo di nuovo polemizzare sulle capacità narrative della Manzini, ma solo ricordare di un’opera sentita e mai superficiale.
L’edizione da noi considerata è:
Gianna Manzini
Ritratto in piedi
Oscar Mondadori
CERCA
NEWS
-
4.01.2026
Rizzoli
Dan Brown -
4.01.2026
La nave di Teseo
Patricia Highsmith -
4.01.2026
Adelphi
C.S.Lewis
RECENSIONI
-
Matsumoto Seicho
Vangelo nero
-
Dolores Hitchens
La gatta ci ha messo lo zampino.
-
Anna Bailey
I nostri ultimi giorni selvaggi
ATTUALITA'
-
Stefano Torossi
Carl Maria von Weber 1786 - 1826
-
Stefano Torossi
ARRIGO BOITO 1842 - 1918
-
La redazione
Pausa natalizia
CLASSICI
CINEMA E MUSICA
-
Marco Minicangeli
La mia famiglia a Taipei
-
Marco Minicangeli
To a Land Unknow
-
Marco Minicangeli
Predator: Badlands
RACCONTI
-
Eugenio Flajani Galli
Ciro e il Miracolo di S. Gennaro
-
Massimo Grisafi
Dondola dondola
-
Luca Alessandrini
Apres la pluie vient le beau temps