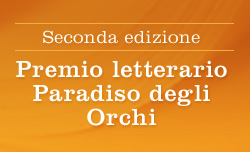RACCONTI
Massimiliano Città
Ania

Ania era una bambina dalla bellezza folgorante. Era venuta al mondo come un sospiro a rallegrare la vita dei genitori, per anni spenti in inutili tentativi d’allargare l’orizzonte della loro famiglia. Alfonso, attempato insegnante d’educazione musicale e Sandra, un tempo brillante mezzosoprano, entrambi discesi verso il declivio d’una grigia esistenza, avevano in un pomeriggio d’autunno risalito la china. Grazie a lei, la piccola Ania che, morbida come una candida nuvola bianca, s’era messa lì, cheta cheta al centro del piccolo focolare, a brillare di luce propria. Il padre la scrutava di continuo, come se ogni istante perduto ad osservare altro fosse vita sprecata. E adesso, dopo l’arrivo dell’angelo non c’era alcun motivo per lasciarsene sfuggire neppure un briciolo, come spesso gli era capitato di sperare. In casa Alessandri si respirava aria nuova, fresca, pulita. Come subito dopo una nevicata, tutto era privo di macchia, tutto doveva essere ripulito.
Il terzo ripiano del mobile libreria, un tempo alcova di vizi e ristori melanconici, era stato sgomberato con forza dalle numerose bottiglie mezze piene di whisky, dalle cartacce pentagrammate che contenevano giovanili velleità di contemporanee composizione, per dare spazio ad una ricchissima collezione digitale di musica.
Alfonso aveva spezzato in molte occasioni puntine di vecchi giradischi fino a restarsene in silenzio per la sala, accovacciato sul divano che divideva con la moglie, dolente e brilla come lui.
Quando, ancora incredula, Sandra gli aveva comunicato la lieta novella, era balenata un’idea nella mente di Alfonso, idea che tardò a realizzare, scaramantico fino all’osso qual’era. Soltanto quando le minuscole dita della sua creatura si levarono verso il cielo in cerca del suo volto pensò d’agire.
Grazie ad un amico, che era riuscito a sfondare le sue ultime resistenze, in verità esili, per condurlo in uno dei migliori rivenditori della città in fatto di impianti HI-FI, s’era dato completamente alla nuova tecnologia digitale in fatto di musica. Aveva voltato le spalle a tutte le reticenze del caso sul calore di un suono analogico, di cui anni addietro, agli albori di quelle fredde incisioni, s’era fatto portabandiera, finendo per essere tacciato quale anacronistico.
Vintage.
Aveva scelto il migliore in qualità, il peggiore in prezzo, ma adesso nella sua vita non c’era necessità di trattenere i risparmi da qualche parte, doveva investirli nel presente della sua Ania.
Fu con quell’idea frenetica, da realizzare nel più breve tempo possibile, che trascorse le ore pomeridiane. Erano le ore in cui, dopo notevoli battibecchi, Sandra lo invitava caldamente ad uscire un po’ di casa, e lui se ne andava a zonzo, per negozi musicali in cerca delle migliori esecuzioni dei capolavori della classica.
Non c’era dubbio, e in questo Sandra era completamente d’accordo, la piccola avrebbe scandito le sue ore cullata dalla bellezza dell’ingegno umano. L’unica ragione per cui la razza umana potesse esser detta umanità e non razza animale. Era stato da sempre il suo pensiero sulla musica, magari carpito senza attenzione a qualche saggio musicofilo, non avrebbe saputo riferirlo, ma era profondamente convito che soltanto la musica «umanizzasse» la razza.
Enfaticamente considerava quanto la bellezza di Mozart potesse resistere alla deflagrazione di Hiroshima, a distanza di tempo.
Sandra rimaneva in casa, e sorrideva, e parlava alla figlia in ogni occasione.
C’era vita in quell’abitazione, se ne poteva sentire la consistenza al tatto, l’aria ne era pregna.
E Sandra le parlava. Anche quando, alcuni metri distanti, s’industriava a preparare la cena, le raccontava per filo e per segno ogni suo movimento, ogni ingrediente aggiunto. Qualsiasi gesto era accompagnato da un commento, e il cuore le saliva in gola per l’emozione ogni qualvolta Ania, dal conforto della sua culla, provava a risponderle, a modo suo.
Fin dai primi vagiti, chiunque aveva avuto modo di guardarne i lineamenti aveva esclamato, a ragione: «sarà bellissima».
Già all’età di cinque anni era stata scelta, lei tra centinaia, per pubblicizzare una nota marca d’abbigliamento. Rimase icona per alcuni anni, fino a quando il cambiamento delle forme non spinse i pubblicitari a proporle un settore differente.
A quindici anni, già donna nelle fattezze, iniziò una lunga collaborazione con alcune tra le più prestigiose marche di intimo e costumi.
Ania faceva la modella senza sfilare, senza lo stress delle passerelle, evitando le morbose attenzioni della stampa scandalistica per le anoressiche vicissitudini quotidiane delle donne copertina.
Nonostante ciò finì in moltissime riviste di moda, e in un numero speciale dedicato all’estate 2006 occupò la prima pagina facendo impennare le vendite.
Si divideva tra set fotografici e la casa.
Il fortissimo legame con la madre era il suo porto sicuro, l’ancora che la tratteneva salda nella navigazione difficile del quotidiano. La voce della donna era il filo che ne conduceva i passi da quando aveva memoria. Non c’era bisogno di considerare, pensare più di tanto, le era necessario ascoltarla quella voce per affidarsi a lei completamente.
Erano cresciute in simbiosi, nel ricordo lontano delle parole del padre, troppo presto vinto da un male che ne aveva cancellato addirittura l’odore per tutta la casa.
Ma la musica era rimasta.
Talvolta, nelle sere di tempesta, Ania provava a ricostruirne il tono dei passi, i movimenti pesanti lungo il parquet del salotto. Provava a ricordare il profumo della sua pelle, quando con le mani grandi e calde le accarezzava il viso. Non aveva, invece, bisogno di ricostruire nella sua memoria il largo sorriso, che veniva spesso fuori nei suoi pensieri, fragoroso e allegro.
Nei terribili mesi che, repentini, trasformarono l’energia della madre in una flebile lampada ad intermittenza, provò per la prima volta in vita sua la felice sensazione d’essere utile a qualcuno. Sebbene il contesto le fosse assai doloroso, non si scoraggiò.
Fu accanto alla madre malata in ogni momento, diede buca a riviste e agenti che le avevano reso fino ad allora la vita brillante, dedicandosi completamente a mantenere ancora in vita il filo dei suoi passi. E si scoprì provetta cuoca, nonché amorevole infermiera.
Nella familiarità dell’ambiente casalingo sapeva bene dove mettere i suoi piedi diafani, si destreggiava leggera, quasi fosse una ballerina, negli spazi di quella abitazione congegnata negli anni affinché, già bambina sgambettante, non incontrasse nessun ostacolo lungo il cammino.
Fin da piccola aveva sviluppato una memoria ferrea, e tale qualità la sosteneva nelle incombenze quotidiane.
Aveva del resto, e da tempo, rifiutato qualsiasi altro aiuto che non fosse la voce della madre.
Quando la donna iniziò a faticare nelle parole, nei gesti, fino a distendersi vinta sul letto, affrontò gli eventi con una caparbietà di cui non era stata fino ad allora consapevole.
In fin dei conti, la straordinaria avvenenza che la natura le aveva donato facilitava il suo incedere nell’ombra.
A lungo i riflettori avevano puntato la sua pelle candida, scoprendone impudenti il corpo morbido e pieno d’armonia. A lungo corteggiatori con le tasche gonfie di quattrini e il cuore pieni di buchi l’avevano condotta nei migliori ristoranti, all’Opera perfino, vista la sua nota passione per la musica classica, nella speranza che ella concedesse quelle grazie ambite da molti.
Eppure lei, sorridente e gentile ad ogni invito, cordiale nell’intrattenersi in quelle serate, e piena di spirito, tanto da meravigliare gli astanti, congedava il corteggiatore di turno con un casto e delicato bacio sula guancia, nulla più.
La riluttanza ad intraprendere un legame sentimentale era profonda, e radicava in un’ancestrale paura, l’unica, che mai l’aveva abbandonata.
Il pensiero d’essere un gioiellino da mostrare al mondo, un diamante di cui fregiarsi fin quando tale, brillante all’eccesso, per poi essere lasciato in disparte, nella profonda oscurità dei suoi giorni, era l’ostacolo insormontabile. Il granitico muro che si frapponeva tra lei e il mondo.
Al ritorno da quelle serate, rientrava a casa con un senso d’angoscia che le cingeva la gola. Lasciava le scarpe, lanciandole sullo zerbino, all’ingresso, e poi contava.
Sì, contava.
Ferma, davanti l’immenso scaffale del salotto, le mani tremanti a livello del terzo ripiano.
Uno, due, tre, quattro, cinque ...diciotto.
In certe occasioni il numero diciotto le era di gran sollievo.
Estraeva il piccolo cofanetto, poi si voltava sulla destra, pochi passi e le dita accarezzavano il fronte del lettore stereo. Armeggiava con i pulsanti fino a quando un simpatico sospiro le indicava che il vano era pronto ad essere nutrito del suo solito pasto serale. Inseriva il compact e si distendeva sulla poltrona. Prendeva il telecomando in mano e, con inusuale destrezza, portava avanti il contatore delle traccie, fino alla numero 5. In quel punto esatto iniziava uno dei suoi brani preferiti, l’andante del concerto per pianoforte e orchestra di Mozart numero 21.
In quelle sere, in cui la melanconia l’avvinceva per tutte le membra, solleticandone fantasie che il buon profumo delle mani dell’ultimo corteggiatore aveva stimolato, si abbandonava infantile a giochi di pensiero. S’immaginava, come faceva da bambina, principessa solitaria vittima di un malefico incantesimo che, prima o poi, il meraviglioso principe, di qualsiasi colore potesse essere, sarebbe giunto trionfante a cancellare.
Sorrideva di sé e delle sue profonde fragilità, che negli ultimi tempi era riuscita a tramutare in vigore, quel vigore che ne sosteneva il cammino in una lotta senza quartiere. Combatteva contro vento la tormenta che aveva spazzato ogni sorriso in casa, compromettendo l’unica voce della sua vita. L’alter ego che sempre più stremata giaceva pressoché immobile nel suo letto, a pochi metri di distanza. Il suono delle melodie di Mozart cullava la madre dolente, senza riuscire, però, ad alleviarne la fine.
Quando la donna morì, all’improvviso tutta l’oscurità dei suoi 29 anni le piombò addosso, schiacciandole il viso per terra. E non fu un sentire metaforico, ma la sera stessa, in cui con veemenza scacciò tutti i parenti e lo sparuto gruppo d’amici che contava di rimanere ancora lì, quando decise, per la prima volta nella sua vita di rimanere sola, non appena richiuse l’uscio di quella casa, divenuta d’un tratto tomba delle sue memorie, inciampò, come non le accadeva da anni.Ania era una bambina dalla bellezza folgorante. Era venuta al mondo come un sospiro a rallegrare la vita dei genitori, per anni spenti in inutili tentativi d’allargare l’orizzonte della loro famiglia. Alfonso, attempato insegnante d’educazione musicale e Sandra, un tempo brillante mezzosoprano, entrambi discesi verso il declivio d’una grigia esistenza, avevano in un pomeriggio d’autunno risalito la china. Grazie a lei, la piccola Ania che, morbida come una candida nuvola bianca, s’era messa lì, cheta cheta al centro del piccolo focolare, a brillare di luce propria. Il padre la scrutava di continuo, come se ogni istante perduto ad osservare altro fosse vita sprecata. E adesso, dopo l’arrivo dell’angelo non c’era alcun motivo per lasciarsene sfuggire neppure un briciolo, come spesso gli era capitato di sperare. In casa Alessandri si respirava aria nuova, fresca, pulita. Come subito dopo una nevicata, tutto era privo di macchia, tutto doveva essere ripulito.
Il terzo ripiano del mobile libreria, un tempo alcova di vizi e ristori melanconici, era stato sgomberato con forza dalle numerose bottiglie mezze piene di whisky, dalle cartacce pentagrammate che contenevano giovanili velleità di contemporanee composizione, per dare spazio ad una ricchissima collezione digitale di musica.
Alfonso aveva spezzato in molte occasioni puntine di vecchi giradischi fino a restarsene in silenzio per la sala, accovacciato sul divano che divideva con la moglie, dolente e brilla come lui.
Quando, ancora incredula, Sandra gli aveva comunicato la lieta novella, era balenata un’idea nella mente di Alfonso, idea che tardò a realizzare, scaramantico fino all’osso qual’era. Soltanto quando le minuscole dita della sua creatura si levarono verso il cielo in cerca del suo volto pensò d’agire.
Grazie ad un amico, che era riuscito a sfondare le sue ultime resistenze, in verità esili, per condurlo in uno dei migliori rivenditori della città in fatto di impianti HI-FI, s’era dato completamente alla nuova tecnologia digitale in fatto di musica. Aveva voltato le spalle a tutte le reticenze del caso sul calore di un suono analogico, di cui anni addietro, agli albori di quelle fredde incisioni, s’era fatto portabandiera, finendo per essere tacciato quale anacronistico.
Vintage.
Aveva scelto il migliore in qualità, il peggiore in prezzo, ma adesso nella sua vita non c’era necessità di trattenere i risparmi da qualche parte, doveva investirli nel presente della sua Ania.
Fu con quell’idea frenetica, da realizzare nel più breve tempo possibile, che trascorse le ore pomeridiane. Erano le ore in cui, dopo notevoli battibecchi, Sandra lo invitava caldamente ad uscire un po’ di casa, e lui se ne andava a zonzo, per negozi musicali in cerca delle migliori esecuzioni dei capolavori della classica.
Non c’era dubbio, e in questo Sandra era completamente d’accordo, la piccola avrebbe scandito le sue ore cullata dalla bellezza dell’ingegno umano. L’unica ragione per cui la razza umana potesse esser detta umanità e non razza animale. Era stato da sempre il suo pensiero sulla musica, magari carpito senza attenzione a qualche saggio musicofilo, non avrebbe saputo riferirlo, ma era profondamente convito che soltanto la musica «umanizzasse» la razza.
Enfaticamente considerava quanto la bellezza di Mozart potesse resistere alla deflagrazione di Hiroshima, a distanza di tempo.
Sandra rimaneva in casa, e sorrideva, e parlava alla figlia in ogni occasione.
C’era vita in quell’abitazione, se ne poteva sentire la consistenza al tatto, l’aria ne era pregna.
E Sandra le parlava. Anche quando, alcuni metri distanti, s’industriava a preparare la cena, le raccontava per filo e per segno ogni suo movimento, ogni ingrediente aggiunto. Qualsiasi gesto era accompagnato da un commento, e il cuore le saliva in gola per l’emozione ogni qualvolta Ania, dal conforto della sua culla, provava a risponderle, a modo suo.
Fin dai primi vagiti, chiunque aveva avuto modo di guardarne i lineamenti aveva esclamato, a ragione: «sarà bellissima».
Già all’età di cinque anni era stata scelta, lei tra centinaia, per pubblicizzare una nota marca d’abbigliamento. Rimase icona per alcuni anni, fino a quando il cambiamento delle forme non spinse i pubblicitari a proporle un settore differente.
A quindici anni, già donna nelle fattezze, iniziò una lunga collaborazione con alcune tra le più prestigiose marche di intimo e costumi.
Ania faceva la modella senza sfilare, senza lo stress delle passerelle, evitando le morbose attenzioni della stampa scandalistica per le anoressiche vicissitudini quotidiane delle donne copertina.
Nonostante ciò finì in moltissime riviste di moda, e in un numero speciale dedicato all’estate 2006 occupò la prima pagina facendo impennare le vendite.
Si divideva tra set fotografici e la casa.
Il fortissimo legame con la madre era il suo porto sicuro, l’ancora che la tratteneva salda nella navigazione difficile del quotidiano. La voce della donna era il filo che ne conduceva i passi da quando aveva memoria. Non c’era bisogno di considerare, pensare più di tanto, le era necessario ascoltarla quella voce per affidarsi a lei completamente.
Erano cresciute in simbiosi, nel ricordo lontano delle parole del padre, troppo presto vinto da un male che ne aveva cancellato addirittura l’odore per tutta la casa.
Ma la musica era rimasta.
Talvolta, nelle sere di tempesta, Ania provava a ricostruirne il tono dei passi, i movimenti pesanti lungo il parquet del salotto. Provava a ricordare il profumo della sua pelle, quando con le mani grandi e calde le accarezzava il viso. Non aveva, invece, bisogno di ricostruire nella sua memoria il largo sorriso, che veniva spesso fuori nei suoi pensieri, fragoroso e allegro.
Nei terribili mesi che, repentini, trasformarono l’energia della madre in una flebile lampada ad intermittenza, provò per la prima volta in vita sua la felice sensazione d’essere utile a qualcuno. Sebbene il contesto le fosse assai doloroso, non si scoraggiò.
Fu accanto alla madre malata in ogni momento, diede buca a riviste e agenti che le avevano reso fino ad allora la vita brillante, dedicandosi completamente a mantenere ancora in vita il filo dei suoi passi. E si scoprì provetta cuoca, nonché amorevole infermiera.
Nella familiarità dell’ambiente casalingo sapeva bene dove mettere i suoi piedi diafani, si destreggiava leggera, quasi fosse una ballerina, negli spazi di quella abitazione congegnata negli anni affinché, già bambina sgambettante, non incontrasse nessun ostacolo lungo il cammino.
Fin da piccola aveva sviluppato una memoria ferrea, e tale qualità la sosteneva nelle incombenze quotidiane.
Aveva del resto, e da tempo, rifiutato qualsiasi altro aiuto che non fosse la voce della madre.
Quando la donna iniziò a faticare nelle parole, nei gesti, fino a distendersi vinta sul letto, affrontò gli eventi con una caparbietà di cui non era stata fino ad allora consapevole.
In fin dei conti, la straordinaria avvenenza che la natura le aveva donato facilitava il suo incedere nell’ombra.
A lungo i riflettori avevano puntato la sua pelle candida, scoprendone impudenti il corpo morbido e pieno d’armonia. A lungo corteggiatori con le tasche gonfie di quattrini e il cuore pieni di buchi l’avevano condotta nei migliori ristoranti, all’Opera perfino, vista la sua nota passione per la musica classica, nella speranza che ella concedesse quelle grazie ambite da molti.
Eppure lei, sorridente e gentile ad ogni invito, cordiale nell’intrattenersi in quelle serate, e piena di spirito, tanto da meravigliare gli astanti, congedava il corteggiatore di turno con un casto e delicato bacio sula guancia, nulla più.
La riluttanza ad intraprendere un legame sentimentale era profonda, e radicava in un’ancestrale paura, l’unica, che mai l’aveva abbandonata.
Il pensiero d’essere un gioiellino da mostrare al mondo, un diamante di cui fregiarsi fin quando tale, brillante all’eccesso, per poi essere lasciato in disparte, nella profonda oscurità dei suoi giorni, era l’ostacolo insormontabile. Il granitico muro che si frapponeva tra lei e il mondo.
Al ritorno da quelle serate, rientrava a casa con un senso d’angoscia che le cingeva la gola. Lasciava le scarpe, lanciandole sullo zerbino, all’ingresso, e poi contava.
Sì, contava.
Ferma, davanti l’immenso scaffale del salotto, le mani tremanti a livello del terzo ripiano.
Uno, due, tre, quattro, cinque ...diciotto.
In certe occasioni il numero diciotto le era di gran sollievo.
Estraeva il piccolo cofanetto, poi si voltava sulla destra, pochi passi e le dita accarezzavano il fronte del lettore stereo. Armeggiava con i pulsanti fino a quando un simpatico sospiro le indicava che il vano era pronto ad essere nutrito del suo solito pasto serale. Inseriva il compact e si distendeva sulla poltrona. Prendeva il telecomando in mano e, con inusuale destrezza, portava avanti il contatore delle traccie, fino alla numero 5. In quel punto esatto iniziava uno dei suoi brani preferiti, l’andante del concerto per pianoforte e orchestra di Mozart numero 21.
In quelle sere, in cui la melanconia l’avvinceva per tutte le membra, solleticandone fantasie che il buon profumo delle mani dell’ultimo corteggiatore aveva stimolato, si abbandonava infantile a giochi di pensiero. S’immaginava, come faceva da bambina, principessa solitaria vittima di un malefico incantesimo che, prima o poi, il meraviglioso principe, di qualsiasi colore potesse essere, sarebbe giunto trionfante a cancellare.
Sorrideva di sé e delle sue profonde fragilità, che negli ultimi tempi era riuscita a tramutare in vigore, quel vigore che ne sosteneva il cammino in una lotta senza quartiere. Combatteva contro vento la tormenta che aveva spazzato ogni sorriso in casa, compromettendo l’unica voce della sua vita. L’alter ego che sempre più stremata giaceva pressoché immobile nel suo letto, a pochi metri di distanza. Il suono delle melodie di Mozart cullava la madre dolente, senza riuscire, però, ad alleviarne la fine.
Quando la donna morì, all’improvviso tutta l’oscurità dei suoi 29 anni le piombò addosso, schiacciandole il viso per terra. E non fu un sentire metaforico, ma la sera stessa, in cui con veemenza scacciò tutti i parenti e lo sparuto gruppo d’amici che contava di rimanere ancora lì, quando decise, per la prima volta nella sua vita di rimanere sola, non appena richiuse l’uscio di quella casa, divenuta d’un tratto tomba delle sue memorie, inciampò, come non le accadeva da anni.
Finì distesa per terra lungo il freddo parquet, e lì rimase per tutta la notte, bagnando il legno di lacrime e morsi.
Non furono i raggi del primo mattino a scoprirla sola, così come non era mai accaduto nei giorni precedenti che le luci dell’alba la destassero dal sonno profondo, ma come sempre fu il suono del nuovo giorno a svegliarla.
E il giorno si fece nel frastuono di un martello pneumatico che, senza alcun ritegno, penetrò nella sua mente confusa, richiamandola ad alzarsi.
Anche il più cinico tra gli uomini avrebbe provato un sentimento di commozione se avesse assistito alla scena.
Indolenzita, tanto nell’animo quanto nel corpo, per quella notte in cui sogno e veglia s’alternavano senza sosta, con le esili membra schiacciate nel freddo di un pavimento che aveva perduto la voce e l’odore della madre, Ania provò più volte a rimettersi in sesto.
Nel volgere della notte, l’oscurità che l’aveva abbracciata dalla nascita, verso la quale aveva sempre opposto lo splendore della sua bellezza, parve stringerla, comprimerla.
Conati di vomito risalivano lenti per il collo affusolato che molti avevano sognato di accarezzare con le labbra.
E le labbra stesse bruciavano di un sapore amaro che sapeva di silenzio.
Non appena riuscì a ritrovare l’orientamento si accasciò disperata sulla poltrona.
Diventava sempre più consapevole che non era stata la cecità, inseparabile compagna di vita, a piegarle il respiro gettandola per terra la notte prima, ma l’improvvisa solitudine.
A quella non era in grado di far fronte.
Il viso, che mesi prima decine di riviste s’erano contesi, adesso era devastato. Rigagnoli di lacrime venivano fuori in maniera incessante e affondavano sulla pelle morbida come graffi di gatte in calore. Gli occhi gonfi, lucidi, rossi, avevano completamente nascosto l’aspetto angelico.
Ania non poteva vedersi, eppure vedeva tutto, e in quel tutto, che s’era ridotto a melanconico nulla, non scorgeva modo di rialzarsi.
Rimase seduta sulla poltrona per l’intera giornata.
Il petto florido, a stento contenuto dagli arditi costumi che in serie aveva indossato, rendendoli appetibili alle casalinghe in cerca di frivolezze, si sollevava a stento, in una respirazione discreta.
Talvolta un rigurgito di singulto veniva su, traditore, e allora, sempre senza far rumore, le lacrime ritornavano a solcarle il viso.
Il tempo della sua esistenza era stato scandito dalle voci dei suoi affetti, sopratutto dal timbro delicato e caldo di Sandra, che poche volte aveva chiamato mamma.
Ania e Sandra, due amiche, generazioni differenti che affrontavano l’oscurità del mondo, l’una accanto all’altra. E in quella simbiosi tutto appariva loro più lieve.
Anche nei primi tempi della malattia, quando la madre ancora aveva la forza di sostenere la sua condizione, il sorriso spazzava via, come spugna su vetro, le macchie della sofferenza.
Adesso?
Chi la svegliava al mattino, come un’impettita Rosina?
Chi si crogiolava davanti ai fornelli, vestendo i panni della triste Mimì?
Dov’era il filo di quelle parole, e il canto, la via dei suoi passi?
Silenziata dalla terra ogni cosa.
Non poteva sopportarlo, quel silenzio l’opprimeva più dell’oscurità.
S’alzò, di scatto, e dopo alcuni passi incerti, barcollante, si mosse sicura sul pavimento che non avrebbe mai dovuta tradirla.
Ritornò a vedere, chiaramente.
L’immensa libreria, colma di dischi e libri, che i suoi genitori si alternavano, in maniera quasi frenetica, a leggerle, e poi la cucina, modesta ma dignitosa, senza fronzoli, senza trappole per i passi paffuti di Ania, senza spigoli che avrebbero potuto sfregiare il viso della piccola.
Tutto era morbido in quella abitazione, ogni cosa aveva avuto una voce, anche la mobilia stessa, e le suppellettili. I suoi genitori si divertivano a dare un timbro agli oggetti, era l’unica maniera attraverso cui riuscivano a farglieli vedere.
Ogni corpo una voce, ogni oggetto un suono.
In quel modo Ania aveva creduto di poter vedere Dio, perché ne aveva ascoltato la musica.
E quella blasfema divinità aveva le fattezze grassocce di un bimbo mai cresciuto, oberato dai debiti, incapace di provvedere a se stesso e alle sue voglie, e rispondeva al nome di Amadeus.
Ania era una bambina dalla bellezza folgorante. Era venuta al mondo come un sospiro a rallegrare la vita dei genitori, per anni spenti in inutili tentativi d’allargare l’orizzonte della loro famiglia. Alfonso, attempato insegnante d’educazione musicale e Sandra, un tempo brillante mezzosoprano, entrambi discesi verso il declivio d’una grigia esistenza, avevano in un pomeriggio d’autunno risalito la china. Grazie a lei, la piccola Ania che, morbida come una candida nuvola bianca, s’era messa lì, cheta cheta al centro del piccolo focolare, a brillare di luce propria. Il padre la scrutava di continuo, come se ogni istante perduto ad osservare altro fosse vita sprecata. E adesso, dopo l’arrivo dell’angelo non c’era alcun motivo per lasciarsene sfuggire neppure un briciolo, come spesso gli era capitato di sperare. In casa Alessandri si respirava aria nuova, fresca, pulita. Come subito dopo una nevicata, tutto era privo di macchia, tutto doveva essere ripulito.
Il terzo ripiano del mobile libreria, un tempo alcova di vizi e ristori melanconici, era stato sgomberato con forza dalle numerose bottiglie mezze piene di whisky, dalle cartacce pentagrammate che contenevano giovanili velleità di contemporanee composizione, per dare spazio ad una ricchissima collezione digitale di musica.
Alfonso aveva spezzato in molte occasioni puntine di vecchi giradischi fino a restarsene in silenzio per la sala, accovacciato sul divano che divideva con la moglie, dolente e brilla come lui.
Quando, ancora incredula, Sandra gli aveva comunicato la lieta novella, era balenata un’idea nella mente di Alfonso, idea che tardò a realizzare, scaramantico fino all’osso qual’era. Soltanto quando le minuscole dita della sua creatura si levarono verso il cielo in cerca del suo volto pensò d’agire.
Grazie ad un amico, che era riuscito a sfondare le sue ultime resistenze, in verità esili, per condurlo in uno dei migliori rivenditori della città in fatto di impianti HI-FI, s’era dato completamente alla nuova tecnologia digitale in fatto di musica. Aveva voltato le spalle a tutte le reticenze del caso sul calore di un suono analogico, di cui anni addietro, agli albori di quelle fredde incisioni, s’era fatto portabandiera, finendo per essere tacciato quale anacronistico.
Vintage.
Aveva scelto il migliore in qualità, il peggiore in prezzo, ma adesso nella sua vita non c’era necessità di trattenere i risparmi da qualche parte, doveva investirli nel presente della sua Ania.
Fu con quell’idea frenetica, da realizzare nel più breve tempo possibile, che trascorse le ore pomeridiane. Erano le ore in cui, dopo notevoli battibecchi, Sandra lo invitava caldamente ad uscire un po’ di casa, e lui se ne andava a zonzo, per negozi musicali in cerca delle migliori esecuzioni dei capolavori della classica.
Non c’era dubbio, e in questo Sandra era completamente d’accordo, la piccola avrebbe scandito le sue ore cullata dalla bellezza dell’ingegno umano. L’unica ragione per cui la razza umana potesse esser detta umanità e non razza animale. Era stato da sempre il suo pensiero sulla musica, magari carpito senza attenzione a qualche saggio musicofilo, non avrebbe saputo riferirlo, ma era profondamente convito che soltanto la musica «umanizzasse» la razza.
Enfaticamente considerava quanto la bellezza di Mozart potesse resistere alla deflagrazione di Hiroshima, a distanza di tempo.
Sandra rimaneva in casa, e sorrideva, e parlava alla figlia in ogni occasione.
C’era vita in quell’abitazione, se ne poteva sentire la consistenza al tatto, l’aria ne era pregna.
E Sandra le parlava. Anche quando, alcuni metri distanti, s’industriava a preparare la cena, le raccontava per filo e per segno ogni suo movimento, ogni ingrediente aggiunto. Qualsiasi gesto era accompagnato da un commento, e il cuore le saliva in gola per l’emozione ogni qualvolta Ania, dal conforto della sua culla, provava a risponderle, a modo suo.
Fin dai primi vagiti, chiunque aveva avuto modo di guardarne i lineamenti aveva esclamato, a ragione: «sarà bellissima».
Già all’età di cinque anni era stata scelta, lei tra centinaia, per pubblicizzare una nota marca d’abbigliamento. Rimase icona per alcuni anni, fino a quando il cambiamento delle forme non spinse i pubblicitari a proporle un settore differente.
A quindici anni, già donna nelle fattezze, iniziò una lunga collaborazione con alcune tra le più prestigiose marche di intimo e costumi.
Ania faceva la modella senza sfilare, senza lo stress delle passerelle, evitando le morbose attenzioni della stampa scandalistica per le anoressiche vicissitudini quotidiane delle donne copertina.
Nonostante ciò finì in moltissime riviste di moda, e in un numero speciale dedicato all’estate 2006 occupò la prima pagina facendo impennare le vendite.
Si divideva tra set fotografici e la casa.
Il fortissimo legame con la madre era il suo porto sicuro, l’ancora che la tratteneva salda nella navigazione difficile del quotidiano. La voce della donna era il filo che ne conduceva i passi da quando aveva memoria. Non c’era bisogno di considerare, pensare più di tanto, le era necessario ascoltarla quella voce per affidarsi a lei completamente.
Erano cresciute in simbiosi, nel ricordo lontano delle parole del padre, troppo presto vinto da un male che ne aveva cancellato addirittura l’odore per tutta la casa.
Ma la musica era rimasta.
Talvolta, nelle sere di tempesta, Ania provava a ricostruirne il tono dei passi, i movimenti pesanti lungo il parquet del salotto. Provava a ricordare il profumo della sua pelle, quando con le mani grandi e calde le accarezzava il viso. Non aveva, invece, bisogno di ricostruire nella sua memoria il largo sorriso, che veniva spesso fuori nei suoi pensieri, fragoroso e allegro.
Nei terribili mesi che, repentini, trasformarono l’energia della madre in una flebile lampada ad intermittenza, provò per la prima volta in vita sua la felice sensazione d’essere utile a qualcuno. Sebbene il contesto le fosse assai doloroso, non si scoraggiò.
Fu accanto alla madre malata in ogni momento, diede buca a riviste e agenti che le avevano reso fino ad allora la vita brillante, dedicandosi completamente a mantenere ancora in vita il filo dei suoi passi. E si scoprì provetta cuoca, nonché amorevole infermiera.
Nella familiarità dell’ambiente casalingo sapeva bene dove mettere i suoi piedi diafani, si destreggiava leggera, quasi fosse una ballerina, negli spazi di quella abitazione congegnata negli anni affinché, già bambina sgambettante, non incontrasse nessun ostacolo lungo il cammino.
Fin da piccola aveva sviluppato una memoria ferrea, e tale qualità la sosteneva nelle incombenze quotidiane.
Aveva del resto, e da tempo, rifiutato qualsiasi altro aiuto che non fosse la voce della madre.
Quando la donna iniziò a faticare nelle parole, nei gesti, fino a distendersi vinta sul letto, affrontò gli eventi con una caparbietà di cui non era stata fino ad allora consapevole.
In fin dei conti, la straordinaria avvenenza che la natura le aveva donato facilitava il suo incedere nell’ombra.
A lungo i riflettori avevano puntato la sua pelle candida, scoprendone impudenti il corpo morbido e pieno d’armonia. A lungo corteggiatori con le tasche gonfie di quattrini e il cuore pieni di buchi l’avevano condotta nei migliori ristoranti, all’Opera perfino, vista la sua nota passione per la musica classica, nella speranza che ella concedesse quelle grazie ambite da molti.
Eppure lei, sorridente e gentile ad ogni invito, cordiale nell’intrattenersi in quelle serate, e piena di spirito, tanto da meravigliare gli astanti, congedava il corteggiatore di turno con un casto e delicato bacio sula guancia, nulla più.
La riluttanza ad intraprendere un legame sentimentale era profonda, e radicava in un’ancestrale paura, l’unica, che mai l’aveva abbandonata.
Il pensiero d’essere un gioiellino da mostrare al mondo, un diamante di cui fregiarsi fin quando tale, brillante all’eccesso, per poi essere lasciato in disparte, nella profonda oscurità dei suoi giorni, era l’ostacolo insormontabile. Il granitico muro che si frapponeva tra lei e il mondo.
Al ritorno da quelle serate, rientrava a casa con un senso d’angoscia che le cingeva la gola. Lasciava le scarpe, lanciandole sullo zerbino, all’ingresso, e poi contava.
Sì, contava.
Ferma, davanti l’immenso scaffale del salotto, le mani tremanti a livello del terzo ripiano.
Uno, due, tre, quattro, cinque ...diciotto.
In certe occasioni il numero diciotto le era di gran sollievo.
Estraeva il piccolo cofanetto, poi si voltava sulla destra, pochi passi e le dita accarezzavano il fronte del lettore stereo. Armeggiava con i pulsanti fino a quando un simpatico sospiro le indicava che il vano era pronto ad essere nutrito del suo solito pasto serale. Inseriva il compact e si distendeva sulla poltrona. Prendeva il telecomando in mano e, con inusuale destrezza, portava avanti il contatore delle traccie, fino alla numero 5. In quel punto esatto iniziava uno dei suoi brani preferiti, l’andante del concerto per pianoforte e orchestra di Mozart numero 21.
In quelle sere, in cui la melanconia l’avvinceva per tutte le membra, solleticandone fantasie che il buon profumo delle mani dell’ultimo corteggiatore aveva stimolato, si abbandonava infantile a giochi di pensiero. S’immaginava, come faceva da bambina, principessa solitaria vittima di un malefico incantesimo che, prima o poi, il meraviglioso principe, di qualsiasi colore potesse essere, sarebbe giunto trionfante a cancellare.
Sorrideva di sé e delle sue profonde fragilità, che negli ultimi tempi era riuscita a tramutare in vigore, quel vigore che ne sosteneva il cammino in una lotta senza quartiere. Combatteva contro vento la tormenta che aveva spazzato ogni sorriso in casa, compromettendo l’unica voce della sua vita. L’alter ego che sempre più stremata giaceva pressoché immobile nel suo letto, a pochi metri di distanza. Il suono delle melodie di Mozart cullava la madre dolente, senza riuscire, però, ad alleviarne la fine.
Quando la donna morì, all’improvviso tutta l’oscurità dei suoi 29 anni le piombò addosso, schiacciandole il viso per terra. E non fu un sentire metaforico, ma la sera stessa, in cui con veemenza scacciò tutti i parenti e lo sparuto gruppo d’amici che contava di rimanere ancora lì, quando decise, per la prima volta nella sua vita di rimanere sola, non appena richiuse l’uscio di quella casa, divenuta d’un tratto tomba delle sue memorie, inciampò, come non le accadeva da anni.
Finì distesa per terra lungo il freddo parquet, e lì rimase per tutta la notte, bagnando il legno di lacrime e morsi.
Non furono i raggi del primo mattino a scoprirla sola, così come non era mai accaduto nei giorni precedenti che le luci dell’alba la destassero dal sonno profondo, ma come sempre fu il suono del nuovo giorno a svegliarla.
E il giorno si fece nel frastuono di un martello pneumatico che, senza alcun ritegno, penetrò nella sua mente confusa, richiamandola ad alzarsi.
Anche il più cinico tra gli uomini avrebbe provato un sentimento di commozione se avesse assistito alla scena.
Indolenzita, tanto nell’animo quanto nel corpo, per quella notte in cui sogno e veglia s’alternavano senza sosta, con le esili membra schiacciate nel freddo di un pavimento che aveva perduto la voce e l’odore della madre, Ania provò più volte a rimettersi in sesto.
Nel volgere della notte, l’oscurità che l’aveva abbracciata dalla nascita, verso la quale aveva sempre opposto lo splendore della sua bellezza, parve stringerla, comprimerla.
Conati di vomito risalivano lenti per il collo affusolato che molti avevano sognato di accarezzare con le labbra.
E le labbra stesse bruciavano di un sapore amaro che sapeva di silenzio.
Non appena riuscì a ritrovare l’orientamento si accasciò disperata sulla poltrona.
Diventava sempre più consapevole che non era stata la cecità, inseparabile compagna di vita, a piegarle il respiro gettandola per terra la notte prima, ma l’improvvisa solitudine.
A quella non era in grado di far fronte.
Il viso, che mesi prima decine di riviste s’erano contesi, adesso era devastato. Rigagnoli di lacrime venivano fuori in maniera incessante e affondavano sulla pelle morbida come graffi di gatte in calore. Gli occhi gonfi, lucidi, rossi, avevano completamente nascosto l’aspetto angelico.
Ania non poteva vedersi, eppure vedeva tutto, e in quel tutto, che s’era ridotto a melanconico nulla, non scorgeva modo di rialzarsi.
Rimase seduta sulla poltrona per l’intera giornata.
Il petto florido, a stento contenuto dagli arditi costumi che in serie aveva indossato, rendendoli appetibili alle casalinghe in cerca di frivolezze, si sollevava a stento, in una respirazione discreta.
Talvolta un rigurgito di singulto veniva su, traditore, e allora, sempre senza far rumore, le lacrime ritornavano a solcarle il viso.
Il tempo della sua esistenza era stato scandito dalle voci dei suoi affetti, sopratutto dal timbro delicato e caldo di Sandra, che poche volte aveva chiamato mamma.
Ania e Sandra, due amiche, generazioni differenti che affrontavano l’oscurità del mondo, l’una accanto all’altra. E in quella simbiosi tutto appariva loro più lieve.
Anche nei primi tempi della malattia, quando la madre ancora aveva la forza di sostenere la sua condizione, il sorriso spazzava via, come spugna su vetro, le macchie della sofferenza.
Adesso?
Chi la svegliava al mattino, come un’impettita Rosina?
Chi si crogiolava davanti ai fornelli, vestendo i panni della triste Mimì?
Dov’era il filo di quelle parole, e il canto, la via dei suoi passi?
Silenziata dalla terra ogni cosa.
Non poteva sopportarlo, quel silenzio l’opprimeva più dell’oscurità.
S’alzò, di scatto, e dopo alcuni passi incerti, barcollante, si mosse sicura sul pavimento che non avrebbe mai dovuta tradirla.
Ritornò a vedere, chiaramente.
L’immensa libreria, colma di dischi e libri, che i suoi genitori si alternavano, in maniera quasi frenetica, a leggerle, e poi la cucina, modesta ma dignitosa, senza fronzoli, senza trappole per i passi paffuti di Ania, senza spigoli che avrebbero potuto sfregiare il viso della piccola.
Tutto era morbido in quella abitazione, ogni cosa aveva avuto una voce, anche la mobilia stessa, e le suppellettili. I suoi genitori si divertivano a dare un timbro agli oggetti, era l’unica maniera attraverso cui riuscivano a farglieli vedere.
Ogni corpo una voce, ogni oggetto un suono.
In quel modo Ania aveva creduto di poter vedere Dio, perché ne aveva ascoltato la musica.
E quella blasfema divinità aveva le fattezze grassocce di un bimbo mai cresciuto, oberato dai debiti, incapace di provvedere a se stesso e alle sue voglie, e rispondeva al nome di Amadeus.
Tese le mani verso il terzo ripiano, il rifugio delle malinconie amorose, il sollievo da certe giornate di fatica in cui stanca di aver ascoltato troppe frivolezze, spossata d’aver dovuto riscostruirne i tratti nella sua mente, s’abbandonava al caldo abbraccio della madre, al suo profumo di menta, e insieme si cullavano nella musica.
Iniziò a contare, sentendo che le dita tremavano più del solito.
Un vuoto insostenibile riempiva la sua mente, aveva bisogno della sua musica per contrastarlo.
Prese il cofanetto numero 27.
Con fare meccanico lo aprì, lo inserì nel vano, tastò in cerca del telecomando.
Non trovandolo fu presa dal panico. Probabilmente qualcuno degli ospiti, nella concitata giornata trascorsa, aveva messo le mani dove non doveva.
Un urlo le salì in gola, e non fu capace di trattenerlo.
Non per questo s’arrese. Le era bastata la notte passata sul parquet.
Si mosse con cautela lungo il perimetro della libreria, toccando ogni cosa, assaporandone ogni forma. Avvertì una sensazione particolare, e con la mente andò ai racconti delle amiche e delle loro esperienze, le prime. in cui avevano accolto le mani dei loro ragazzi, mani tremanti, come le sue, in esplorazione, come le sue.
Alla fine riuscì a trovarlo, lo strinse forte a sé.
Esultante.
Si adagiò sulla poltrona, con l’ombra leggera d’un sorriso.
Portò il lettore sulla traccia numero 5.
Schiacciò play, con tutta la vita che aveva in corpo.
Laudate dominum.
Comunque.
E a partire dalle prime battute vide la madre, e ne sentì il fiato sulla bocca, leggero come ogni gesto. La vide camminare per la casa, rovistare tra le stoviglie in cerca del vassoio più adatto per la torta che, golosamente, la piccola Ania avrebbe fatto fuori subito. Seguì i passi della madre, intenta con la bizzarra scopetta a ripulire ogni anfratto da ragnatele e polvere, la inseguì per casa. Entrando nel bagno, e subito dopo aver sentito lo sciabordio dell’acqua, aperta a fiotti per riempir la vasca, sgattaiolare via, cercando di sfuggire al bagno settimanale. Inseguì, la piccola Ania, la madre fin nella camera da letto, tra i morbidi cuscini che respiravano ancora del profumo di Alfonso, e fu lì che lo vide. Alfonso a braccia tese, forti, salde sulla minuta figura, accogliere con un sorriso fragoroso Sandra.
Tese le mani verso il terzo ripiano, il rifugio delle malinconie amorose, il sollievo da certe giornate di fatica in cui stanca di aver ascoltato troppe frivolezze, spossata d’aver dovuto riscostruirne i tratti nella sua mente, s’abbandonava al caldo abbraccio della madre, al suo profumo di menta, e insieme si cullavano nella musica.
Iniziò a contare, sentendo che le dita tremavano più del solito.
Un vuoto insostenibile riempiva la sua mente, aveva bisogno della sua musica per contrastarlo.
Prese il cofanetto numero 27.
Con fare meccanico lo aprì, lo inserì nel vano, tastò in cerca del telecomando.
Non trovandolo fu presa dal panico. Probabilmente qualcuno degli ospiti, nella concitata giornata trascorsa, aveva messo le mani dove non doveva.
Un urlo le salì in gola, e non fu capace di trattenerlo.
Non per questo s’arrese. Le era bastata la notte passata sul parquet.
Si mosse con cautela lungo il perimetro della libreria, toccando ogni cosa, assaporandone ogni forma. Avvertì una sensazione particolare, e con la mente andò ai racconti delle amiche e delle loro esperienze, le prime. in cui avevano accolto le mani dei loro ragazzi, mani tremanti, come le sue, in esplorazione, come le sue.
Alla fine riuscì a trovarlo, lo strinse forte a sé.
Esultante.
Si adagiò sulla poltrona, con l’ombra leggera d’un sorriso.
Portò il lettore sulla traccia numero 5.
Schiacciò play, con tutta la vita che aveva in corpo.
Laudate dominum.
Comunque.
E a partire dalle prime battute vide la madre, e ne sentì il fiato sulla bocca, leggero come ogni gesto. La vide camminare per la casa, rovistare tra le stoviglie in cerca del vassoio più adatto per la torta che, golosamente, la piccola Ania avrebbe fatto fuori subito. Seguì i passi della madre, intenta con la bizzarra scopetta a ripulire ogni anfratto da ragnatele e polvere, la inseguì per casa. Entrando nel bagno, e subito dopo aver sentito lo sciabordio dell’acqua, aperta a fiotti per riempir la vasca, sgattaiolare via, cercando di sfuggire al bagno settimanale. Inseguì, la piccola Ania, la madre fin nella camera da letto, tra i morbidi cuscini che respiravano ancora del profumo di Alfonso, e fu lì che lo vide. Alfonso a braccia tese, forti, salde sulla minuta figura, accogliere con un sorriso fragoroso Sandra.
Finì distesa per terra lungo il freddo parquet, e lì rimase per tutta la notte, bagnando il legno di lacrime e morsi.
Non furono i raggi del primo mattino a scoprirla sola, così come non era mai accaduto nei giorni precedenti che le luci dell’alba la destassero dal sonno profondo, ma come sempre fu il suono del nuovo giorno a svegliarla.
E il giorno si fece nel frastuono di un martello pneumatico che, senza alcun ritegno, penetrò nella sua mente confusa, richiamandola ad alzarsi.
Anche il più cinico tra gli uomini avrebbe provato un sentimento di commozione se avesse assistito alla scena.
Indolenzita, tanto nell’animo quanto nel corpo, per quella notte in cui sogno e veglia s’alternavano senza sosta, con le esili membra schiacciate nel freddo di un pavimento che aveva perduto la voce e l’odore della madre, Ania provò più volte a rimettersi in sesto.
Nel volgere della notte, l’oscurità che l’aveva abbracciata dalla nascita, verso la quale aveva sempre opposto lo splendore della sua bellezza, parve stringerla, comprimerla.
Conati di vomito risalivano lenti per il collo affusolato che molti avevano sognato di accarezzare con le labbra.
E le labbra stesse bruciavano di un sapore amaro che sapeva di silenzio.
Non appena riuscì a ritrovare l’orientamento si accasciò disperata sulla poltrona.
Diventava sempre più consapevole che non era stata la cecità, inseparabile compagna di vita, a piegarle il respiro gettandola per terra la notte prima, ma l’improvvisa solitudine.
A quella non era in grado di far fronte.
Il viso, che mesi prima decine di riviste s’erano contesi, adesso era devastato. Rigagnoli di lacrime venivano fuori in maniera incessante e affondavano sulla pelle morbida come graffi di gatte in calore. Gli occhi gonfi, lucidi, rossi, avevano completamente nascosto l’aspetto angelico.
Ania non poteva vedersi, eppure vedeva tutto, e in quel tutto, che s’era ridotto a melanconico nulla, non scorgeva modo di rialzarsi.
Rimase seduta sulla poltrona per l’intera giornata.
Il petto florido, a stento contenuto dagli arditi costumi che in serie aveva indossato, rendendoli appetibili alle casalinghe in cerca di frivolezze, si sollevava a stento, in una respirazione discreta.
Talvolta un rigurgito di singulto veniva su, traditore, e allora, sempre senza far rumore, le lacrime ritornavano a solcarle il viso.
Il tempo della sua esistenza era stato scandito dalle voci dei suoi affetti, sopratutto dal timbro delicato e caldo di Sandra, che poche volte aveva chiamato mamma.
Ania e Sandra, due amiche, generazioni differenti che affrontavano l’oscurità del mondo, l’una accanto all’altra. E in quella simbiosi tutto appariva loro più lieve.
Anche nei primi tempi della malattia, quando la madre ancora aveva la forza di sostenere la sua condizione, il sorriso spazzava via, come spugna su vetro, le macchie della sofferenza.
Adesso?
Chi la svegliava al mattino, come un’impettita Rosina?
Chi si crogiolava davanti ai fornelli, vestendo i panni della triste Mimì?
Dov’era il filo di quelle parole, e il canto, la via dei suoi passi?
Silenziata dalla terra ogni cosa.
Non poteva sopportarlo, quel silenzio l’opprimeva più dell’oscurità.
S’alzò, di scatto, e dopo alcuni passi incerti, barcollante, si mosse sicura sul pavimento che non avrebbe mai dovuta tradirla.
Ritornò a vedere, chiaramente.
L’immensa libreria, colma di dischi e libri, che i suoi genitori si alternavano, in maniera quasi frenetica, a leggerle, e poi la cucina, modesta ma dignitosa, senza fronzoli, senza trappole per i passi paffuti di Ania, senza spigoli che avrebbero potuto sfregiare il viso della piccola.
Tutto era morbido in quella abitazione, ogni cosa aveva avuto una voce, anche la mobilia stessa, e le suppellettili. I suoi genitori si divertivano a dare un timbro agli oggetti, era l’unica maniera attraverso cui riuscivano a farglieli vedere.
Ogni corpo una voce, ogni oggetto un suono.
In quel modo Ania aveva creduto di poter vedere Dio, perché ne aveva ascoltato la musica.
E quella blasfema divinità aveva le fattezze grassocce di un bimbo mai cresciuto, oberato dai debiti, incapace di provvedere a se stesso e alle sue voglie, e rispondeva al nome di Amadeus.
Tese le mani verso il terzo ripiano, il rifugio delle malinconie amorose, il sollievo da certe giornate di fatica in cui stanca di aver ascoltato troppe frivolezze, spossata d’aver dovuto riscostruirne i tratti nella sua mente, s’abbandonava al caldo abbraccio della madre, al suo profumo di menta, e insieme si cullavano nella musica.
Iniziò a contare, sentendo che le dita tremavano più del solito.
Un vuoto insostenibile riempiva la sua mente, aveva bisogno della sua musica per contrastarlo.
Prese il cofanetto numero 27.
Con fare meccanico lo aprì, lo inserì nel vano, tastò in cerca del telecomando.
Non trovandolo fu presa dal panico. Probabilmente qualcuno degli ospiti, nella concitata giornata trascorsa, aveva messo le mani dove non doveva.
Un urlo le salì in gola, e non fu capace di trattenerlo.
Non per questo s’arrese. Le era bastata la notte passata sul parquet.
Si mosse con cautela lungo il perimetro della libreria, toccando ogni cosa, assaporandone ogni forma. Avvertì una sensazione particolare, e con la mente andò ai racconti delle amiche e delle loro esperienze, le prime. in cui avevano accolto le mani dei loro ragazzi, mani tremanti, come le sue, in esplorazione, come le sue.
Alla fine riuscì a trovarlo, lo strinse forte a sé.
Esultante.
Si adagiò sulla poltrona, con l’ombra leggera d’un sorriso.
Portò il lettore sulla traccia numero 5.
Schiacciò play, con tutta la vita che aveva in corpo.
Laudate dominum.
Comunque.
E a partire dalle prime battute vide la madre, e ne sentì il fiato sulla bocca, leggero come ogni gesto. La vide camminare per la casa, rovistare tra le stoviglie in cerca del vassoio più adatto per la torta che, golosamente, la piccola Ania avrebbe fatto fuori subito. Seguì i passi della madre, intenta con la bizzarra scopetta a ripulire ogni anfratto da ragnatele e polvere, la inseguì per casa. Entrando nel bagno, e subito dopo aver sentito lo sciabordio dell’acqua, aperta a fiotti per riempir la vasca, sgattaiolare via, cercando di sfuggire al bagno settimanale. Inseguì, la piccola Ania, la madre fin nella camera da letto, tra i morbidi cuscini che respiravano ancora del profumo di Alfonso, e fu lì che lo vide. Alfonso a braccia tese, forti, salde sulla minuta figura, accogliere con un sorriso fragoroso Sandra.
Il terzo ripiano del mobile libreria, un tempo alcova di vizi e ristori melanconici, era stato sgomberato con forza dalle numerose bottiglie mezze piene di whisky, dalle cartacce pentagrammate che contenevano giovanili velleità di contemporanee composizione, per dare spazio ad una ricchissima collezione digitale di musica.
Alfonso aveva spezzato in molte occasioni puntine di vecchi giradischi fino a restarsene in silenzio per la sala, accovacciato sul divano che divideva con la moglie, dolente e brilla come lui.
Quando, ancora incredula, Sandra gli aveva comunicato la lieta novella, era balenata un’idea nella mente di Alfonso, idea che tardò a realizzare, scaramantico fino all’osso qual’era. Soltanto quando le minuscole dita della sua creatura si levarono verso il cielo in cerca del suo volto pensò d’agire.
Grazie ad un amico, che era riuscito a sfondare le sue ultime resistenze, in verità esili, per condurlo in uno dei migliori rivenditori della città in fatto di impianti HI-FI, s’era dato completamente alla nuova tecnologia digitale in fatto di musica. Aveva voltato le spalle a tutte le reticenze del caso sul calore di un suono analogico, di cui anni addietro, agli albori di quelle fredde incisioni, s’era fatto portabandiera, finendo per essere tacciato quale anacronistico.
Vintage.
Aveva scelto il migliore in qualità, il peggiore in prezzo, ma adesso nella sua vita non c’era necessità di trattenere i risparmi da qualche parte, doveva investirli nel presente della sua Ania.
Fu con quell’idea frenetica, da realizzare nel più breve tempo possibile, che trascorse le ore pomeridiane. Erano le ore in cui, dopo notevoli battibecchi, Sandra lo invitava caldamente ad uscire un po’ di casa, e lui se ne andava a zonzo, per negozi musicali in cerca delle migliori esecuzioni dei capolavori della classica.
Non c’era dubbio, e in questo Sandra era completamente d’accordo, la piccola avrebbe scandito le sue ore cullata dalla bellezza dell’ingegno umano. L’unica ragione per cui la razza umana potesse esser detta umanità e non razza animale. Era stato da sempre il suo pensiero sulla musica, magari carpito senza attenzione a qualche saggio musicofilo, non avrebbe saputo riferirlo, ma era profondamente convito che soltanto la musica «umanizzasse» la razza.
Enfaticamente considerava quanto la bellezza di Mozart potesse resistere alla deflagrazione di Hiroshima, a distanza di tempo.
Sandra rimaneva in casa, e sorrideva, e parlava alla figlia in ogni occasione.
C’era vita in quell’abitazione, se ne poteva sentire la consistenza al tatto, l’aria ne era pregna.
E Sandra le parlava. Anche quando, alcuni metri distanti, s’industriava a preparare la cena, le raccontava per filo e per segno ogni suo movimento, ogni ingrediente aggiunto. Qualsiasi gesto era accompagnato da un commento, e il cuore le saliva in gola per l’emozione ogni qualvolta Ania, dal conforto della sua culla, provava a risponderle, a modo suo.
Fin dai primi vagiti, chiunque aveva avuto modo di guardarne i lineamenti aveva esclamato, a ragione: «sarà bellissima».
Già all’età di cinque anni era stata scelta, lei tra centinaia, per pubblicizzare una nota marca d’abbigliamento. Rimase icona per alcuni anni, fino a quando il cambiamento delle forme non spinse i pubblicitari a proporle un settore differente.
A quindici anni, già donna nelle fattezze, iniziò una lunga collaborazione con alcune tra le più prestigiose marche di intimo e costumi.
Ania faceva la modella senza sfilare, senza lo stress delle passerelle, evitando le morbose attenzioni della stampa scandalistica per le anoressiche vicissitudini quotidiane delle donne copertina.
Nonostante ciò finì in moltissime riviste di moda, e in un numero speciale dedicato all’estate 2006 occupò la prima pagina facendo impennare le vendite.
Si divideva tra set fotografici e la casa.
Il fortissimo legame con la madre era il suo porto sicuro, l’ancora che la tratteneva salda nella navigazione difficile del quotidiano. La voce della donna era il filo che ne conduceva i passi da quando aveva memoria. Non c’era bisogno di considerare, pensare più di tanto, le era necessario ascoltarla quella voce per affidarsi a lei completamente.
Erano cresciute in simbiosi, nel ricordo lontano delle parole del padre, troppo presto vinto da un male che ne aveva cancellato addirittura l’odore per tutta la casa.
Ma la musica era rimasta.
Talvolta, nelle sere di tempesta, Ania provava a ricostruirne il tono dei passi, i movimenti pesanti lungo il parquet del salotto. Provava a ricordare il profumo della sua pelle, quando con le mani grandi e calde le accarezzava il viso. Non aveva, invece, bisogno di ricostruire nella sua memoria il largo sorriso, che veniva spesso fuori nei suoi pensieri, fragoroso e allegro.
Nei terribili mesi che, repentini, trasformarono l’energia della madre in una flebile lampada ad intermittenza, provò per la prima volta in vita sua la felice sensazione d’essere utile a qualcuno. Sebbene il contesto le fosse assai doloroso, non si scoraggiò.
Fu accanto alla madre malata in ogni momento, diede buca a riviste e agenti che le avevano reso fino ad allora la vita brillante, dedicandosi completamente a mantenere ancora in vita il filo dei suoi passi. E si scoprì provetta cuoca, nonché amorevole infermiera.
Nella familiarità dell’ambiente casalingo sapeva bene dove mettere i suoi piedi diafani, si destreggiava leggera, quasi fosse una ballerina, negli spazi di quella abitazione congegnata negli anni affinché, già bambina sgambettante, non incontrasse nessun ostacolo lungo il cammino.
Fin da piccola aveva sviluppato una memoria ferrea, e tale qualità la sosteneva nelle incombenze quotidiane.
Aveva del resto, e da tempo, rifiutato qualsiasi altro aiuto che non fosse la voce della madre.
Quando la donna iniziò a faticare nelle parole, nei gesti, fino a distendersi vinta sul letto, affrontò gli eventi con una caparbietà di cui non era stata fino ad allora consapevole.
In fin dei conti, la straordinaria avvenenza che la natura le aveva donato facilitava il suo incedere nell’ombra.
A lungo i riflettori avevano puntato la sua pelle candida, scoprendone impudenti il corpo morbido e pieno d’armonia. A lungo corteggiatori con le tasche gonfie di quattrini e il cuore pieni di buchi l’avevano condotta nei migliori ristoranti, all’Opera perfino, vista la sua nota passione per la musica classica, nella speranza che ella concedesse quelle grazie ambite da molti.
Eppure lei, sorridente e gentile ad ogni invito, cordiale nell’intrattenersi in quelle serate, e piena di spirito, tanto da meravigliare gli astanti, congedava il corteggiatore di turno con un casto e delicato bacio sula guancia, nulla più.
La riluttanza ad intraprendere un legame sentimentale era profonda, e radicava in un’ancestrale paura, l’unica, che mai l’aveva abbandonata.
Il pensiero d’essere un gioiellino da mostrare al mondo, un diamante di cui fregiarsi fin quando tale, brillante all’eccesso, per poi essere lasciato in disparte, nella profonda oscurità dei suoi giorni, era l’ostacolo insormontabile. Il granitico muro che si frapponeva tra lei e il mondo.
Al ritorno da quelle serate, rientrava a casa con un senso d’angoscia che le cingeva la gola. Lasciava le scarpe, lanciandole sullo zerbino, all’ingresso, e poi contava.
Sì, contava.
Ferma, davanti l’immenso scaffale del salotto, le mani tremanti a livello del terzo ripiano.
Uno, due, tre, quattro, cinque ...diciotto.
In certe occasioni il numero diciotto le era di gran sollievo.
Estraeva il piccolo cofanetto, poi si voltava sulla destra, pochi passi e le dita accarezzavano il fronte del lettore stereo. Armeggiava con i pulsanti fino a quando un simpatico sospiro le indicava che il vano era pronto ad essere nutrito del suo solito pasto serale. Inseriva il compact e si distendeva sulla poltrona. Prendeva il telecomando in mano e, con inusuale destrezza, portava avanti il contatore delle traccie, fino alla numero 5. In quel punto esatto iniziava uno dei suoi brani preferiti, l’andante del concerto per pianoforte e orchestra di Mozart numero 21.
In quelle sere, in cui la melanconia l’avvinceva per tutte le membra, solleticandone fantasie che il buon profumo delle mani dell’ultimo corteggiatore aveva stimolato, si abbandonava infantile a giochi di pensiero. S’immaginava, come faceva da bambina, principessa solitaria vittima di un malefico incantesimo che, prima o poi, il meraviglioso principe, di qualsiasi colore potesse essere, sarebbe giunto trionfante a cancellare.
Sorrideva di sé e delle sue profonde fragilità, che negli ultimi tempi era riuscita a tramutare in vigore, quel vigore che ne sosteneva il cammino in una lotta senza quartiere. Combatteva contro vento la tormenta che aveva spazzato ogni sorriso in casa, compromettendo l’unica voce della sua vita. L’alter ego che sempre più stremata giaceva pressoché immobile nel suo letto, a pochi metri di distanza. Il suono delle melodie di Mozart cullava la madre dolente, senza riuscire, però, ad alleviarne la fine.
Quando la donna morì, all’improvviso tutta l’oscurità dei suoi 29 anni le piombò addosso, schiacciandole il viso per terra. E non fu un sentire metaforico, ma la sera stessa, in cui con veemenza scacciò tutti i parenti e lo sparuto gruppo d’amici che contava di rimanere ancora lì, quando decise, per la prima volta nella sua vita di rimanere sola, non appena richiuse l’uscio di quella casa, divenuta d’un tratto tomba delle sue memorie, inciampò, come non le accadeva da anni.Ania era una bambina dalla bellezza folgorante. Era venuta al mondo come un sospiro a rallegrare la vita dei genitori, per anni spenti in inutili tentativi d’allargare l’orizzonte della loro famiglia. Alfonso, attempato insegnante d’educazione musicale e Sandra, un tempo brillante mezzosoprano, entrambi discesi verso il declivio d’una grigia esistenza, avevano in un pomeriggio d’autunno risalito la china. Grazie a lei, la piccola Ania che, morbida come una candida nuvola bianca, s’era messa lì, cheta cheta al centro del piccolo focolare, a brillare di luce propria. Il padre la scrutava di continuo, come se ogni istante perduto ad osservare altro fosse vita sprecata. E adesso, dopo l’arrivo dell’angelo non c’era alcun motivo per lasciarsene sfuggire neppure un briciolo, come spesso gli era capitato di sperare. In casa Alessandri si respirava aria nuova, fresca, pulita. Come subito dopo una nevicata, tutto era privo di macchia, tutto doveva essere ripulito.
Il terzo ripiano del mobile libreria, un tempo alcova di vizi e ristori melanconici, era stato sgomberato con forza dalle numerose bottiglie mezze piene di whisky, dalle cartacce pentagrammate che contenevano giovanili velleità di contemporanee composizione, per dare spazio ad una ricchissima collezione digitale di musica.
Alfonso aveva spezzato in molte occasioni puntine di vecchi giradischi fino a restarsene in silenzio per la sala, accovacciato sul divano che divideva con la moglie, dolente e brilla come lui.
Quando, ancora incredula, Sandra gli aveva comunicato la lieta novella, era balenata un’idea nella mente di Alfonso, idea che tardò a realizzare, scaramantico fino all’osso qual’era. Soltanto quando le minuscole dita della sua creatura si levarono verso il cielo in cerca del suo volto pensò d’agire.
Grazie ad un amico, che era riuscito a sfondare le sue ultime resistenze, in verità esili, per condurlo in uno dei migliori rivenditori della città in fatto di impianti HI-FI, s’era dato completamente alla nuova tecnologia digitale in fatto di musica. Aveva voltato le spalle a tutte le reticenze del caso sul calore di un suono analogico, di cui anni addietro, agli albori di quelle fredde incisioni, s’era fatto portabandiera, finendo per essere tacciato quale anacronistico.
Vintage.
Aveva scelto il migliore in qualità, il peggiore in prezzo, ma adesso nella sua vita non c’era necessità di trattenere i risparmi da qualche parte, doveva investirli nel presente della sua Ania.
Fu con quell’idea frenetica, da realizzare nel più breve tempo possibile, che trascorse le ore pomeridiane. Erano le ore in cui, dopo notevoli battibecchi, Sandra lo invitava caldamente ad uscire un po’ di casa, e lui se ne andava a zonzo, per negozi musicali in cerca delle migliori esecuzioni dei capolavori della classica.
Non c’era dubbio, e in questo Sandra era completamente d’accordo, la piccola avrebbe scandito le sue ore cullata dalla bellezza dell’ingegno umano. L’unica ragione per cui la razza umana potesse esser detta umanità e non razza animale. Era stato da sempre il suo pensiero sulla musica, magari carpito senza attenzione a qualche saggio musicofilo, non avrebbe saputo riferirlo, ma era profondamente convito che soltanto la musica «umanizzasse» la razza.
Enfaticamente considerava quanto la bellezza di Mozart potesse resistere alla deflagrazione di Hiroshima, a distanza di tempo.
Sandra rimaneva in casa, e sorrideva, e parlava alla figlia in ogni occasione.
C’era vita in quell’abitazione, se ne poteva sentire la consistenza al tatto, l’aria ne era pregna.
E Sandra le parlava. Anche quando, alcuni metri distanti, s’industriava a preparare la cena, le raccontava per filo e per segno ogni suo movimento, ogni ingrediente aggiunto. Qualsiasi gesto era accompagnato da un commento, e il cuore le saliva in gola per l’emozione ogni qualvolta Ania, dal conforto della sua culla, provava a risponderle, a modo suo.
Fin dai primi vagiti, chiunque aveva avuto modo di guardarne i lineamenti aveva esclamato, a ragione: «sarà bellissima».
Già all’età di cinque anni era stata scelta, lei tra centinaia, per pubblicizzare una nota marca d’abbigliamento. Rimase icona per alcuni anni, fino a quando il cambiamento delle forme non spinse i pubblicitari a proporle un settore differente.
A quindici anni, già donna nelle fattezze, iniziò una lunga collaborazione con alcune tra le più prestigiose marche di intimo e costumi.
Ania faceva la modella senza sfilare, senza lo stress delle passerelle, evitando le morbose attenzioni della stampa scandalistica per le anoressiche vicissitudini quotidiane delle donne copertina.
Nonostante ciò finì in moltissime riviste di moda, e in un numero speciale dedicato all’estate 2006 occupò la prima pagina facendo impennare le vendite.
Si divideva tra set fotografici e la casa.
Il fortissimo legame con la madre era il suo porto sicuro, l’ancora che la tratteneva salda nella navigazione difficile del quotidiano. La voce della donna era il filo che ne conduceva i passi da quando aveva memoria. Non c’era bisogno di considerare, pensare più di tanto, le era necessario ascoltarla quella voce per affidarsi a lei completamente.
Erano cresciute in simbiosi, nel ricordo lontano delle parole del padre, troppo presto vinto da un male che ne aveva cancellato addirittura l’odore per tutta la casa.
Ma la musica era rimasta.
Talvolta, nelle sere di tempesta, Ania provava a ricostruirne il tono dei passi, i movimenti pesanti lungo il parquet del salotto. Provava a ricordare il profumo della sua pelle, quando con le mani grandi e calde le accarezzava il viso. Non aveva, invece, bisogno di ricostruire nella sua memoria il largo sorriso, che veniva spesso fuori nei suoi pensieri, fragoroso e allegro.
Nei terribili mesi che, repentini, trasformarono l’energia della madre in una flebile lampada ad intermittenza, provò per la prima volta in vita sua la felice sensazione d’essere utile a qualcuno. Sebbene il contesto le fosse assai doloroso, non si scoraggiò.
Fu accanto alla madre malata in ogni momento, diede buca a riviste e agenti che le avevano reso fino ad allora la vita brillante, dedicandosi completamente a mantenere ancora in vita il filo dei suoi passi. E si scoprì provetta cuoca, nonché amorevole infermiera.
Nella familiarità dell’ambiente casalingo sapeva bene dove mettere i suoi piedi diafani, si destreggiava leggera, quasi fosse una ballerina, negli spazi di quella abitazione congegnata negli anni affinché, già bambina sgambettante, non incontrasse nessun ostacolo lungo il cammino.
Fin da piccola aveva sviluppato una memoria ferrea, e tale qualità la sosteneva nelle incombenze quotidiane.
Aveva del resto, e da tempo, rifiutato qualsiasi altro aiuto che non fosse la voce della madre.
Quando la donna iniziò a faticare nelle parole, nei gesti, fino a distendersi vinta sul letto, affrontò gli eventi con una caparbietà di cui non era stata fino ad allora consapevole.
In fin dei conti, la straordinaria avvenenza che la natura le aveva donato facilitava il suo incedere nell’ombra.
A lungo i riflettori avevano puntato la sua pelle candida, scoprendone impudenti il corpo morbido e pieno d’armonia. A lungo corteggiatori con le tasche gonfie di quattrini e il cuore pieni di buchi l’avevano condotta nei migliori ristoranti, all’Opera perfino, vista la sua nota passione per la musica classica, nella speranza che ella concedesse quelle grazie ambite da molti.
Eppure lei, sorridente e gentile ad ogni invito, cordiale nell’intrattenersi in quelle serate, e piena di spirito, tanto da meravigliare gli astanti, congedava il corteggiatore di turno con un casto e delicato bacio sula guancia, nulla più.
La riluttanza ad intraprendere un legame sentimentale era profonda, e radicava in un’ancestrale paura, l’unica, che mai l’aveva abbandonata.
Il pensiero d’essere un gioiellino da mostrare al mondo, un diamante di cui fregiarsi fin quando tale, brillante all’eccesso, per poi essere lasciato in disparte, nella profonda oscurità dei suoi giorni, era l’ostacolo insormontabile. Il granitico muro che si frapponeva tra lei e il mondo.
Al ritorno da quelle serate, rientrava a casa con un senso d’angoscia che le cingeva la gola. Lasciava le scarpe, lanciandole sullo zerbino, all’ingresso, e poi contava.
Sì, contava.
Ferma, davanti l’immenso scaffale del salotto, le mani tremanti a livello del terzo ripiano.
Uno, due, tre, quattro, cinque ...diciotto.
In certe occasioni il numero diciotto le era di gran sollievo.
Estraeva il piccolo cofanetto, poi si voltava sulla destra, pochi passi e le dita accarezzavano il fronte del lettore stereo. Armeggiava con i pulsanti fino a quando un simpatico sospiro le indicava che il vano era pronto ad essere nutrito del suo solito pasto serale. Inseriva il compact e si distendeva sulla poltrona. Prendeva il telecomando in mano e, con inusuale destrezza, portava avanti il contatore delle traccie, fino alla numero 5. In quel punto esatto iniziava uno dei suoi brani preferiti, l’andante del concerto per pianoforte e orchestra di Mozart numero 21.
In quelle sere, in cui la melanconia l’avvinceva per tutte le membra, solleticandone fantasie che il buon profumo delle mani dell’ultimo corteggiatore aveva stimolato, si abbandonava infantile a giochi di pensiero. S’immaginava, come faceva da bambina, principessa solitaria vittima di un malefico incantesimo che, prima o poi, il meraviglioso principe, di qualsiasi colore potesse essere, sarebbe giunto trionfante a cancellare.
Sorrideva di sé e delle sue profonde fragilità, che negli ultimi tempi era riuscita a tramutare in vigore, quel vigore che ne sosteneva il cammino in una lotta senza quartiere. Combatteva contro vento la tormenta che aveva spazzato ogni sorriso in casa, compromettendo l’unica voce della sua vita. L’alter ego che sempre più stremata giaceva pressoché immobile nel suo letto, a pochi metri di distanza. Il suono delle melodie di Mozart cullava la madre dolente, senza riuscire, però, ad alleviarne la fine.
Quando la donna morì, all’improvviso tutta l’oscurità dei suoi 29 anni le piombò addosso, schiacciandole il viso per terra. E non fu un sentire metaforico, ma la sera stessa, in cui con veemenza scacciò tutti i parenti e lo sparuto gruppo d’amici che contava di rimanere ancora lì, quando decise, per la prima volta nella sua vita di rimanere sola, non appena richiuse l’uscio di quella casa, divenuta d’un tratto tomba delle sue memorie, inciampò, come non le accadeva da anni.
Finì distesa per terra lungo il freddo parquet, e lì rimase per tutta la notte, bagnando il legno di lacrime e morsi.
Non furono i raggi del primo mattino a scoprirla sola, così come non era mai accaduto nei giorni precedenti che le luci dell’alba la destassero dal sonno profondo, ma come sempre fu il suono del nuovo giorno a svegliarla.
E il giorno si fece nel frastuono di un martello pneumatico che, senza alcun ritegno, penetrò nella sua mente confusa, richiamandola ad alzarsi.
Anche il più cinico tra gli uomini avrebbe provato un sentimento di commozione se avesse assistito alla scena.
Indolenzita, tanto nell’animo quanto nel corpo, per quella notte in cui sogno e veglia s’alternavano senza sosta, con le esili membra schiacciate nel freddo di un pavimento che aveva perduto la voce e l’odore della madre, Ania provò più volte a rimettersi in sesto.
Nel volgere della notte, l’oscurità che l’aveva abbracciata dalla nascita, verso la quale aveva sempre opposto lo splendore della sua bellezza, parve stringerla, comprimerla.
Conati di vomito risalivano lenti per il collo affusolato che molti avevano sognato di accarezzare con le labbra.
E le labbra stesse bruciavano di un sapore amaro che sapeva di silenzio.
Non appena riuscì a ritrovare l’orientamento si accasciò disperata sulla poltrona.
Diventava sempre più consapevole che non era stata la cecità, inseparabile compagna di vita, a piegarle il respiro gettandola per terra la notte prima, ma l’improvvisa solitudine.
A quella non era in grado di far fronte.
Il viso, che mesi prima decine di riviste s’erano contesi, adesso era devastato. Rigagnoli di lacrime venivano fuori in maniera incessante e affondavano sulla pelle morbida come graffi di gatte in calore. Gli occhi gonfi, lucidi, rossi, avevano completamente nascosto l’aspetto angelico.
Ania non poteva vedersi, eppure vedeva tutto, e in quel tutto, che s’era ridotto a melanconico nulla, non scorgeva modo di rialzarsi.
Rimase seduta sulla poltrona per l’intera giornata.
Il petto florido, a stento contenuto dagli arditi costumi che in serie aveva indossato, rendendoli appetibili alle casalinghe in cerca di frivolezze, si sollevava a stento, in una respirazione discreta.
Talvolta un rigurgito di singulto veniva su, traditore, e allora, sempre senza far rumore, le lacrime ritornavano a solcarle il viso.
Il tempo della sua esistenza era stato scandito dalle voci dei suoi affetti, sopratutto dal timbro delicato e caldo di Sandra, che poche volte aveva chiamato mamma.
Ania e Sandra, due amiche, generazioni differenti che affrontavano l’oscurità del mondo, l’una accanto all’altra. E in quella simbiosi tutto appariva loro più lieve.
Anche nei primi tempi della malattia, quando la madre ancora aveva la forza di sostenere la sua condizione, il sorriso spazzava via, come spugna su vetro, le macchie della sofferenza.
Adesso?
Chi la svegliava al mattino, come un’impettita Rosina?
Chi si crogiolava davanti ai fornelli, vestendo i panni della triste Mimì?
Dov’era il filo di quelle parole, e il canto, la via dei suoi passi?
Silenziata dalla terra ogni cosa.
Non poteva sopportarlo, quel silenzio l’opprimeva più dell’oscurità.
S’alzò, di scatto, e dopo alcuni passi incerti, barcollante, si mosse sicura sul pavimento che non avrebbe mai dovuta tradirla.
Ritornò a vedere, chiaramente.
L’immensa libreria, colma di dischi e libri, che i suoi genitori si alternavano, in maniera quasi frenetica, a leggerle, e poi la cucina, modesta ma dignitosa, senza fronzoli, senza trappole per i passi paffuti di Ania, senza spigoli che avrebbero potuto sfregiare il viso della piccola.
Tutto era morbido in quella abitazione, ogni cosa aveva avuto una voce, anche la mobilia stessa, e le suppellettili. I suoi genitori si divertivano a dare un timbro agli oggetti, era l’unica maniera attraverso cui riuscivano a farglieli vedere.
Ogni corpo una voce, ogni oggetto un suono.
In quel modo Ania aveva creduto di poter vedere Dio, perché ne aveva ascoltato la musica.
E quella blasfema divinità aveva le fattezze grassocce di un bimbo mai cresciuto, oberato dai debiti, incapace di provvedere a se stesso e alle sue voglie, e rispondeva al nome di Amadeus.
Ania era una bambina dalla bellezza folgorante. Era venuta al mondo come un sospiro a rallegrare la vita dei genitori, per anni spenti in inutili tentativi d’allargare l’orizzonte della loro famiglia. Alfonso, attempato insegnante d’educazione musicale e Sandra, un tempo brillante mezzosoprano, entrambi discesi verso il declivio d’una grigia esistenza, avevano in un pomeriggio d’autunno risalito la china. Grazie a lei, la piccola Ania che, morbida come una candida nuvola bianca, s’era messa lì, cheta cheta al centro del piccolo focolare, a brillare di luce propria. Il padre la scrutava di continuo, come se ogni istante perduto ad osservare altro fosse vita sprecata. E adesso, dopo l’arrivo dell’angelo non c’era alcun motivo per lasciarsene sfuggire neppure un briciolo, come spesso gli era capitato di sperare. In casa Alessandri si respirava aria nuova, fresca, pulita. Come subito dopo una nevicata, tutto era privo di macchia, tutto doveva essere ripulito.
Il terzo ripiano del mobile libreria, un tempo alcova di vizi e ristori melanconici, era stato sgomberato con forza dalle numerose bottiglie mezze piene di whisky, dalle cartacce pentagrammate che contenevano giovanili velleità di contemporanee composizione, per dare spazio ad una ricchissima collezione digitale di musica.
Alfonso aveva spezzato in molte occasioni puntine di vecchi giradischi fino a restarsene in silenzio per la sala, accovacciato sul divano che divideva con la moglie, dolente e brilla come lui.
Quando, ancora incredula, Sandra gli aveva comunicato la lieta novella, era balenata un’idea nella mente di Alfonso, idea che tardò a realizzare, scaramantico fino all’osso qual’era. Soltanto quando le minuscole dita della sua creatura si levarono verso il cielo in cerca del suo volto pensò d’agire.
Grazie ad un amico, che era riuscito a sfondare le sue ultime resistenze, in verità esili, per condurlo in uno dei migliori rivenditori della città in fatto di impianti HI-FI, s’era dato completamente alla nuova tecnologia digitale in fatto di musica. Aveva voltato le spalle a tutte le reticenze del caso sul calore di un suono analogico, di cui anni addietro, agli albori di quelle fredde incisioni, s’era fatto portabandiera, finendo per essere tacciato quale anacronistico.
Vintage.
Aveva scelto il migliore in qualità, il peggiore in prezzo, ma adesso nella sua vita non c’era necessità di trattenere i risparmi da qualche parte, doveva investirli nel presente della sua Ania.
Fu con quell’idea frenetica, da realizzare nel più breve tempo possibile, che trascorse le ore pomeridiane. Erano le ore in cui, dopo notevoli battibecchi, Sandra lo invitava caldamente ad uscire un po’ di casa, e lui se ne andava a zonzo, per negozi musicali in cerca delle migliori esecuzioni dei capolavori della classica.
Non c’era dubbio, e in questo Sandra era completamente d’accordo, la piccola avrebbe scandito le sue ore cullata dalla bellezza dell’ingegno umano. L’unica ragione per cui la razza umana potesse esser detta umanità e non razza animale. Era stato da sempre il suo pensiero sulla musica, magari carpito senza attenzione a qualche saggio musicofilo, non avrebbe saputo riferirlo, ma era profondamente convito che soltanto la musica «umanizzasse» la razza.
Enfaticamente considerava quanto la bellezza di Mozart potesse resistere alla deflagrazione di Hiroshima, a distanza di tempo.
Sandra rimaneva in casa, e sorrideva, e parlava alla figlia in ogni occasione.
C’era vita in quell’abitazione, se ne poteva sentire la consistenza al tatto, l’aria ne era pregna.
E Sandra le parlava. Anche quando, alcuni metri distanti, s’industriava a preparare la cena, le raccontava per filo e per segno ogni suo movimento, ogni ingrediente aggiunto. Qualsiasi gesto era accompagnato da un commento, e il cuore le saliva in gola per l’emozione ogni qualvolta Ania, dal conforto della sua culla, provava a risponderle, a modo suo.
Fin dai primi vagiti, chiunque aveva avuto modo di guardarne i lineamenti aveva esclamato, a ragione: «sarà bellissima».
Già all’età di cinque anni era stata scelta, lei tra centinaia, per pubblicizzare una nota marca d’abbigliamento. Rimase icona per alcuni anni, fino a quando il cambiamento delle forme non spinse i pubblicitari a proporle un settore differente.
A quindici anni, già donna nelle fattezze, iniziò una lunga collaborazione con alcune tra le più prestigiose marche di intimo e costumi.
Ania faceva la modella senza sfilare, senza lo stress delle passerelle, evitando le morbose attenzioni della stampa scandalistica per le anoressiche vicissitudini quotidiane delle donne copertina.
Nonostante ciò finì in moltissime riviste di moda, e in un numero speciale dedicato all’estate 2006 occupò la prima pagina facendo impennare le vendite.
Si divideva tra set fotografici e la casa.
Il fortissimo legame con la madre era il suo porto sicuro, l’ancora che la tratteneva salda nella navigazione difficile del quotidiano. La voce della donna era il filo che ne conduceva i passi da quando aveva memoria. Non c’era bisogno di considerare, pensare più di tanto, le era necessario ascoltarla quella voce per affidarsi a lei completamente.
Erano cresciute in simbiosi, nel ricordo lontano delle parole del padre, troppo presto vinto da un male che ne aveva cancellato addirittura l’odore per tutta la casa.
Ma la musica era rimasta.
Talvolta, nelle sere di tempesta, Ania provava a ricostruirne il tono dei passi, i movimenti pesanti lungo il parquet del salotto. Provava a ricordare il profumo della sua pelle, quando con le mani grandi e calde le accarezzava il viso. Non aveva, invece, bisogno di ricostruire nella sua memoria il largo sorriso, che veniva spesso fuori nei suoi pensieri, fragoroso e allegro.
Nei terribili mesi che, repentini, trasformarono l’energia della madre in una flebile lampada ad intermittenza, provò per la prima volta in vita sua la felice sensazione d’essere utile a qualcuno. Sebbene il contesto le fosse assai doloroso, non si scoraggiò.
Fu accanto alla madre malata in ogni momento, diede buca a riviste e agenti che le avevano reso fino ad allora la vita brillante, dedicandosi completamente a mantenere ancora in vita il filo dei suoi passi. E si scoprì provetta cuoca, nonché amorevole infermiera.
Nella familiarità dell’ambiente casalingo sapeva bene dove mettere i suoi piedi diafani, si destreggiava leggera, quasi fosse una ballerina, negli spazi di quella abitazione congegnata negli anni affinché, già bambina sgambettante, non incontrasse nessun ostacolo lungo il cammino.
Fin da piccola aveva sviluppato una memoria ferrea, e tale qualità la sosteneva nelle incombenze quotidiane.
Aveva del resto, e da tempo, rifiutato qualsiasi altro aiuto che non fosse la voce della madre.
Quando la donna iniziò a faticare nelle parole, nei gesti, fino a distendersi vinta sul letto, affrontò gli eventi con una caparbietà di cui non era stata fino ad allora consapevole.
In fin dei conti, la straordinaria avvenenza che la natura le aveva donato facilitava il suo incedere nell’ombra.
A lungo i riflettori avevano puntato la sua pelle candida, scoprendone impudenti il corpo morbido e pieno d’armonia. A lungo corteggiatori con le tasche gonfie di quattrini e il cuore pieni di buchi l’avevano condotta nei migliori ristoranti, all’Opera perfino, vista la sua nota passione per la musica classica, nella speranza che ella concedesse quelle grazie ambite da molti.
Eppure lei, sorridente e gentile ad ogni invito, cordiale nell’intrattenersi in quelle serate, e piena di spirito, tanto da meravigliare gli astanti, congedava il corteggiatore di turno con un casto e delicato bacio sula guancia, nulla più.
La riluttanza ad intraprendere un legame sentimentale era profonda, e radicava in un’ancestrale paura, l’unica, che mai l’aveva abbandonata.
Il pensiero d’essere un gioiellino da mostrare al mondo, un diamante di cui fregiarsi fin quando tale, brillante all’eccesso, per poi essere lasciato in disparte, nella profonda oscurità dei suoi giorni, era l’ostacolo insormontabile. Il granitico muro che si frapponeva tra lei e il mondo.
Al ritorno da quelle serate, rientrava a casa con un senso d’angoscia che le cingeva la gola. Lasciava le scarpe, lanciandole sullo zerbino, all’ingresso, e poi contava.
Sì, contava.
Ferma, davanti l’immenso scaffale del salotto, le mani tremanti a livello del terzo ripiano.
Uno, due, tre, quattro, cinque ...diciotto.
In certe occasioni il numero diciotto le era di gran sollievo.
Estraeva il piccolo cofanetto, poi si voltava sulla destra, pochi passi e le dita accarezzavano il fronte del lettore stereo. Armeggiava con i pulsanti fino a quando un simpatico sospiro le indicava che il vano era pronto ad essere nutrito del suo solito pasto serale. Inseriva il compact e si distendeva sulla poltrona. Prendeva il telecomando in mano e, con inusuale destrezza, portava avanti il contatore delle traccie, fino alla numero 5. In quel punto esatto iniziava uno dei suoi brani preferiti, l’andante del concerto per pianoforte e orchestra di Mozart numero 21.
In quelle sere, in cui la melanconia l’avvinceva per tutte le membra, solleticandone fantasie che il buon profumo delle mani dell’ultimo corteggiatore aveva stimolato, si abbandonava infantile a giochi di pensiero. S’immaginava, come faceva da bambina, principessa solitaria vittima di un malefico incantesimo che, prima o poi, il meraviglioso principe, di qualsiasi colore potesse essere, sarebbe giunto trionfante a cancellare.
Sorrideva di sé e delle sue profonde fragilità, che negli ultimi tempi era riuscita a tramutare in vigore, quel vigore che ne sosteneva il cammino in una lotta senza quartiere. Combatteva contro vento la tormenta che aveva spazzato ogni sorriso in casa, compromettendo l’unica voce della sua vita. L’alter ego che sempre più stremata giaceva pressoché immobile nel suo letto, a pochi metri di distanza. Il suono delle melodie di Mozart cullava la madre dolente, senza riuscire, però, ad alleviarne la fine.
Quando la donna morì, all’improvviso tutta l’oscurità dei suoi 29 anni le piombò addosso, schiacciandole il viso per terra. E non fu un sentire metaforico, ma la sera stessa, in cui con veemenza scacciò tutti i parenti e lo sparuto gruppo d’amici che contava di rimanere ancora lì, quando decise, per la prima volta nella sua vita di rimanere sola, non appena richiuse l’uscio di quella casa, divenuta d’un tratto tomba delle sue memorie, inciampò, come non le accadeva da anni.
Finì distesa per terra lungo il freddo parquet, e lì rimase per tutta la notte, bagnando il legno di lacrime e morsi.
Non furono i raggi del primo mattino a scoprirla sola, così come non era mai accaduto nei giorni precedenti che le luci dell’alba la destassero dal sonno profondo, ma come sempre fu il suono del nuovo giorno a svegliarla.
E il giorno si fece nel frastuono di un martello pneumatico che, senza alcun ritegno, penetrò nella sua mente confusa, richiamandola ad alzarsi.
Anche il più cinico tra gli uomini avrebbe provato un sentimento di commozione se avesse assistito alla scena.
Indolenzita, tanto nell’animo quanto nel corpo, per quella notte in cui sogno e veglia s’alternavano senza sosta, con le esili membra schiacciate nel freddo di un pavimento che aveva perduto la voce e l’odore della madre, Ania provò più volte a rimettersi in sesto.
Nel volgere della notte, l’oscurità che l’aveva abbracciata dalla nascita, verso la quale aveva sempre opposto lo splendore della sua bellezza, parve stringerla, comprimerla.
Conati di vomito risalivano lenti per il collo affusolato che molti avevano sognato di accarezzare con le labbra.
E le labbra stesse bruciavano di un sapore amaro che sapeva di silenzio.
Non appena riuscì a ritrovare l’orientamento si accasciò disperata sulla poltrona.
Diventava sempre più consapevole che non era stata la cecità, inseparabile compagna di vita, a piegarle il respiro gettandola per terra la notte prima, ma l’improvvisa solitudine.
A quella non era in grado di far fronte.
Il viso, che mesi prima decine di riviste s’erano contesi, adesso era devastato. Rigagnoli di lacrime venivano fuori in maniera incessante e affondavano sulla pelle morbida come graffi di gatte in calore. Gli occhi gonfi, lucidi, rossi, avevano completamente nascosto l’aspetto angelico.
Ania non poteva vedersi, eppure vedeva tutto, e in quel tutto, che s’era ridotto a melanconico nulla, non scorgeva modo di rialzarsi.
Rimase seduta sulla poltrona per l’intera giornata.
Il petto florido, a stento contenuto dagli arditi costumi che in serie aveva indossato, rendendoli appetibili alle casalinghe in cerca di frivolezze, si sollevava a stento, in una respirazione discreta.
Talvolta un rigurgito di singulto veniva su, traditore, e allora, sempre senza far rumore, le lacrime ritornavano a solcarle il viso.
Il tempo della sua esistenza era stato scandito dalle voci dei suoi affetti, sopratutto dal timbro delicato e caldo di Sandra, che poche volte aveva chiamato mamma.
Ania e Sandra, due amiche, generazioni differenti che affrontavano l’oscurità del mondo, l’una accanto all’altra. E in quella simbiosi tutto appariva loro più lieve.
Anche nei primi tempi della malattia, quando la madre ancora aveva la forza di sostenere la sua condizione, il sorriso spazzava via, come spugna su vetro, le macchie della sofferenza.
Adesso?
Chi la svegliava al mattino, come un’impettita Rosina?
Chi si crogiolava davanti ai fornelli, vestendo i panni della triste Mimì?
Dov’era il filo di quelle parole, e il canto, la via dei suoi passi?
Silenziata dalla terra ogni cosa.
Non poteva sopportarlo, quel silenzio l’opprimeva più dell’oscurità.
S’alzò, di scatto, e dopo alcuni passi incerti, barcollante, si mosse sicura sul pavimento che non avrebbe mai dovuta tradirla.
Ritornò a vedere, chiaramente.
L’immensa libreria, colma di dischi e libri, che i suoi genitori si alternavano, in maniera quasi frenetica, a leggerle, e poi la cucina, modesta ma dignitosa, senza fronzoli, senza trappole per i passi paffuti di Ania, senza spigoli che avrebbero potuto sfregiare il viso della piccola.
Tutto era morbido in quella abitazione, ogni cosa aveva avuto una voce, anche la mobilia stessa, e le suppellettili. I suoi genitori si divertivano a dare un timbro agli oggetti, era l’unica maniera attraverso cui riuscivano a farglieli vedere.
Ogni corpo una voce, ogni oggetto un suono.
In quel modo Ania aveva creduto di poter vedere Dio, perché ne aveva ascoltato la musica.
E quella blasfema divinità aveva le fattezze grassocce di un bimbo mai cresciuto, oberato dai debiti, incapace di provvedere a se stesso e alle sue voglie, e rispondeva al nome di Amadeus.
Tese le mani verso il terzo ripiano, il rifugio delle malinconie amorose, il sollievo da certe giornate di fatica in cui stanca di aver ascoltato troppe frivolezze, spossata d’aver dovuto riscostruirne i tratti nella sua mente, s’abbandonava al caldo abbraccio della madre, al suo profumo di menta, e insieme si cullavano nella musica.
Iniziò a contare, sentendo che le dita tremavano più del solito.
Un vuoto insostenibile riempiva la sua mente, aveva bisogno della sua musica per contrastarlo.
Prese il cofanetto numero 27.
Con fare meccanico lo aprì, lo inserì nel vano, tastò in cerca del telecomando.
Non trovandolo fu presa dal panico. Probabilmente qualcuno degli ospiti, nella concitata giornata trascorsa, aveva messo le mani dove non doveva.
Un urlo le salì in gola, e non fu capace di trattenerlo.
Non per questo s’arrese. Le era bastata la notte passata sul parquet.
Si mosse con cautela lungo il perimetro della libreria, toccando ogni cosa, assaporandone ogni forma. Avvertì una sensazione particolare, e con la mente andò ai racconti delle amiche e delle loro esperienze, le prime. in cui avevano accolto le mani dei loro ragazzi, mani tremanti, come le sue, in esplorazione, come le sue.
Alla fine riuscì a trovarlo, lo strinse forte a sé.
Esultante.
Si adagiò sulla poltrona, con l’ombra leggera d’un sorriso.
Portò il lettore sulla traccia numero 5.
Schiacciò play, con tutta la vita che aveva in corpo.
Laudate dominum.
Comunque.
E a partire dalle prime battute vide la madre, e ne sentì il fiato sulla bocca, leggero come ogni gesto. La vide camminare per la casa, rovistare tra le stoviglie in cerca del vassoio più adatto per la torta che, golosamente, la piccola Ania avrebbe fatto fuori subito. Seguì i passi della madre, intenta con la bizzarra scopetta a ripulire ogni anfratto da ragnatele e polvere, la inseguì per casa. Entrando nel bagno, e subito dopo aver sentito lo sciabordio dell’acqua, aperta a fiotti per riempir la vasca, sgattaiolare via, cercando di sfuggire al bagno settimanale. Inseguì, la piccola Ania, la madre fin nella camera da letto, tra i morbidi cuscini che respiravano ancora del profumo di Alfonso, e fu lì che lo vide. Alfonso a braccia tese, forti, salde sulla minuta figura, accogliere con un sorriso fragoroso Sandra.
Tese le mani verso il terzo ripiano, il rifugio delle malinconie amorose, il sollievo da certe giornate di fatica in cui stanca di aver ascoltato troppe frivolezze, spossata d’aver dovuto riscostruirne i tratti nella sua mente, s’abbandonava al caldo abbraccio della madre, al suo profumo di menta, e insieme si cullavano nella musica.
Iniziò a contare, sentendo che le dita tremavano più del solito.
Un vuoto insostenibile riempiva la sua mente, aveva bisogno della sua musica per contrastarlo.
Prese il cofanetto numero 27.
Con fare meccanico lo aprì, lo inserì nel vano, tastò in cerca del telecomando.
Non trovandolo fu presa dal panico. Probabilmente qualcuno degli ospiti, nella concitata giornata trascorsa, aveva messo le mani dove non doveva.
Un urlo le salì in gola, e non fu capace di trattenerlo.
Non per questo s’arrese. Le era bastata la notte passata sul parquet.
Si mosse con cautela lungo il perimetro della libreria, toccando ogni cosa, assaporandone ogni forma. Avvertì una sensazione particolare, e con la mente andò ai racconti delle amiche e delle loro esperienze, le prime. in cui avevano accolto le mani dei loro ragazzi, mani tremanti, come le sue, in esplorazione, come le sue.
Alla fine riuscì a trovarlo, lo strinse forte a sé.
Esultante.
Si adagiò sulla poltrona, con l’ombra leggera d’un sorriso.
Portò il lettore sulla traccia numero 5.
Schiacciò play, con tutta la vita che aveva in corpo.
Laudate dominum.
Comunque.
E a partire dalle prime battute vide la madre, e ne sentì il fiato sulla bocca, leggero come ogni gesto. La vide camminare per la casa, rovistare tra le stoviglie in cerca del vassoio più adatto per la torta che, golosamente, la piccola Ania avrebbe fatto fuori subito. Seguì i passi della madre, intenta con la bizzarra scopetta a ripulire ogni anfratto da ragnatele e polvere, la inseguì per casa. Entrando nel bagno, e subito dopo aver sentito lo sciabordio dell’acqua, aperta a fiotti per riempir la vasca, sgattaiolare via, cercando di sfuggire al bagno settimanale. Inseguì, la piccola Ania, la madre fin nella camera da letto, tra i morbidi cuscini che respiravano ancora del profumo di Alfonso, e fu lì che lo vide. Alfonso a braccia tese, forti, salde sulla minuta figura, accogliere con un sorriso fragoroso Sandra.
Finì distesa per terra lungo il freddo parquet, e lì rimase per tutta la notte, bagnando il legno di lacrime e morsi.
Non furono i raggi del primo mattino a scoprirla sola, così come non era mai accaduto nei giorni precedenti che le luci dell’alba la destassero dal sonno profondo, ma come sempre fu il suono del nuovo giorno a svegliarla.
E il giorno si fece nel frastuono di un martello pneumatico che, senza alcun ritegno, penetrò nella sua mente confusa, richiamandola ad alzarsi.
Anche il più cinico tra gli uomini avrebbe provato un sentimento di commozione se avesse assistito alla scena.
Indolenzita, tanto nell’animo quanto nel corpo, per quella notte in cui sogno e veglia s’alternavano senza sosta, con le esili membra schiacciate nel freddo di un pavimento che aveva perduto la voce e l’odore della madre, Ania provò più volte a rimettersi in sesto.
Nel volgere della notte, l’oscurità che l’aveva abbracciata dalla nascita, verso la quale aveva sempre opposto lo splendore della sua bellezza, parve stringerla, comprimerla.
Conati di vomito risalivano lenti per il collo affusolato che molti avevano sognato di accarezzare con le labbra.
E le labbra stesse bruciavano di un sapore amaro che sapeva di silenzio.
Non appena riuscì a ritrovare l’orientamento si accasciò disperata sulla poltrona.
Diventava sempre più consapevole che non era stata la cecità, inseparabile compagna di vita, a piegarle il respiro gettandola per terra la notte prima, ma l’improvvisa solitudine.
A quella non era in grado di far fronte.
Il viso, che mesi prima decine di riviste s’erano contesi, adesso era devastato. Rigagnoli di lacrime venivano fuori in maniera incessante e affondavano sulla pelle morbida come graffi di gatte in calore. Gli occhi gonfi, lucidi, rossi, avevano completamente nascosto l’aspetto angelico.
Ania non poteva vedersi, eppure vedeva tutto, e in quel tutto, che s’era ridotto a melanconico nulla, non scorgeva modo di rialzarsi.
Rimase seduta sulla poltrona per l’intera giornata.
Il petto florido, a stento contenuto dagli arditi costumi che in serie aveva indossato, rendendoli appetibili alle casalinghe in cerca di frivolezze, si sollevava a stento, in una respirazione discreta.
Talvolta un rigurgito di singulto veniva su, traditore, e allora, sempre senza far rumore, le lacrime ritornavano a solcarle il viso.
Il tempo della sua esistenza era stato scandito dalle voci dei suoi affetti, sopratutto dal timbro delicato e caldo di Sandra, che poche volte aveva chiamato mamma.
Ania e Sandra, due amiche, generazioni differenti che affrontavano l’oscurità del mondo, l’una accanto all’altra. E in quella simbiosi tutto appariva loro più lieve.
Anche nei primi tempi della malattia, quando la madre ancora aveva la forza di sostenere la sua condizione, il sorriso spazzava via, come spugna su vetro, le macchie della sofferenza.
Adesso?
Chi la svegliava al mattino, come un’impettita Rosina?
Chi si crogiolava davanti ai fornelli, vestendo i panni della triste Mimì?
Dov’era il filo di quelle parole, e il canto, la via dei suoi passi?
Silenziata dalla terra ogni cosa.
Non poteva sopportarlo, quel silenzio l’opprimeva più dell’oscurità.
S’alzò, di scatto, e dopo alcuni passi incerti, barcollante, si mosse sicura sul pavimento che non avrebbe mai dovuta tradirla.
Ritornò a vedere, chiaramente.
L’immensa libreria, colma di dischi e libri, che i suoi genitori si alternavano, in maniera quasi frenetica, a leggerle, e poi la cucina, modesta ma dignitosa, senza fronzoli, senza trappole per i passi paffuti di Ania, senza spigoli che avrebbero potuto sfregiare il viso della piccola.
Tutto era morbido in quella abitazione, ogni cosa aveva avuto una voce, anche la mobilia stessa, e le suppellettili. I suoi genitori si divertivano a dare un timbro agli oggetti, era l’unica maniera attraverso cui riuscivano a farglieli vedere.
Ogni corpo una voce, ogni oggetto un suono.
In quel modo Ania aveva creduto di poter vedere Dio, perché ne aveva ascoltato la musica.
E quella blasfema divinità aveva le fattezze grassocce di un bimbo mai cresciuto, oberato dai debiti, incapace di provvedere a se stesso e alle sue voglie, e rispondeva al nome di Amadeus.
Tese le mani verso il terzo ripiano, il rifugio delle malinconie amorose, il sollievo da certe giornate di fatica in cui stanca di aver ascoltato troppe frivolezze, spossata d’aver dovuto riscostruirne i tratti nella sua mente, s’abbandonava al caldo abbraccio della madre, al suo profumo di menta, e insieme si cullavano nella musica.
Iniziò a contare, sentendo che le dita tremavano più del solito.
Un vuoto insostenibile riempiva la sua mente, aveva bisogno della sua musica per contrastarlo.
Prese il cofanetto numero 27.
Con fare meccanico lo aprì, lo inserì nel vano, tastò in cerca del telecomando.
Non trovandolo fu presa dal panico. Probabilmente qualcuno degli ospiti, nella concitata giornata trascorsa, aveva messo le mani dove non doveva.
Un urlo le salì in gola, e non fu capace di trattenerlo.
Non per questo s’arrese. Le era bastata la notte passata sul parquet.
Si mosse con cautela lungo il perimetro della libreria, toccando ogni cosa, assaporandone ogni forma. Avvertì una sensazione particolare, e con la mente andò ai racconti delle amiche e delle loro esperienze, le prime. in cui avevano accolto le mani dei loro ragazzi, mani tremanti, come le sue, in esplorazione, come le sue.
Alla fine riuscì a trovarlo, lo strinse forte a sé.
Esultante.
Si adagiò sulla poltrona, con l’ombra leggera d’un sorriso.
Portò il lettore sulla traccia numero 5.
Schiacciò play, con tutta la vita che aveva in corpo.
Laudate dominum.
Comunque.
E a partire dalle prime battute vide la madre, e ne sentì il fiato sulla bocca, leggero come ogni gesto. La vide camminare per la casa, rovistare tra le stoviglie in cerca del vassoio più adatto per la torta che, golosamente, la piccola Ania avrebbe fatto fuori subito. Seguì i passi della madre, intenta con la bizzarra scopetta a ripulire ogni anfratto da ragnatele e polvere, la inseguì per casa. Entrando nel bagno, e subito dopo aver sentito lo sciabordio dell’acqua, aperta a fiotti per riempir la vasca, sgattaiolare via, cercando di sfuggire al bagno settimanale. Inseguì, la piccola Ania, la madre fin nella camera da letto, tra i morbidi cuscini che respiravano ancora del profumo di Alfonso, e fu lì che lo vide. Alfonso a braccia tese, forti, salde sulla minuta figura, accogliere con un sorriso fragoroso Sandra.
CERCA
NEWS
-
18.01.2026
Einaudi
Haiku al femminile -
18.01.2026
Sellerio
Davide Cammarone -
18.01.2026
La naven di Teseo
Christian Raimo
RECENSIONI
-
Luca Giommoni
Nero
-
Matsumoto Seicho
Vangelo nero
-
Dolores Hitchens
La gatta ci ha messo lo zampino.
ATTUALITA'
-
Stefano Torossi
I FRATELLI MARCELLO. Benedetto Marcello 1686 – 1739 Alessandro Marcello 1673 – 1747
-
Stefano Torossi
Carl Maria von Weber 1786 - 1826
-
Stefano Torossi
ARRIGO BOITO 1842 - 1918
CLASSICI
CINEMA E MUSICA
-
Lorenzo Lombardi/Marco Minicangeli
28 anni dopo – Il tempio delle ossa.
-
Marco Minicangeli
La mia famiglia a Taipei
-
Marco Minicangeli
To a Land Unknow
RACCONTI
-
Eugenio Flajani Galli
Ciro e il Miracolo di S. Gennaro
-
Massimo Grisafi
Dondola dondola
-
Luca Alessandrini
Apres la pluie vient le beau temps